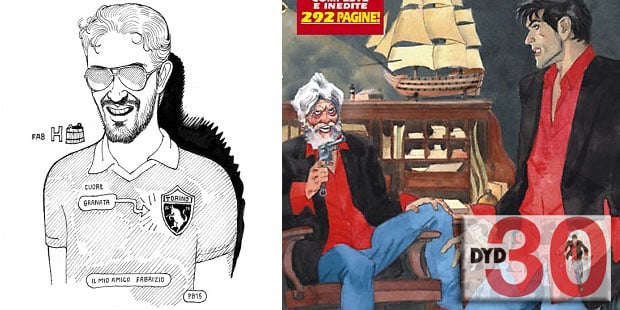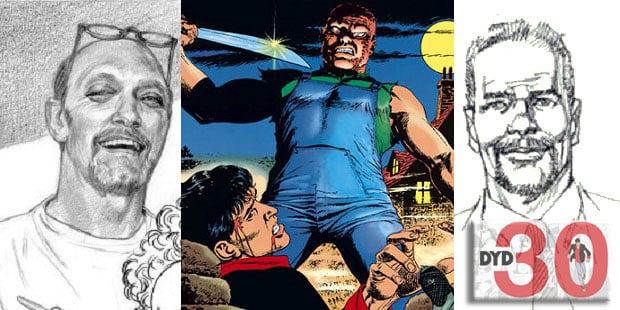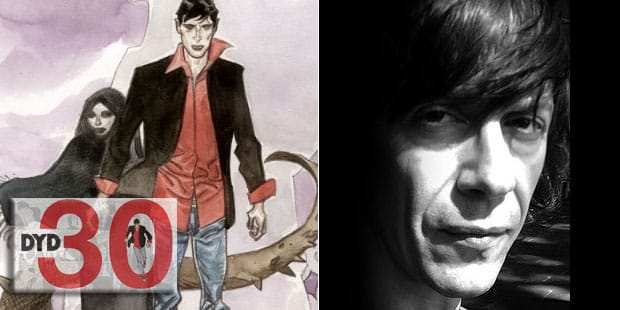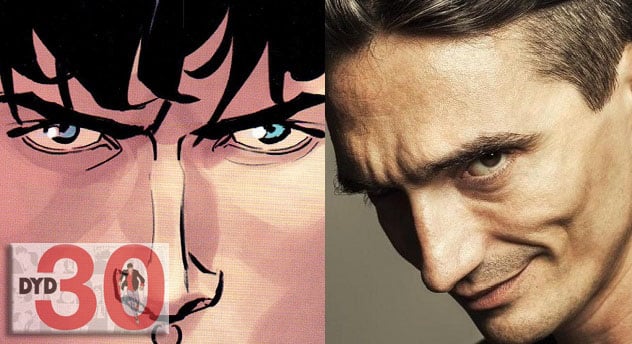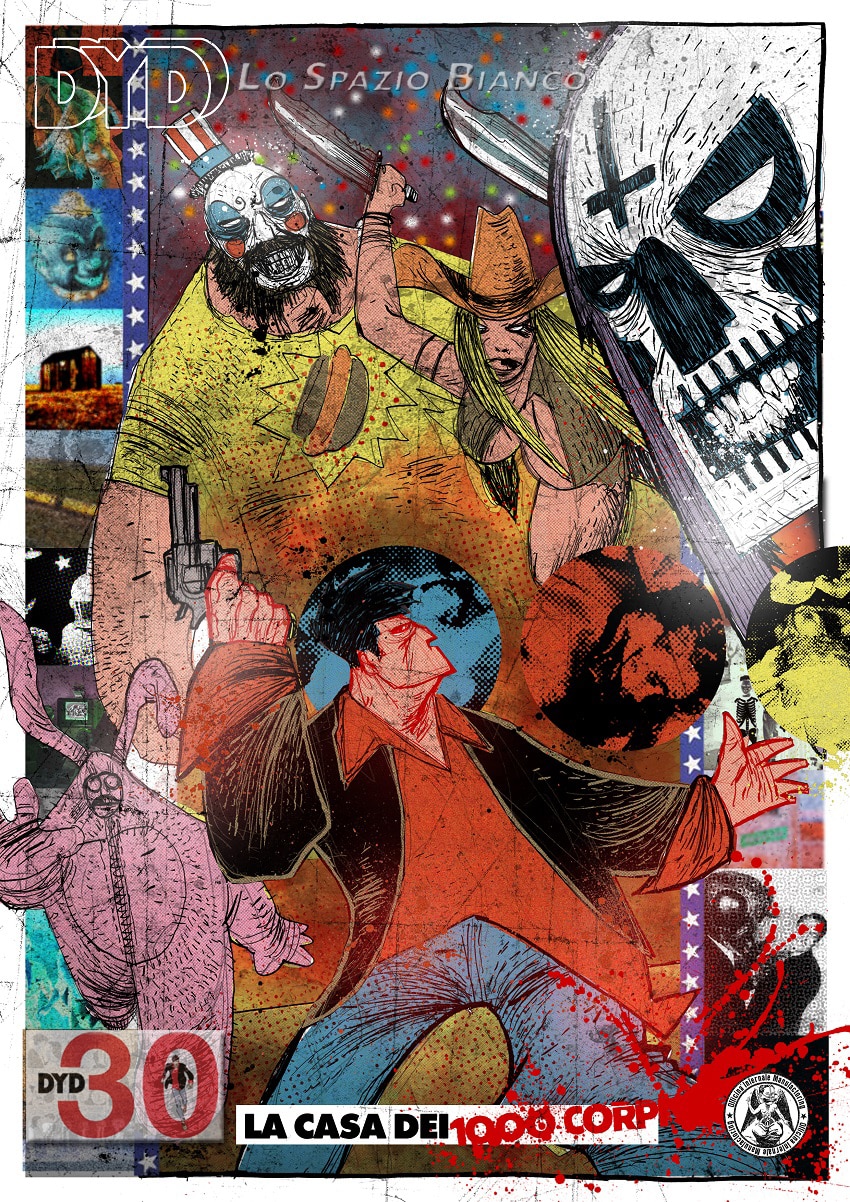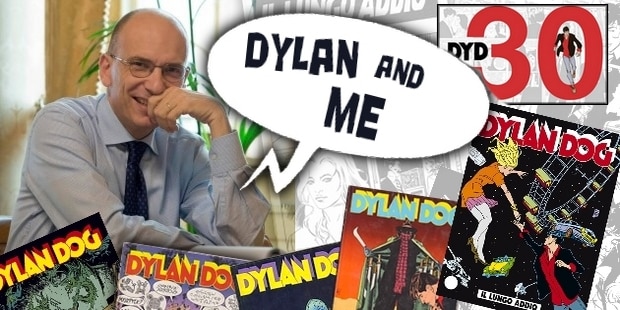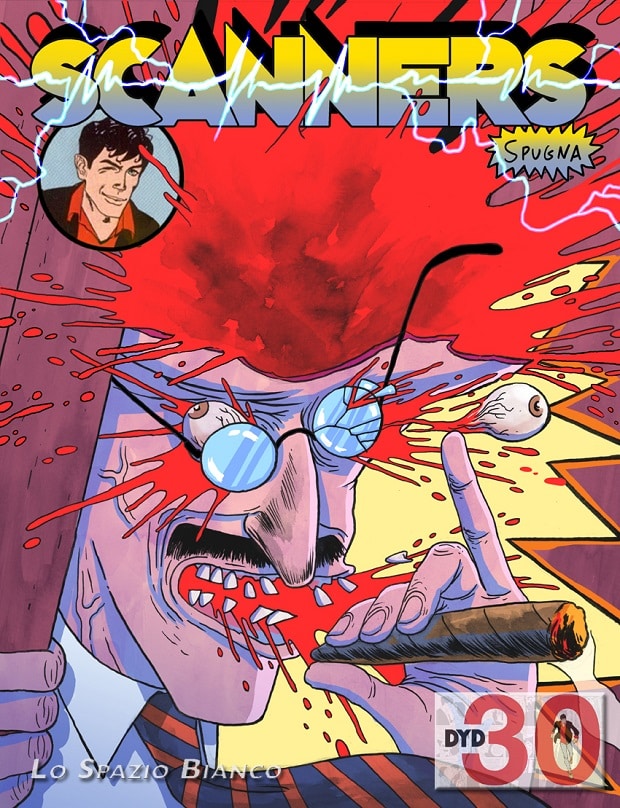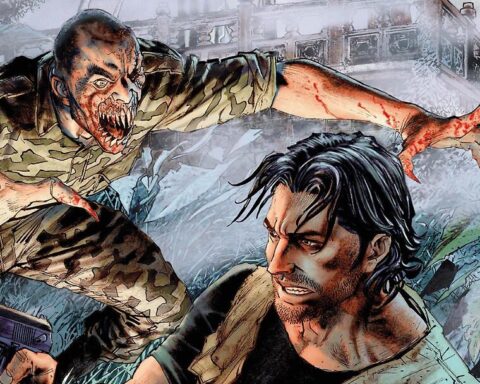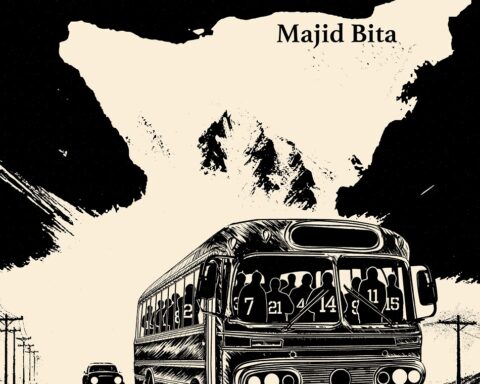Fabrizio Accatino, nato a Torino il 20 dicembre 1971, è giornalista, sceneggiatore, autore di programmi televisivi e radiofonici per Rai e La7. Esordisce nel fumetto a 22 anni entrando nello staff di Dylan Dog, di cui fa parte tuttora. Per Sergio Bonelli Editore ha sceneggiato inoltre quattro albi della collana Le Storie: La pattuglia (2013, disegni di Giampiero Casertano), Il prezzo dell’onore (2015, disegni di Paolo Bacilieri), Le nebbie di Boisbonnard (2016, disegni di Eleonora Dea Nanni) e Illusioni (2016, disegni di Giampiero Wallnofer).
In questa intervista approfondisce con noi il suo approccio alla serie dedicata all’Indagatore dell’incubo e il suo rapporto con la scrittura di Tiziano Sclavi.
A lungo si è pensato a un Dylan Dog indissolubilmente legato a Sclavi. Per te è ancora così nelle “fondamenta” del personaggio? Come ci si muove nell’equilibrio tra ciò che Dylan Dog è nella interpretazione del suo “padre” e quello che di personale un autore cerca sempre di mettere nelle sue opere?
A livello costituzionale Dylan è Tiziano. Al contempo però è un personaggio talmente ricco, sfaccettato, aperto che è in grado di ospitare in maniera convincente anche le visioni di altri autori. Sclavi ha creato il personaggio e gli ha donato le sue caratteristiche fondanti, ma il suo modo di scrivere è e sarà sempre solo suo. Un buon autore deve avere una propria visione del personaggio, e il fatto che inevitabilmente non coincida con quella di Sclavi non la rende necessariamente sbagliata. Pretendere che vengano riproposti all’infinito i cliché stilistici del Dylan delle origini è assurdo. Se lo sforzo degli autori che si sono succeduti a Stan Lee ai testi dell’Uomo Ragno fosse stato quello di scimmiottare l’illustre predecessore invece di cercare una propria via al personaggio, non avremmo avuto lo Spider-Man di Gerry Conway, di Peter David, di J. M. DeMatteis. Come Topolino è riuscito a fare a meno di Walt Disney e Ub Iwerks, e Lucky Luke è sopravvissuto a Morris e Goscinny, lo stesso farà Dylan Dog con Sclavi.
Dylan Dog è stato un fenomeno artistico, editoriale e sociale. Nel suo periodo di maggiore successo è stato protagonista di pubblicità, merchandising, ha generato bizzarri epigoni, è stato ospite di riviste a larga diffusione. Sembrava che tutti leggessero Dylan Dog. Come ci si approccia a un personaggio e a un fenomeno del genere senza esserne schiacciati? Fa paura scrivere Dylan Dog?
Beh, certo la storia editoriale di Dylan Dog un po’ di soggezione la mette. A metà anni Novanta la testata vendeva circa 600.000 copie e riceveva una decina di lettere al giorno dai lettori, quindi quasi 300 al mese, con un redattore fisso che passava le giornate a rispondere a tutte. Un qualcosa di impensabile, oggi. Chi non ha vissuto quel periodo glorioso non può capire cos’è stato Dylan Dog per la cosiddetta Generazione X. Però parlare di paura è troppo. Se davvero ne avessimo, faremmo meglio a cambiare lavoro. Dylan è un personaggio che funziona solo se chi lo scrive si diverte, si lascia andare, prova, sperimenta, osa. Non lo si può scrivere con il freno a mano tirato, senza una vera urgenza narrativa. Dylan Dog è in assoluto la testata Bonelli che non si può scrivere solo di mestiere, con furbizia, facendo il compitino, perché il lettore è particolarmente esigente e ti becca subito. Ecco, più che il passato editoriale è la severità del lettore di Dylan Dog a creare un po’ di pressione psicologica. Ma come insegnava un vecchio amico rosso e blu, da grandi poteri derivano grandi responsabilità.
Qual è l’idea centrale del “tuo” Dylan Dog e cosa lo rende immediatamente riconoscibile e unico?

Sei entrato nel team di sceneggiatori della serie diversi anni fa. Come è cambiato da allora a oggi il tuo approccio e la tua interpretazione del personaggio e delle tue storie? Come è maturato il tuo modo di scrivere Dylan Dog e farlo come ti ha influenzato negli altri tuoi lavori?

Hai narrato in alcune interviste che le tue prime sceneggiature rimasero a lungo nei cassetti di via Buonarroti, prima che la tua storia vedesse finalmente la luce. Che cosa ti ha insegnato questa lunga gavetta?
Che se non credi in quello che stai scrivendo non ci crederà nemmeno il lettore quando l’albo uscirà. Che per sceneggiare occorre un’attenta regia e che non basta piazzare un primo piano lì e un piano d’insieme là per fare storytelling. Che puntando solo sullo stile e sulle atmosfere senza avere sotto una storia ben strutturata non vai da nessuna parte. Che i dialoghi lunghi o ingessati rompono le palle al lettore. Che se per spiegare una scena sei costretto a ricorrere ai balloon di pensiero non è una buona scena. Che puoi scrivere la storia più bella del mondo ma senza un buon disegnatore nessuno dirà mai che è la storia più bella del mondo.

C’è qualcosa che cambieresti in Dylan Dog e qualcosa a cui non rinunceresti mai?
Dylan ha quell’equilibrio miracoloso che hanno i personaggi perfetti. Se a Sherlock Holmes togliessimo la pipa e mettessimo il sigaro perderebbe qualcosa. Come i film perfetti sono perfetti in tutto, ogni singola inquadratura, ogni singolo taglio di montaggio, ogni scelta di luce, ogni comparsa che passa per pochi secondi sullo sfondo, così è per il personaggio di Sclavi. È questo che l’ha reso unico, universale, immortale. Un elemento dylaniato a cui proprio non rinuncerei mai? L’ironia. Dylan senza l’ironia è come Druuna senza le tette.
Che ruolo ha avuto Dylan Dog nella tua vita?
È stato il fratello maggiore, negli anni diventato fratello minore. È stato l’esempio da seguire, un modello di stile e di etica. L’altrove mentale in cui rifugiarsi di fronte all’orrore, alla noia, alla banalità della vita quotidiana. Dylan è poesia. Tutto quello che ho imparato della vita, del senso profondo delle cose lo devo a lui.
Dylan è sempre stato un personaggio con una forte aderenza al sociale, le sue storie spesso si sono fatte carico di messaggi sui diritti, l’uguaglianza, la pace, il rispetto per gli animali… Questo pone l’attenzione sul tema della responsabilità dell’autore nei confronti delle sue opere. Cosa significa per te questo tema, in particolare per Dylan Dog?

Rendere l’orrore è difficile. La paura, l’irrazionale. Ci sono tante sfumature del genere in Dylan, commistioni. Lo stesso genere è cambiato molto dagli anni ’90 a oggi. Cosa significa scrivere un fumetto horror oggi? Come evolve Dylan Dog in questo?
L’orrore è in assoluto il genere narrativo che più ha patito il trascorrere degli anni. Lo storico, il fantasy, il western, la fantascienza sono generi congelati in una bolla fuori del tempo, l’horror invece è contemporaneo e deve misurarsi con i cambiamenti della società. Deve quindi fare i conti con il cinismo, l’assuefazione, l’inaridimento del mondo contemporaneo. Se al telegiornale passano servizi su donne bruciate con l’acido o poveracci arsi vivi davanti alle telecamere, che cosa può ancora inventarsi uno sceneggiatore di storie dell’orrore? Da questa difficoltà è nato il torture porno, un sottogenere che odio, perché inflattivo e ricattatorio nei confronti dello spettatore. Dylan sta patendo in prima persona le difficoltà del genere horror, ma la risposta non può essere (anche per banali motivi editoriali) spingere il pedale sulle efferatezze. Ancora oggi l’orrore continua ad annidarsi dentro di noi e lì dobbiamo cercarlo. Spostare la ricerca all’esterno significa perdere la battaglia con le nostre paure e con il personaggio che stiamo scrivendo.
Intervista condotta via mail nel mese di settembre 2016.