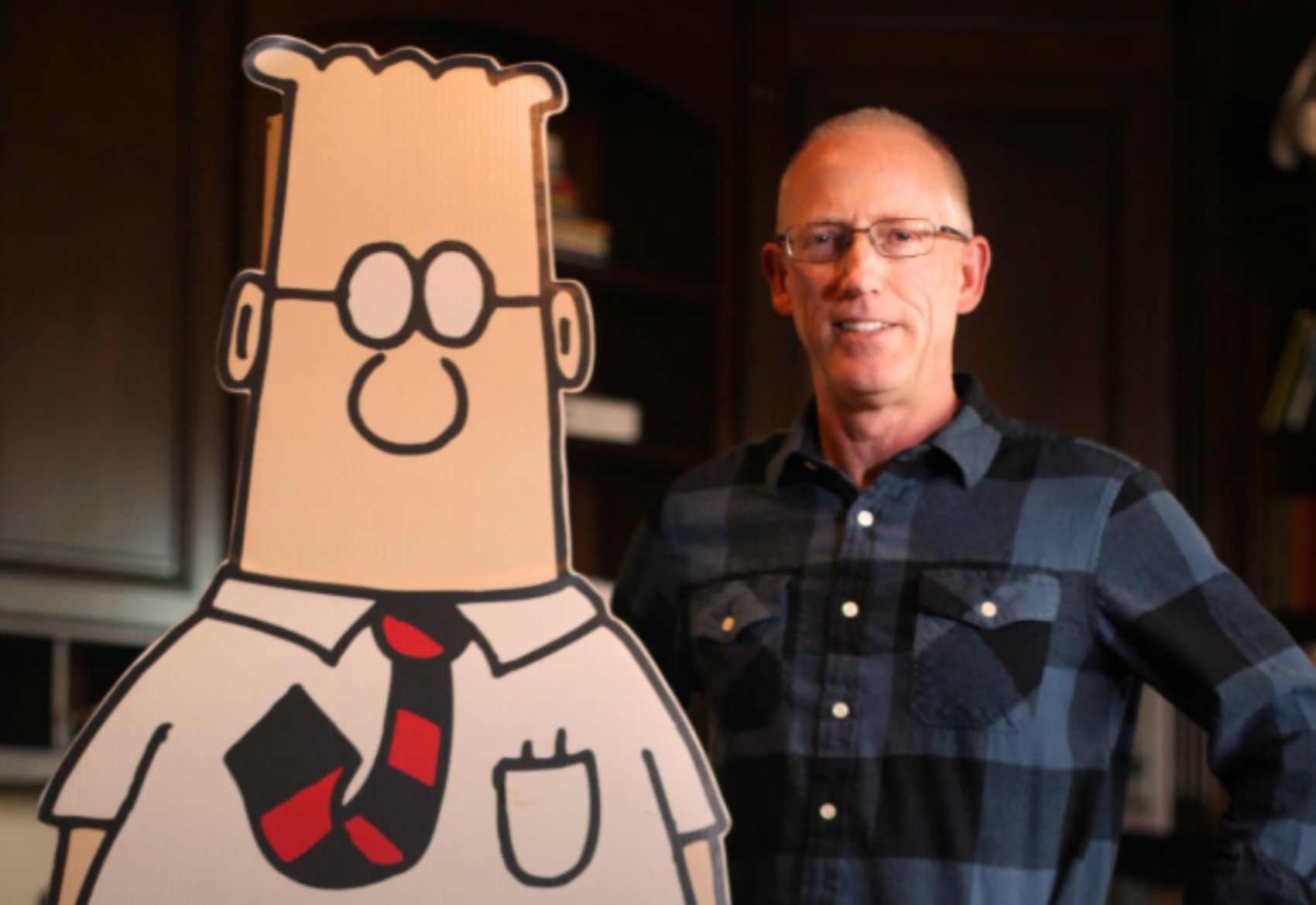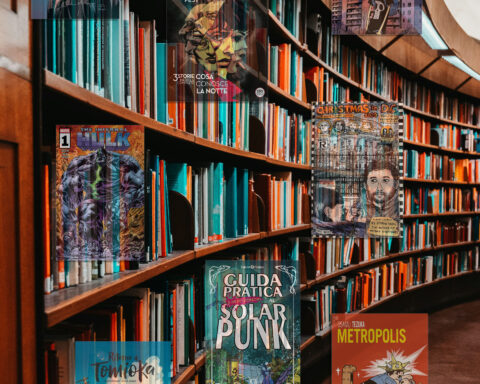Abbiamo incontrato a Berlino Alberto Madrigal che, in occasione della pubblicazione di Dovevo dirti una cosa per Bao Publishing, ci ha concesso una lunga intervista. Alberto ci ha parlato della genesi dell’opera e delle sue molte vite – tra Berlino, Spagna e Italia, tra l´essere padre e il lavoro di fumettista. Ecco cosa ci ha raccontato.

Alberto, Benvenuto sullo Spazio Bianco! Come scritto sulla tua bio in quarta di copertina, “Alberto Madrigal, nato in Spagna, residente a Berlino dal 2007.” La prima domanda è: dove sei nato di preciso, perchè questo generico “Spagna”?
Sono nato a Plasencia, che è una piccola città in Estremadura, una regione accanto al Portogallo. Però ho sempre vissuto vicino a Valladolid, in un paesino piccolo che sarebbe in Castilla y León, la regione sopra Madrid.
Quindi la vera domanda è: perché nato in Spagna senza specificare Plasencia o Estremadura, mentre Berlino è specificato rispetto alla Germania? È un dettaglio, ma menzionare il Paese o specificare la città magari indica un rapporto differente con questi luoghi. Anche nelle tue opere il tuo essere spagnolo passa in secondo piano: la Spagna non viene mai raccontata, mentre è molto più evidente lo stretto legame dei personaggi con le città, spesso Berlino, ma anche Roma o Milano, come nel tuo ultimo lavoro.
Vorrei partire chiedendoti il tuo rapporto con questi Paesi e queste città, con la Spagna, con l’Italia e con Berlino. Dato che ci troviamo a Berlino partirei proprio da qui: cos’è Berlino per te, cos’era e se, dal 2007 a oggi, qualcosa è cambiato.
Allora, io sono arrivato in Germania perché la mia fidanzata di allora faceva un Erasmus vicino ad Amburgo. Io già volevo fare i fumetti, quindi ho lasciato il lavoro di informatico che avevo in Spagna e ho detto “vengo con te, tu fai l’università e io studio i fumetti.” Narrativa, prospettiva, anatomia, tutte queste cose… Poi lei è tornata in España e io ho deciso di venire a Berlino perché eravamo stati un paio di giorni e mi era piaciuta molto.
Lì è iniziato il periodo berlinese. Mi piaceva molto la libertà che c’era. Libertà nel senso: in Spagna non avevo mai visto nessuno che disegnasse e se io mi mettevo per strada a disegnare, mi dicevano “ma che fai? Ma sei uno sfigato, che stai facendo?”. Erano altri tempi poi, non c’era Instagram, tutte queste cose…
A Berlino invece mi sono reso conto che non fregava niente a nessuno di cosa facessi. In Spagna sentivo un po’ il peso del lavoro che fai, di quello che vuoi fare. Io volevo fare i fumetti ma non erano considerati un lavoro. Per questo avevo studiato informatica, avevo seguito quel percorso tanto per. Mi piaceva, ma era più per comodità, diciamo.
Qua invece non sentivo quel peso, potevo fare un po’ quello che volevo, i fumetti, senza dover spiegare niente a nessuno.
Berlino è cambiata? Beh sì, è cambiata molto. Intanto i prezzi sono triplicati, il che rende tutto più difficile. Effettivamente all’epoca ricordo di aver venduto la macchina che avevo comprato lavorando in Spagna, dato che a Berlino non serve guidare. Con i soldi della macchina a Berlino ci ho campato più di un anno, forse due. Si viveva con molto poco. Poi avevo trovato un lavoro in una ditta di videogiochi e lì guadagnavo molto bene, mentre in Spagna si guadagnava molto poco.
Erano due mondi differenti. Qui all’epoca si stava molto molto bene e lì in Spagna era molto più difficile viverci. Poi Berlino si é gentrificata, però è una cosa che si sapeva sarebbe successo. Non poteva rimanere così, era troppo assurdo, era troppo diversa dalle altre capitali europee. Poi in realtà anche la mia vita è cambiata molto: ho fatto due figli!

Pensavo: dici “a Berlino a nessuno importa niente di quello che fai”. Quello forse è ancora rimasto, ancora si respira.
Quello c’è, quello c’è.
Però c’è anche un lato oscuro, ovvero non gli importa niente perché… non gli importa niente. Semplicemente si viene ignorati.
Sì, è vero. Infatti io ho trovato negli italiani quello che a me mancava qua, essendo spagnolo. Sentivo il peso delle differenze culturali. All’inizio volevo stare solo con i tedeschi, poi dopo un po’ mi sono arreso.
Non ho cercato gli spagnoli perché ho conosciuto mia moglie che è della provincia di Roma, mi sono trovato molto bene subito. Poi ho avuto delle amicizie italiane e ho trovato quello che mi mancava da spagnolo vivendo a Berlino… però è anche un po’ diverso. Quell’essere ignorati dai Berlinesi, che è liberatorio ma è anche un peso, l’ho bilanciato con la comunità italiana. É come se avessi tre vite, quella a Berlino, quella in España e quella in Italia.
Qual è il tuo rapporto con l’Italia? Come nasce?
Io lavoro per l’Italia, ho tanti amici lì. Poi anche per i festival, viaggio molto in Italia. Se non ci fosse quello ne soffrirei sicuramente e sarebbe più pesante stare in Germania.
La mia vita italiana nasce con mia moglie. Una volta conosciuta lei ho cominciato ad avere subito tanti amici italiani. Quindi andavo spesso in Italia, poi la lingua l’ho imparata molto più facilmente del tedesco, quindi potevo anche proporre dei progetti nelle fiere di fumetto. È cominciata cosí.
Poi il mio primo libro l’ho scritto in italiano. Scrivo tutto in italiano.
Anche questo è curioso: come mai non scrivi nella tua madrelingua?
È iniziato tutto col primo libro, Un lavoro vero (2014), che è autobiografico. Parla dell’arrivo a Berlino e del voler fare fumetti. Quando ho scritto quel libro raccontavo gli argomenti di cui parlavo tutti i giorni con i miei amici italiani, quindi automaticamente le parole mi venivano in italiano. Poi, siccome non padroneggiavo la lingua, ero costretto a usare delle frasi semplici. E questo mi ha aiutato molto perché se lo avessi scritto in spagnolo avrei fatto dei giri di parole per ogni concetto. Quindi mi ha aiutato a semplificare e ridurre all’osso la storia.

Questo dialogo “semplificato”, o più naturale se vogliamo, lo hai reso anche un po’ una tua forza ma magari ci arriviamo dopo. Quindi Berlino, Italia… Invece la Spagna come mai non compare nei tuoi lavori?
Mah, non saprei. È come se, essendo una cosa che conosco – anche se ormai la metà della mia vita è fuori dalla Spagna – ormai mi è familiare, quindi non mi incuriosisce così tanto. Non ho quella voglia di raccontare qualcosa. Probabilmente è una cosa che con una crisi dei cinquant’anni potrebbe cambiare. Per ora è stato sempre così. Sicuramente è anche legato al fatto che la mia vita da fumettista è iniziata con l’Italia e Berlino. Inizialmente volevo solo disegnare fumetti, non mi interessavano le storie, il colorare… E quando ho iniziato a scrivere è stato tutto legato, fin dall’inizio, con l’Italia, mai con la Spagna.
La “scusa” per questa intervista è la pubblicazione del tuo nuovo fumetto, Dovevo dirti una cosa, pubblicato per Bao Publishing. Partirei con una domanda ampia: ce ne vuoi parlare? Come nasce questo tuo lavoro, di cosa parla e cosa significa per te?
È un libro a cui tengo molto. Questo e Va Tutto Bene (2015), non sono autobiografici. Dovevo dirti una cosa è più lontano da me, almeno in partenza. Ci ho messo tutte quelle cose che mi incuriosiscono, o che magari vorrei capire e non capisco. Però non parte da un’esperienza propria. L’ho iniziato a scrivere nove anni fa. In Pigiama Computer Biscotti (2019), in cui racconto della nascita di mio figlio, si accenna spesso al fatto che sto scrivendo un nuovo libro. Era Dovevo dirti una cosa.
Foreshadowing!
Ahah Esatto! L’ho iniziato a scrivere perché in quel periodo tante delle coppie di amici, coppie stabili che stavano insieme da tanti anni, hanno iniziato a lasciarsi. Ed è diventato una sorta di virus, quando una coppia si lascia è come se mettesse in crisi tutte le altre vicine.
Che è normale se ci pensi, no? É un’età in cui è facile farsi delle domande.

Appena fuori l’adolescenza, anche se ormai non si è più adolescenti solo dopo i 30, si è spostata in avanti.
Ah, si è vero! Quindi ho iniziato a scrivere per capire perché queste persone arrivavano a quella scelta, coppie che all’esterno sembravano perfette tra di loro. Anche perché se chiedevi a ognuno di loro separatamente, nessuno ti diceva il vero motivo della separazione. Nemmeno loro lo sapevano e nemmeno c’era un solo motivo, ovviamente, ma più di uno. Mi incuriosiva molto questo: provare a raccontare una coppia che apparentemente sta bene, anche se poi cominciano a esserci dei dettagli che la fanno arrivare alla rottura. Solo che quando ho iniziato a scrivere ho pensato, “che palle, so già come finirà.” E quindi ho iniziato subito dalla crisi. E da lì mi sono lasciato andare e sono diventato il mio primo lettore. Non sapevo dove sarei arrivato.
I tuoi personaggi sono sempre molto concreti – in inglese direi relatable. Il lettore li conosce velocemente, si capisce subito chi sono o almeno la situazione che stanno vivendo. Sono personaggi “veri”: con le loro forze, le loro debolezze, le loro qualità ma anche le loro meschinità. Penso ad esempio al personaggio di Pietro, inizialmente affascinante, anche seducente. Qualcuno che vive “seguendo le sue regole”, ma che poi, improvvisamente, si rivela più negativamente, non tanto meschino quanto scontato e banale nelle sue mire. Che personaggio è questo Pietro?
In realtà inizialmente erano tre personaggi principali, Pietro, Angela e Roberto, e io raccontavo ogni capitolo dal punto di vista di ognuno di loro. È solo che poi il libro sarebbe stato il doppio, quindi ho dovuto ridurre e raccontare solo i punti di vista degli altri due. Però un po’ mi dispiace. Pietro era molto più complesso nella versione iniziale. La cosa bella, quello che volevo fare, iniziava come lo hai descritto tu, però a un certo punto capivi perché era così. Sai come quando si racconta il cattivo di un romanzo, di un film? E poi ti rendi conto che non ci sono buoni e cattivi, ci sono solo quelli che fanno delle scelte in accordo ai loro traumi, al loro vissuto… scelte che per loro sono giuste.
Questa cosa mi interessava molto. Poi però, siccome ho dovuto toglierlo per una questione pratica, ho messo questa idea un po’ su Roberto, che all’inizio al lettore tende a stare più antipatico. La mia idea era che, lungo la storia, il lettore avrebbe capito anche Pietro. Ho dovuto ridurre la parte dedicata a lui, e mi dispiace perché Pietro è rimasto più banale. Non raccontando il suo punto di vista non lo puoi capire. Però allo stesso tempo è rimasta l’idea di questa persona che ha una vita, come dici tu, seducente, che fa delle scelte che un po’, in fondo, tanti di noi vorrebbero anche fare, e non fanno per paura o per avere una stabilità o delle sicurezze… Non sto dando un giudizio. Non voglio dire che se fai quelle scelte poi ti andrà male, però mi piaceva questo fascino dall’esterno e il fatto che non è tutto sempre così bello come sembra.

Anticipo una domanda che avrei fatto più avanti dato che ne stiamo parlando: uno dei temi del fumetto è quello del lasciarsi. Il lasciarsi in una coppia, ma anche il lasciar perdere, il lasciarsi tutto alle spalle. Roberto con il lavoro, Angela con le sue relazioni con Roberto e con i genitori. Mandare tutto a “fanculo” per usare un francesismo. Ha qualcosa di seducente, che è quello che dicevamo di Pietro. Hakuna Matata, vivere senza pensieri, senza responsabilità. Anche senza rapporti, da isola. Da filosofo mi viene in mente Kierkegaard, il contrasto tra vita Etica e Estetica… senza spingersi fino lì, ti chiedo: come vivi tu, da persona sposata, con due figli, in una vita impegnata e impegnativa, questa seduzione?
É difficile… come dici tu, quando hai dei figli hai subito delle responsabilità di cui non puoi, e non vuoi, liberarti. Devi confrontarti con quelle responsabilità. Soprattutto nei primi anni, soprattutto quando sono molto piccoli, hai delle emozioni molto contrastanti. A volte ti sembra che è la cosa più bella del mondo e non capisci come qualcuno possa vivere senza di quello, e a volte invidi chi non ce l’ha, chi ha quella libertà di scegliere in ogni momento cosa fare con la sua giornata. È un continuo disequilibrio di queste emozioni.
Io comunque sono tendenzialmente ottimista, quindi tendo sempre a vedere il lato buono di queste cose. Mi rendo conto che tutte quelle costrizioni che ha l’essere genitore, hanno anche una svolta positiva. Per esempio sul lavoro, prima di avere figli potevo lavorare tutto il giorno, tutta la notte e mi piaceva. Però questa cosa è diventata anche una trappola, perché non vivevo, mi perdevo il resto delle cose. Anche se in quel momento mi piaceva, a lungo termine non mi faceva stare bene. Essere costretto a lavorare meno mi fa bene. Negli ultimi anni lavoro praticamente solo la mattina, poi il pomeriggio sto con loro. Faccio più cose di vita familiare. All’inizio questa cosa mi dava molta tristezza, mi dispiaceva. Anche perché, lavorando con i fumetti, ti senti sempre di dover lavorare di più. Però allo stesso tempo il dire “ok solo la mattina,” mi costringeva a prendere il lavoro in modo diverso. Con il tempo mi rendo conto che mi ha fatto bene. Se lavoravo meno ore stavo meglio e avevo più voglia di riprendere il giorno dopo. La cosa assurda è che riuscivo a fare la stessa quantità di lavoro in quelle ore.
Quindi per rispondere alla tua domanda: sì è vero, ci sono tante costrizioni, e a volte è molto difficile, ancora oggi che i miei figli sono più grandi, 6 e 9 anni. Però è pure vero che mi costringono a fare delle cose che alla lunga mi rendono piú felice. Devi solo uscire dal loop del lamentarsi, e dire “ok queste sono le carte, io posso fare questo, che cosa faccio e in che modo?” Quindi riuscire a prendere il meglio.
Quando diventi genitore – una cosa banale che si dice spesso, però è vera – c’è una marcia in più. È come se togliessi tutte le cose inutili, e andassi direttamente alle cose importanti. Per tornare all’esempio di prima, quando io lavoravo tutto il giorno, in realtà magari tre ore intere stavo a cazzeggiare su internet, su Instagram… senti che stai lavorando, ma non stai lavorando, e ti prosciuga, ti toglie l’energia.

Parlando di essere padre, parlando di figli, a questo punto ti domanderei del personaggio dello scrittore. Non voglio fare spoiler, ma lo scrittore è anche un padre, è un personaggio che si fa un po’ carico di quelle che sono le ansie, le paure di un genitore. Ci mostra un rapporto difficile con i figli e anche un po’ queste due emozioni che hai descritto, la bellezza dell’essere genitore ma anche la difficoltà del mantenere una propria identità che va oltre l’essere genitore, non necessariamente solo lavorativa, ma di realizzazione personale. Che personaggio è lo scrittore? Come nasce?
Lo scrittore nasce perché io leggo tanti saggi sulla scrittura, mi piace proprio tanto. Mi piacciono da quando ho iniziato a scrivere questo libro. Siccome volevo scrivere una trama un po’ più complessa di quelle precedenti, ho letto tanti libri sulla scrittura, sceneggiatura, eccetera. Quindi mi sono appassionato all’argomento. Con lo scrittore volevo inseguire una mia curiosità e metterla nella storia.
Una prima curiosità era questa delle coppie che erano in crisi, un qualcosa che io volevo capire dentro. La seconda curiosità era su qualcosa che mi piaceva, mi divertiva: la scrittura appunto. In particolare nasce perché avevo letto un libro su… non mi ricordo l’autore, però è una sorta di intervista a Lee Child, che è lo scrittore di Jack Reacher.
La cosa assurda è che io non ho letto nessun libro della serie di Jack Reacher, che è molto famoso, ci sono anche dei film. Però a me piace molto Lee Child: lo conosco attraverso incontri e interviste nelle quali parla del suo mestiere. E c’è un libro in cui un giornalista va da lui, e dice “ok, tu scrivi. Io ti osservo e scrivo un libro su come tu scrivi un libro.” E questa cosa mi è piaciuta tantissimo e infatti ho inserito qualcosa di simile in Dovevo dirti una cosa. Lo scrittore era una scusa per parlare di quel mondo là, però mi serviva anche un motivo per collegarlo al resto della trama. E lì nasce quello che hai letto.
Era anche un modo di esplorare quello di cui parlavamo prima, uno scrittore che si dedica completamente al lavoro. Qualcosa che magari avrei fatto io se non ci fosse stato qualcosa di esterno, come può essere un figlio, una famiglia o una relazione con un’altra persona, a portarmi in una direzione differente.

Una domanda che tengo molto a farti, anche se più che una domanda è una riflessione. La sensazione che ho, leggendo i tuoi lavori, è che spesso la trama passi quasi in secondo piano rispetto all’atmosfera, alle situazioni. Questo probabilmente è anche dovuto alla tua arte molto riconoscibile e peculiare, agli acquerelli, al modo in cui disegni e dipingi – letteralmente e metaforicamente – un frangente della vita dei tuoi personaggi, che diventano immediatamente familiari. Abbiamo accennato alla semplicità dei dialoghi, che appaiono ordinari, da vita di tutti i giorni, ma proprio per questo aiutano a relazionarsi velocemente con i personaggi. Penso alle pause silenziose, alle città sullo sfondo immediatamente riconoscibili. In una puntata del tuo blog un tuo amico sceneggiatore definisce questo tuo modo di costruire una storia come un “racconto femminile”. Niente “journey” dell’eroe, ma emozioni. Non voglio dire che la storia sia di minore importanza, quanto che la forza dei tuoi lavori, ciò che permette anche al lettore di rispecchiarvisi, sia piuttosto nella tua capacità di delineare in pochissime vignette una situazione, una vita che ci sembra di conoscere, una realtà ordinaria, ma proprio per questo immediatamente riconoscibile, anche empaticamente. Per certi aspetti quasi banale. Penso qui all’urlo di Angela: “Cazzo, mi sento così banale,” che è un sentimento che può capitare di sentire di tanto in tanto, magari quando litighiamo in coppia, nella vita comune con i figli, ma anche al lavoro, nella routine. Che ne pensi?
È bello questo che hai detto. Hai toccato molti temi.
Riguardo alla trama, io negli anni mi sono chiesto perché alcune storie, fumetti, romanzi o film, mi intrattengono. Lì per lì non posso smettere di leggerle o di guardarle, ma poi il giorno dopo me le scordo, non mi toccano per niente. Perché altre storie, invece, sono noiose ma mi rimangono dentro? La risposta a cui sono arrivato è che ci sono due elementi in una storia che devono funzionare: il primo è che ti devi intrattenere, il secondo è che ti deve parlare di qualcosa di profondo.
I libri che ho fatto prima di questo li facevo di getto, mi lasciavo molto andare e mi rendevo conto che non parlavano tanto. Non c’era una trama, o se c’era era molto – come dici tu – in secondo piano. Tutto era guidato dall’emozione, dalla vita interiore dei personaggi. Quando invece ho scritto Dovevo dirti una cosa, avevo già due figli. Quando arrivavo a fine giornata avevo il mio tempo per leggere un libro, per rilassarmi, non avevo né tempo né energia per leggere qualcosa di bello ma lento e un po’ noioso. Quindi ho pensato che avrei voluto scrivere il libro che mi sarebbe piaciuto leggere. Volevo un libro che fin dalla prima pagina facesse venir voglia di continuare. Qui l’obiettivo principale era che intrattenesse. Poi, però, non volevo rinunciare al secondo elemento, cioè il fatto che toccasse delle corde emotive per cui rimanesse impresso. Non volevo scrivere un libro che ti scordi il giorno dopo. Se sono riuscito a farlo o no non lo so, però ho provato proprio a unire quelle due cose.
Un esempio di un autore che fa questo benissimo è Zerocalcare. Tu magari non hai voglia di leggere, sei stanco, però ti prendi un libro suo, cominci e non puoi smettere. Per me almeno è cosí. Ti intrattiene, ti fa ridere, ti fa rilassare e dimenticare se hai i tuoi problemi. Dopo un po’ ti rendi conto che hai letto mezzo libro e ti sta pure parlando di cose pesantissime, ma ormai sei dentro, ti ha preso la mano e ti ha fregato. Questa è una cosa che io ammiro tantissimo, quindi volevo provare a fare quello.
Un’altra cosa che credo faccia sentire familiari i personaggi sono i miei disegni, molto semplici. Come succede per esempio su WhatsApp quando usi gli emoji, faccine in cui tutti ci riconosciamo. Mentre se metti, invece di una faccina felice, una foto di una persona felice non ti riconosci più. Con i disegni succede una cosa simile, se hai uno stile di disegno realistico e non assomigli a quel personaggio, quest’ultimo è lontano da te, se invece lo stile di disegno è più come nel manga – non so come chiamarlo, più semplice, più generico – è più facile immedesimarsi. È una scelta inconscia, e mi succede anche perché i disegnatori che fanno disegni più semplici, mi toccano di più e quindi provo ad andare in quella direzione.
Gipi, per esempio, sa disegnare benissimo però tanti dei fumetti suoi che mi toccano profondamente hanno dei disegni “fatti male”, come La mia vita disegnata male (2008). Sono molto semplici e hanno anche dei “difetti”, diciamo, che però diventano punti di forza. Quando finisco di leggere un suo libro, ne vorrei più e solo lui me lo può dare. Non c’è un’altra persona uguale a lui con gli stessi “errori”.
Gipi mi ha cambiato la vita. Io non lo conoscevo, arrivavo in fumetteria, aprivo il libro e non mi piacevano i disegni. Poi invece ho preso S (2006) e ho iniziato a leggere… dopo cinque/sei pagine ero già dentro. Ero innamorato del disegno. Sono arrivato alla fine e ne volevo più e solo lui me lo poteva dare. Questa cosa mi ha veramente cambiato la vita e mi ha fatto venire voglia di scrivere (prima di quel momento volevo solo disegnare). Un altro esempio é Zerocalcare che non disegna i gomiti, no? Il braccio del personaggio è “mollo” dove dovrebbe esserci il gomito. Anche quello in realtà dopo un po’ diventa un punto di forza, un tratto distintivo.
Questo per quanto riguarda la questione stilistica. Il fatto del racconto femminile… questo mio amico, Giovanni di Gregorio che lavora come sceneggiatore per Bonelli e ora ha fatto una serie con Barbucci, mi aveva detto una volta che ci sono diverse modalità di racconto. Quella diciamo “maschile” è quella del viaggio dell’eroe con le sue regole, eccetera, e quella” femminile” è quella che è più centrata sull’emozione dei personaggi, che era quello di cui parlavamo prima.
Brevemente su questo frangente, c’è una scena, il momento del rapimento in macchina, che comunque è una sequenza anche action, che è quasi fuori posto. Però va in fondo a sottolineare la differenza tra un racconto che segue l’avventura o comunque il conflitto così diretto e raggiunge, come lo chiami nel fumetto, un climax drammatico, mentre un racconto, come poi sono i tuoi, che si lascia guidare dall’emozione, più simile alla vita di tutti i giorni, dove i conflitti ci sono, ma sono solitamente, almeno nel nostro mondo, più a bassa intensità. Vuoi dire qualcosa di questa scena?
Sì, quella è una scena interessante. All’inizio il libro l’ho scritto improvvisando, come ti dicevo, quindi non sapevo nulla dei personaggi, non sapevo nulla della storia. Ho introdotto il pacco che arriva all’inizio senza sapere cosa ci fosse dentro. Sapevo solo che quel mistero, quando sarebbe stato svelato, avrebbe un po’ svoltato la storia, avrebbe cambiato ai personaggi. Ho passato dei mesi chiedendomi “sì, ma che c’è in questo pacco?” L’ho scoperto quando è arrivato il momento.
Quello è anche il motivo per cui mi sono bloccato anche tante volte nel corso di questi anni, perché scrivevo in questo modo. In ogni caso, della prima stesura ho mantenuto alcune cose, di cui la scena della macchina. Per me quella scena si potrebbe togliere dal libro ma l’ho voluta mantenere perché a me piace molto. Chi la leggeva mi diceva che effettivamente aveva qualcosa che andava al di là dell’intrattenimento, ti dava qualcos’altro. È legata al capire come funziona l’ansia e quindi capire cosa prova il personaggio di Roberto in situazioni normalissime. Il mio obiettivo era quello ma non lo sapevo. L’ho scoperto dopo, perché per me scrivere un po’ va di pancia, non lo programmo troppo prima. Quella scena effettivamente mi sono divertito molto a scriverla e in qualche modo trasmetteva questa cosa dell’ansia del personaggio in un modo che, se l’avessi programmato, non sarei riuscito a comunicare.
Personalmente mi rispecchio molto nelle situazioni e in molte delle dinamiche che descrivi. Certo, potrei essere una mosca bianca, in fondo ci ritrovo molto della mia vita – sono di (vicino) Roma, vivo a Berlino, ho la doppia vita tra Germania e Italia, combatto con l’essere genitore… ma credo che siano storie e dinamiche che risuonino in molti lettori e, in particolare, quelli della nostra generazione nata negli anni 80-90. Ti faccio una domanda provocatoria: possiamo definire le tue opere un manifesto generazionale? Penso a questo ultimo lavoro, ma anche a Va tutto bene. I tuoi personaggi sono spesso “sperduti”, in difficoltà a costruire un futuro lavorativo, relazionale, un’identità, a trovare un posto nel mondo… insomma probabilmente sono molti i quarantenni e i trentenni di oggi che ci si riconoscono.
Allora, no, non direi manifesto generazionale, è talmente una cosa personale… però capisco che la gente della mia generazione ci si ritrovi per quello che hai detto. C’è una tipologia di persone come me, forse come te, che ci si rivedono e altre della stessa generazione che magari non ci si ritrovano per niente, quindi non generalizzerei. Però effettivamente… me ne sono reso conto dopo, non era voluto, ma sono argomenti che parlano di più a persone della mia generazione.

Il discorso generazionale è ricorrente anche nel caso di un tuo amico e collega, che citi anche nei ringraziamenti conclusivi: Michele Rech, meglio conosciuto come Zerocalcare. Anche le sue opere vengono spesso descritte come specchio di una generazione. Michele ti ha spesso fatto comparire nei suoi lavori, e anche tu sul blog hai dato la tua versione fumetti di Zerocalcare e persino del famoso armadillo. Cosa ci puoi dire della vostra amicizia ma anche del vostro rapporto lavorativo?
In Pigiama Computer Biscotti lui compare proprio come personaggio. Io sono un suo fan, lo leggo da quando faceva le cose sul blog. Ci siamo conosciuti per caso, pubblichiamo con lo stesso editore e a Lucca Comics del 2013 ci siamo incontrati a cena con l’editore. Abbiamo parlato tanto e a me sembrava come se fosse un mio amico di sempre. Ci siamo trovati subito molto bene.
La nascita di un rapporto anche di lavoro a me fa molto piacere. È l’unica persona con cui, quando faccio un lavoro, non mi sento di dover far bella figura. Mi lascio andare e posso anche provare cose nuove, quindi uscire un poco dalla mia comfort zone. Provo a fare quel lavoro nel modo migliore, però divertendomi, che è una cosa che non mi succede quasi mai.
Quando ho un lavoro da fare, non intenzionalmente, ma lo prendo con più ansia che con divertimento. È difficile che io mi diverta a disegnare una mia pagina perché penso “se viene male? se poi non piace?” Invece con le sue cose è come se fosse un parco giochi. Mi posso divertire, tanto sono cose sue. Questa cosa mi piace tantissimo e, alla fine, funziona sempre. Io di solito gli mando due o tre versioni delle copertine o delle cose che mi chiede: una normale, una “pazza”, e una estrema che neanche gli farei vedere. Spesso la sua preferita è quella estrema! Poi non la possiamo pubblicare, quindi ripieghiamo su quella “pazza”. Ci divertiamo.
Ammiro come lavora: lui è molto veloce, in quattro mesi ti fa un libro. Io di solito ci metto anni (9 in questo caso!). Vorrei lavorare come lui, di solito non ci riesco. Però, lavorando con lui… ad esempio quando ho fatto i grigi di Quando muori resta a me (2024), sono riuscito in pochi mesi a finire un lavoro enorme. È stata una bella sensazione, finire un lavoro grosso in poco tempo. Non uscire mai da quel “flow” creativo.
Ogni volta che ci vediamo di persona mi viene voglia di scrivere, di raccontare. Lui è come nei fumetti: ti racconta un aneddoto, ti dice “dobbiamo parlare, ti devo raccontare una cosa” e tu stai lì ad ascoltarlo e vuoi sapere come va a finire. Ha il racconto dentro, anche mentre parla.

Michele spesso (in questa vignetta ad esempio), ti descrive come qualcuno in grado di trasformare tutto in poesia. Confermi?
Mah… no, ma mi fa molto piacere, anche se io sulle cose che faccio non lo vedo.
Zerocalcare si serve spesso dei tuoi talenti da colorista. In effetti i colori e l’uso degli acquerelli sono uno dei tratti più riconoscibili del tuo stile. Come nasce questa scelta artistica e come si è evoluta?
In realtà la scrittura e la colorazione sono le due cose che non considero “mie”, quindi posso seguire la mia curiosità e sperimentare. Mi considero un disegnatore, ed è assurdo che sono diventato più conosciuto per le storie e la colorazione che – mi dicono – è molto riconoscibile. Credo che sia perché in queste due aree mi posso lasciare andare, seguire la mia curiosità. Mentre nel disegno, ci provo, ma faccio più fatica. Ho delle regole già impostate.
Il tuo è un fumetto che definirei, volendogli applicare un’etichetta, “d’autore”, non mainstream. Istintivamente verrebbe da dire che il Madrigal lettore e spettatore elenchi nelle sue fonti di ispirazione opere impegnate, che “segua un percorso di formazione cinematografica” come fa Roberto in Dovevo dirti una cosa: Truffaut, Godard e così via. Però c’è anche l’anima di Angela che invece ha come film preferito una pellicola più “pop” come Mission Impossible. Tra le tue letture abbiamo già citato qualche fumetto italiano, Gipi, Zerocalcare… Invece film, serie, videogiochi, fumetti, cosa ti piace?
Per me la cosa che importa sono le storie, se mi toccano, se sono belle, non mi importa l’etichetta. È difficile farti un elenco, finirei per dimenticarmi… mi piacciono da Hitchcock a Mission Impossible, il primo di Brian De Palma.
Come regista mi piace molto Richard Linklater, che ha fatto Boyhood. La sua trilogia, Before Sunset, Before Sunrise e Before Midnight mi piace tantissimo. Il primo era un film anche un po’ banalotto, anni 90, con Ethan Hawke e Julie Delpy, due che si innamorano. Ma dopo dieci, quindici anni ha fatto il secondo film, di loro due che si incontrano di nuovo, e dopo tipo quindici anni, ne ha fatto un terzo, sempre con loro due. Tu vedi come è passato il tempo nella vita di quei personaggi. Mi piacciono molto soprattutto il secondo e il terzo perché sono solo dialogo, due personaggi che parlano tutto il film. A volte è anche una scena lunghissima in cui stanno camminando e parlano, eppure io non posso smettere di ascoltarli. Poi Woody Allen o Aaron Sorkin, lo sceneggiatore che ha fatto A Few Good Men, con la famosa frase di Jack Nicholson “You Can’t Handle the Truth!”
Però poi mi piacciono anche film come Ace Ventura. Anche Wes Anderson mi piace molto… le storie a volte mi annoiano, ma allo stesso tempo li vedo sempre, perché sono geniali, dai dialoghi ai dettagli grafici… spettacolari.
Da ragazzo giocavo tanto videogiochi. Poi però, intorno ai venticinque, ho un po’ smesso. Ora gioco tanto con degli amici a Tetris.

Tetris?!
Praticamente a Lucca Comics, dopo la cena dell’editore, si è creata questa tradizione in cui giochiamo a Tetris. Tutto è iniziato perché Ken Niimura, l’autore di fumetti, è un mostro a Tetris, e quindi lì si gioca in coppie e si crea una bella atmosfera. Io all’inizio quando l’hanno tirato fuori ho detto, “ma raga, ma che stiamo a fa, ma veramente, andiamo…!” e invece è incredibile.
Mi piaceva molto Metal Gear Solid, il primo. Ho giocato anche al 2 e al 3, però mi sono piaciuti di meno. È in parte collegato al discorso di prima: nel primo Metal Gear Solid per la Playstation 1, non si vedevano le facce, era tutto pixelato. Avevano delle costrizioni tecniche e dovevano essere molto più creativi nel farti sentire delle emozioni, quindi si inventavano delle cose assurde come il boss che faceva telecinesi… dovevi mettere a terra il joystick e con la vibrazione il boss lo faceva muovere… Il dover creare qualcosa con poco, mentre dopo, con più potenza grafica, diventava tutto più complesso, più bello, fatto bene, però perdi quella cosa iniziale.
Invece fumetti più mainstream?
Supereroi mi piacevano molto in un periodo, però era per i disegni, poi non li leggevo quasi mai. Humberto Ramos mi piaceva quando faceva Wolverine, Spider-Man, Out There… Poi Sin City, Watchmen… i classici, insomma.
Un’ultimissima domanda: com’è fare il tuo lavoro se si hanno dei bambini? Un po’ ne abbiamo già parlato, vuoi aggiungere qualcosa?
Mi viene in mente che man mano che passano gli anni, io voglio sempre fare un disegno con più errori, un po’ più “fatto male.”
Alla Gipi?
Sì, cioè, non so se alla Gipi, però con quel concetto di sottofondo. Gipi è molto più bravo di me a disegnare, però fa quella scelta che abbiamo descritto prima. E io voglio andare in quella direzione perché mi diverto di più e ci metto di meno a fare un libro, quindi non diventa un peso. Anche perché, quando ti diverti facendolo, poi il lettore lo sente e il disegno trasmette di più. É grazie ai miei figli che ho scoperto come farlo. O lo sto scoprendo. Quando gioco con loro a disegnare, loro mi dicono: “ora fai un drago che mangia una tigre!” Tu non hai tempo per fare le cose bene, devi fare veloce e provando a trasmettere quello che loro vogliono. E quello insegna.
Alla fine del libro c’è un disegno in cui sto disegnando con mia figlia. Sto finendo il libro e lei sta colorando, anche facendo degli acquarelli. Questo disegno lo avevo fatto perché era su un foglio suo in cui lei stava disegnando proprio come si vede. Io stavo lavorando, lei era accanto a me, però si stava cominciando ad arrabbiare perché non veniva qualcosa come voleva lei. Io ho preso un suo foglio e ho disegnato quella scena di quel momento, noi due che disegniamo.
E lei, mentre lo facevo, si è divertita così tanto che le è passata un po’ la rabbia e mi ha detto, “allora fai tu!” Quindi ho continuato e l’ho fatto proprio male! Cioè, non volevo fare un bel disegno, volevo farla divertire in quel momento. Alla fine ho un disegno scemo che però mi piace e l’ho messo sul libro per ricordarmi di questa cosa.

Grazie per questa lunga intervista. È stato un grande piacere.
Anche per me, grazie!
Intervista tenuta dal vivo il 25 giugno 2025.
Alberto Madrigal

Nato in Spagna e residente a Berlino dal 2007, dopo alcune storie brevi e lavori da illustratore freelance, Alberto Madrigal fa il suo esordio nel mondo del fumetto con la sua prima opera lunga nel 2013, quando pubblica Un lavoro vero (BAO Publishing), di cui è autore completo. Nel 2015, per la stessa casa editrice, pubblica Va tutto bene, in cui ritrova i temi dello smarrimento e i sogni di una generazione che lotta per affermare la propria identità.
Nel 2015 realizza le illustrazioni de L’albero delle storie, romanzo per ragazzi scritto da Gabriele Clima e pubblicato nella collana “Il battello a Vapore” (Edizioni Piemme). Nel 2017 realizza i disegni di Berlino 2.0, graphic novel scritto da Mathilde Ramadier edito dalla Casa editrice francese Futuropolis e pubblicato in Italia da BAO Publishing. Nel 2019, sempre per i tipi di BAO, realizza Pigiama Computer Biscotti, un’attenta riflessione sulla paternità. Nel 2025 esce il suo nuovo graphic novel, Dovevo dirti una cosa, in cui i temi dell’incomunicabilità tornano prepotenti all’interno della sua narrazione.