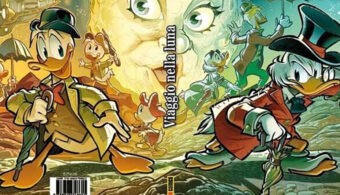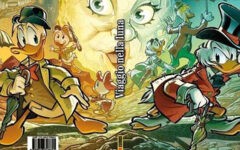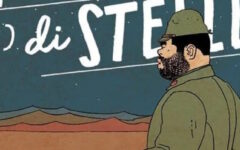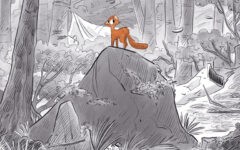Tutta questione di serializzazione e di improvviso guizzo creativo. Il fumetto non è probabilmente un’arte italiana, così come quasi tutte le arti sviluppatesi nel XX secolo. Abbiamo dominato in architettura, pittura, scultura, poesia, letteratura e musica fin quando il mondo era classico e governato da mezzi di comunicazione dalla diffusione lenta e dall’incerta circoscrizione del tempo. Nel novecento le forme di espressione artistica si sono messe in marcia alla velocità della trasmissione ondivaga, ma noi italiani abbiamo leggermente segnato il passo. Niente di meglio, allora, che affidarci alla seriale perpetuazione, secondo il gusto italiano che è il più raffinato del mondo, del modello nordamericano. Poi all’improvviso, il genio artistico, anche questo italiano ed unico al mondo, si indigna e si ribella e fumetto italiano diventa sinonimo di Paz, Buzzelli, Hugo Pratt, Milo Manara, Bonvi, Jacovitti…
Negli anni Cinquanta le invasioni nordamericane erano a colpi di Pow! Splash! Argh!, scaldabagni volanti, le curve sinuose e morbidissime delle donne di Milton Caniff e le calzamaglie ricamate dei supereroi, involontariamente ambigui nell’esportazione del più reazionario dei miti d’oltreoceano. Il fumetto che non si limita ad essere importato, ma che esattamente emigra, ripetendo in maniera inversa il fenomeno “Littleitaliano” avvenuto nei dorati States, è la produzione disneyana, che qui in Italia si ritaglia una sorta di “Little Disneyland”, che assume pero’ forme e connotati personalissimi, dando vita ad una scuola purtroppo destinata a soccombere sotto il marchio del furbissimo Walt, ma gigantesca nella statura mondiale della propria qualità. Non avremmo potuto amare Paperino senza Carl Barks, ma nemmeno senza Romano Scarpa e Giovan Battista Carpi, che ha avuto anche il merito di renderci più simpatico Topolino. Le edizioni disneyane italiane hanno strutturato differenti scuole localizzate soprattutto a Genova e Venezia, riprendendo la tradizione sincretistica storicamente radicata nella tradizione delle antiche repubbliche marinare, abituate ad assorbire e rielaborare personalmente gli stimoli provenienti dall’altra parte del mare.
Gli autori disneyani, artisti travestiti da artigiani, riuniti al lavoro in piccole redazioni di fortuna odorose come una cartoleria, si inventavano di tanto in tanto personaggi imbevuti di questi odori ed umori, destinati ad avere una vita propria più in ombra, ma dignitosissima. Come il Tiramolla di Roberto Renzi e Giorgio Rebuffi, che è proprio figlio della gomma e della colla, nasce proprio dalla mistura un poco folle di tutti questi elementi, e come le combinazioni nate quasi per caso, si rivela una sorta di scheggia impazzita, personaggio divergente e di rottura. Beppe e Cucciolo, che inizialmente lo accompagnano, si rivelano troppo legnosi, intrappolati nel modello Topolino – Pippo, che non può funzionare in un contesto culturale italiano. La tradizione letteraria anglosassone e conseguentemente nordamericana è zeppa di coppie di modello omosessuale soltanto tacitamente alluse (Sherlock Homes ed il fido Watson sono un esempio per tutte), mentre invece l’italianità non è mai allusiva, ma al contrario esplicita. Per cui la carica dirompente è preferibile, o almeno nell’Italia del 1952 era preferibile affidarla ad un personaggio cui non è possibile essere sessuato.
Tiramolla è come Roberto Benigni, esempio di comico puro. Ed il comico puro è come il pagliaccio: mette a nudo l’imperatore con la stessa cattiveria innocente di un bambino, ma non viene creduto. Benigni è andato a dire da Celentano le stesse cose che dice Sabina Guzzanti su Berlusconi, ma senza il suo livore. La comicità pura si garantisce l’immunità, pur se raramente il rispetto dovuto. Allo stesso modo come i film di Benigni si va a vederli con tutta la famiglia, mentre Raiot non è possibile vederlo in televisione nemmeno in orari notturni, Tiramolla è un personaggio fortemente eversivo che pero’ si fa leggere ai bambini perché ritenuto innocuo. Se avessi dei bambini, glielo farei leggere anche perché imparino a preferire l’allegro inferno di Geppo al sotterraneo potere degli incappucciati, a decodificare la dialettica dell’advertisement, a ragionare secondo una logica elastica e flessibile. Elastica e flessibile come se fosse impastata di gomma ed impiastricciata di colla…
Di
Gianfranca Quaraglia
Pubblicato il
(aggiornato il 25/06/2010)