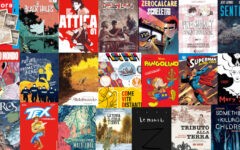Il suo era un paesaggio di libri.
Stavano alle sue spalle, o anche davanti a lui, a seconda di come spostava il tavolo da disegno in cerca della luce giusta: il cielo in una stanza.
Un cielo di libri.
Non ha conosciuto Internet, non ha fatto in tempo ad entusiasmarsi dei PC.
La sua preparazione, la sua documentazione e la sua cultura sono passate sempre unicamente per le pagine stampate.
Libri di ogni genere: fotografia, filosofia, arte, storia dell’arte, letteratura, cataloghi di mostre, pamhlet di improbabili spettacolini teatrali studenteschi, saggi di anatomia, manuali per curiosi, rarità per bibliofili, testi scientifici, compendi di storia dell’architettura, monografie su armi, album su animali, raccolte sul cinema, annate de “Il Vittorioso”, antiche enciclopedie…
Aveva progettato e disegnato la libreria della mia stanza e anche quella del suo studio, realizzata poi in tek da un artigiano di fiducia. Lineare e sobria, con scomparti anche per tavole e albi di grandi dimensioni, riempiva tutta una parete. Negli anni, questo mobile dal profilo così essenziale ha finito per traboccare di volumi multicolori ammucchiati in un’assoluta anarchia di tematiche, tra le quali lui solo poteva destreggiarsi.
Dunque, benché ragionevolmente capienti, ben presto questi scaffali furono saturi. I libri venivano allora impilati su tavoli, allineati su mensole, senza risparmiare i davanzali interni delle finestre.
La biblioteca di mio padre, la sua curiosità intellettuale, erano in continua espansione come l’universo di Einstein.
Impossibile contenerle dentro uno o più mobili come pure dentro una sola stanza.
Ricordo in particolare parecchi titoli della Piccola Biblioteca Filosofica Laterza, da Platone a Marx, che mio padre mantenne per anni allineati su quella mensola sotto la finestra del suo stesso studio.
E di cui io mi impossessai quando mi iscrissi alla Facoltà di Filosofia.
Che cosa ci facevano quei dotti volumetti color senape vicino a un tavolo da disegno?
Gli ricordavano forse uno dei suoi progetti ricorrenti e mai realizzati: raccontare a fumetti l’Apologia di Socrate o l’Emilio di Rousseau, come pure l’Apocalisse di Giovanni o la Fenomenologia dello Spirito di Hegel per restituire così alle idee la loro origine etimologica, per ricordare loro che sono figlie di un verbo che in greco significa “vedere”.
Con le parole scritte, veicolo privilegiato delle idee, mio padre aveva questo rapporto fisico e contraddittorio.
Da un lato se ne lasciava entusiasticamente ammaliare, ne subiva il fascino ambiguo, la seduzione tipografica e …musicale insieme. Le guardava con amore e devozione, come bizzarre catene di austeri criptogrammi, portatrici di una loro eleganza grafica, sigillate nel mistero chimico della mente umana e nei segreti dei processi di stampa… Dall’altro avrebbe preteso una rivincita, non tanto contro di esse, quanto contro i loro dotti paladini che ne facevano l’unico strumento pedagogico legalmente autorizzato nelle scuole, nelle accademie e nelle università.
Mi sembra perciò oggi che, attraverso i libri della sua biblioteca -e di qualsiasi biblioteca-, mio padre si ricordasse che ogni idea è figlia di una visione e che, a rigore, ad ogni libro (portatore di un’idea) egli avrebbe potuto rispondere quanto meno con un disegno, ugualmente degno di veicolare, in altro se non superiore modo, la stessa idea.

C’era ad esempio un Ricordi di scuola di Giovanni Mosca. Rizzoli, Milano 1942, XX. Un libro dell’era fascista, con quella specifica dell’anno in numeri romani. Illustrato con tavole in bianco nero non so da chi. Squinternato, le pagine ingiallite. Rilesse a me quei racconti quando ero ormai fuori tempo massimo per poter ascoltare favole. Eppure capii, dal modo in cui mi leggeva (leggendo a se stesso) quelle pagine, che i libri, benché di favole, sono molto più che favole, sono esseri viventi.
Discendono non solo da visioni, ma da odori, da sapori, da suoni, da carezze…
E vivono infinite vite proprie a seconda di chi li sfoglia, li legge, li vive, se ne appropria e li trasmette ad altri.
Poi c’erano le poesie di Libero de Libero, di cui era stato allievo al Liceo di via Ripetta. Scorreva quei versi, editi da Mondadori, quasi religiosamente, per recuperare a distanza di anni la dolcezza di un uomo forse troppo timido per fare il professore e di cui aveva per questo un ricordo tenerissimo.
E c’erano le tragedie greche, rubate ai miei scaffali di liceale, predilette perché erano “eterne”. Anche quelle avrebbe voluto illustrare.
Della Grecia e sulla Grecia classica possedeva tantissimi volumi: i lirici, l’arte attica, il Partenone. Li scovava spesso da Remainders, a piazza san Silvestro, una specie di outlet culturale, un pozzo di rarità fuori dai giri commerciali di grido e per questo tanto più allettanti per il suo gusto decisamente alternativo.
– Non mi serve andare ad Atene. Ci sono già stato, guarda qui…
E gongolava di fronte all’inedito dettaglio su una metopa del massimo tempio della grecità.
– Tanto, se andassi laggiù, già so che mi deluderebbe.
I libri come ideali compagni di viaggio per un inguaribile pigro con la vocazione a confondere alibi e motivazioni.
Ricordo poi numerosissime riproduzioni della Cappella Sistina e saggi su Michelangelo, che mio padre frequentava assiduamente specie dopo avere visitato il “cantiere” dei restauri. In quel caso il “viaggio” non lo deluse: salì personalmente sui ponteggi fino ad appiccicare il naso sulla volta appena restituita allo splendore dei colori originari. Non fece mai parte del coro dei nostalgici del grigiore. Il colore, sosteneva, aveva ridato vita al Michelangelo scultore-e-pittore.
E poi c’erano le prime storie del fumetto, dei primi settanta, quando la coscienza di questo mezzo si andava gradatamente facendo largo tra i resistenti pregiudizi di una pedagogia ottocentesca ottusamente iconoclasta.
Questi manuali spesso alternativi coabitavano su quegli scaffali con le opere di Byron, con il Faust di Goethe, Ulisse di Joyce, Gli strumenti del comunicare di Marshall McLuhan, la Fenomenologia della percezione di Maurice Merleau-Ponty, con i saggi di Rudolph Arnheim, con antologie di poeti dada… Ma anche con le dispense a fascicoli per aspiranti disegnatori! De Luca già maturo “si abbassava” a comperarle in edicola, lui che certo non doveva aspirare a niente, in quel senso.
Ma che amava abbassarsi, comunque.
Era un curioso, totalmente asistematico, intellettualmente anarchico (ovvero libero), capace di spaziare trasversalmente in discipline diverse, senza pregiudizi.
So oggi che la sua tensione costante fu di disegnare quello che pensava.
E che il suo sport preferito fu arricchire continuamente il suo pensiero allo scopo di disegnare sempre meglio.
Proprio questa sua cultura asimmetrica oriento’ i tratti magistrali della sua matita. Allo stesso modo, certe letture gli servirono ad ispessire le psicologie dei suoi personaggi, potenziarono verso il profondo le sue naturali capacità di vedere e far vedere la realtà nel suo insieme, partendo proprio dalla superficie.
“Se sapessimo vedere, sapremmo anche disegnare…”
Evidentemente non si riteneva ancora capace di vedere al meglio.
E se la scuola del vedere non si esaurisce mai, i nostri sguardi non sono mai abbastanza pietosi.
Oggi potrei chiosare: se sapessimo com-prendere, sapremmo anche vedere.
Com-prendere, vedere, infine disegnare….
Dentro Shakespeare a fumetti o le nebbie milanesi delle storie del commissario Spada ci sono così i racconti di Buzzati e Il castello di Kafka. Dentro le rivoluzionarie soluzioni grafiche che rompono la suddivisione della tavola in vignette affiorano i saggi di Ernst Gombrich e il Discorso sul Metodo di Cartesio…

Neppure si sarebbe esaurita in una borgesiana, infinita biblioteca di Babele. Né testimoniava una sua superficiale curiosità da erudito o una volontà di mettersi al passo con la parola scritta (con la cultura ufficiale!) per poi potersi vantare: ho letto Engels, ho frequentato Foucault…
La sua biblioteca si estendeva al cinema, al teatro, ai suddetti teatrini alternativi di suoi allievi e aspiranti epigoni, a mostre di arte precolombiana…
Ancora e sempre troppo pigro anche per andare spesso a teatro, prediligeva i classici del cinema quando gli venivano offerti in casa, tramite cicli televisivi. Per Il settimo sigillo e per tutta l’estetica di Bergman aveva una specie di venerazione. Stesso dicasi per Stanley Kubrick e il suo 2001: Odissea nello spazio.
Ma poi ammirava anche gli americani di Singin’ in the Rain, il musical in genere, le grandi epopee
western e perfino il ciclo di 007! Per poi divertirsi immensamente con la commedia all’italiana nella quale credo si identificasse insieme a tutta la sua generazione.
Considerava la faccia di Toto’, cui ha dedicato una breve storia biografica, un trattato vivente di mimica e fisiognomica. Non gli piaceva De Filippo, “presepiaro” troppo datato. E se andava a teatro, si scomodava solo per Pirandello o Carmelo Bene.
Pero’ i suoi testi preferiti restavano i profili degli alberi. Questione di sguardi. Tutto il resto, inclusi i libri, alla fine, era una specie di vuoto, di illusione.
Di nuovo, l’attenzione alla realtà.
Da leggere e decifrare, prima che raccontare.
“Da che parte guarda un albero?” si chiedeva, con Vitaliano Brancati.
Le risposte non contavano, preferiva le domande.
Leggeva, mi disse una volta, per trovare domande più che risposte.
Del resto i libri li leggeva, ma li firmava anche.
Libri disegnati, si intende. Era anche un autore. E che lotte, per guadagnarsi questo posto accanto al nome dello scrittore o dello sceneggiatore, per rivendicare la medesima dignità! Come se chi disegna non fosse del tutto titolato a vantare la paternità di un’opera edita. Oggi certi dettagli sembrano ovvi, qualche decennio fa si scontavano ancora certi pregiudizi.
Nella sua biblioteca venivano ammassate così anche le copie de La più grande storia mai raccontata o di Shakespeare a fumetti.
Trovarsi, autore, accanto ad altri autori alimentava quel suo rapporto contraddittorio con la parola. Il cui strapotere accademico non smise mai di irritarlo.
Soprattutto nell’era della riproducibilità tecnica dell’opera d’arte.
Era fondamentalmente convinto che la cultura deve arrivare a tutti, di qui il primato del fumetto anche sulla parola scritta e stampata. Che suona a volte equivoca e supponente, essendo troppo spesso usata per erigere muri piuttosto che abbatterli.
Per questo, ancora una volta, Gianni De Luca preferiva a tutti il libro aperto e misterioso della realtà, disponibile teoricamente a tutte le gradazioni di sguardi.
Quella realtà che trascende le ambiguità delle parole, che le ingloba e le perdona senza giudicarle.
Quella realtà che è eterna come le tragedie greche, che non assomiglia alla destra e neppure alla sinistra, che chiede l’orizzonte dei 360 gradi per essere com-presa, e che ci domanda di addestrarci continuamente all’umiltà del vedere, parallela a quella dell’ascoltare.
Un qualunquismo di punti di vista, dirà qualcuno, una specie di vuoto, che azzera le scelte storiche in nome di una pretesa, impossibile universalità di vedute.
Puo’ anche darsi.

Erano sempre quattro o cinque diversi, figli sparsi e raminghi di questa sua biblioteca in perenne diaspora, compagni fedeli grazie ai quali si incamminava sereno verso la notte tenendo per mano un’idea, cioé una visione: questione di sguardi, ancora una volta.
I titoli che lo hanno accompagnato nell’ultima notte sono stati in particolare due: L’idea fissa, di Paul Valery e L’arte del silenzio dell’abate Dinouart.
Li aveva cercati espressamente dopo averne sentito parlare alla radio (altro suo libro frequentemente aperto, soprattutto sulle memorabili trasmissioni di musica e prosa del Terzo canale, oggi Radio Tre).
L’idea fissa di Valery è la storia di un paradossale incontro fra due uomini … col gusto del paradossale! Un dialogo tesissimo sulla percezione dell’assurdo, sempre in agguato dentro la nostra esistenza. Due modi di affrontare l’angoscia e di fronteggiare la propria intelligenza che si incontrano e si alleano.
Intuisco oggi che proprio il suo gusto per il paradosso avvicino’ mio padre a questo testo, laconicamente abbinato all’altro, pure ritrovato sul suo comodino all’indomani della sua morte:
risalente alla fine del settecento e dovuto alla penna di un ecclesiastico di mondo, L’arte del silenzio propone espressamente un breve ciclo di lezioni sull’arte di tacere nonché su quella di scrivere bene.
Se è vero che ogni libro letto è spesso un libro condiviso, e che ogni sua riga sottolineata è il surrogato di un plagio, o meglio l’equivalente di un’adesione incondizionata, mi piace che uno degli ultimi pensieri condivisi, ovvero sottolineati da mio padre sia stato questo, tratto appunto dal testo di Valery:
“Io… creo. Traggo da me ciò che non sapevo di contenere“.
Sì, in un certo senso mio padre era un uomo consapevole di poggiare su uno spazio cavo.
Tutta la sua biblioteca, tutti i suoi saperi poggiavano su una verginità di intenzioni e di attenzioni, su una neutralità di sguardi, su quella specie di vuoto…
Ma era un genere di vuoto destinato ad essere ben presto contraddetto, ovvero comunque riempito.
Esattamente come un foglio bianco.
Riferimenti
Il sito di BilBolBul: www.bilbolbul.net
Il sito di Hamelin: www.hamelin.net
Ringraziamo Laura De Luca, Hamelin e Black Velvet per aver permesso la pubblicazione di questo articolo
Le immagini di questo articolo sono de luca