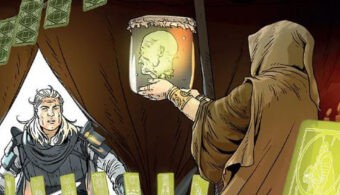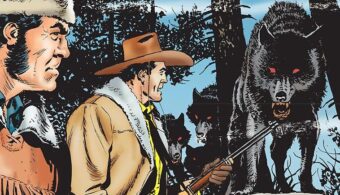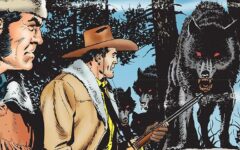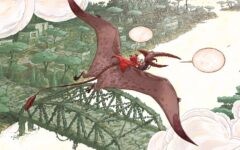Una storia d’orrore, il nuovo Speciale Dylan Dog, porta avanti il percorso autoriale di Alessandro Bilotta, qui insieme al co-creatore di Eternity Sergio Gerasi ai disegni: la rielaborazione del corpus di opere sclaviane, scolpite nell’immaginario dei fan dell’Indagatore dell’incubo, dimostra la possibilità di proseguire su un terreno ancora fertile anche a distanza di diversi anni. Nelle abili mani dello sceneggiatore romano e del disegnatore che forse meglio interpreta le sue visioni, anche quello che avrebbe potuto essere un semplice omaggio al passato, con l’aggiunta di un pizzico di metanarrazione, si trasforma in un albo ricco di spunti, capace di andare oltre l’effetto nostalgia e le esigenze di riprendere il filo della continuity.
LE CONSEGUENZE DELL’AMORE
Centrale a livello tematico è l’amore con le sue conseguenze. Dylan ritrova Opal, ragazza dal ruolo cruciale e volto certo non nuovo nella saga dylaniata, e costruisce con lei un legame forte e a tratti idilliaco. La relazione tra Dylan e Opal non è un’avventura qualunque, ma si caratterizza sia perché sembra (letteralmente) fuoriuscita dalle pagine di un fumetto sia perché la tanto ricercata serenità e stabilità affetttiva dell’Indagatore dell’incubo rivela il suo prezzo da pagare: la felicità (e la vita) altrui.
Finché l’inquilino di Craven Road e la ragazza rimangono insieme, qualcun altro sembra infatti perdere la vita. Dylan si trova dunque a chiedersi quale sia il prezzo della propria felicità e se sia giusto che altre persone ne paghino le conseguenze.
Del resto, come già il titolo dell’albo sembra suggerire, “amore” fa rima con “orrore”.
A questo si aggiunge la presenza di vari piani di realtà che si vanno a sovrapporre: quello della storia narrata e quello del fumetto in cui viene raccontata e dell’autore che la narra, in un gioco a incastri riuscito e non banale.
Sebbene il fumetto sia sostanzialmente fruibile in maniera autonoma senza grossi rischi di non comprenderne il senso universale e profondo, presenta importanti e affascinanti relazioni con altri albi, tanto da farne una tappa di un percorso più ampio.
IL LEGAME CON SCLAVI E CON IL PIANETA DEI MORTI
Pur senza essere inserito esplicitamente all’interno della saga del Pianeta dei Morti, Una storia d’orrore mantiene infatti diversi legami con le altre storie scritte da Bilotta per i precedenti Speciali, tanto da rendere ragione di una continuità autoriale che prevarica le etichette e le facili categorizzazioni.
Se infatti la saga distopica ambientata nel futuro è ufficialmente in stand-by a livello editoriale (per quanto riguarda la pubblicazione di episodi inediti, mentre le ristampe proseguono in volumi cartonati per il mercato librario), va altresì sottolineato come le trame si ricolleghino alla strada intrapresa da anni da Bilotta, sia per i personaggi coinvolti che per il legame inscindibile e rivelatore con le storie di Tiziano Sclavi.
La co-protagonista, Opal, è la figlia del Professor Hicks: entrambi erano già apparsi nel precedente Speciale, Il progetto Hicks, e il loro ruolo si riverbera nel futuro del Pianeta dei morti (alle origini dell’infezione che causa il futuro distopico del PdM, Groucho viene infettato da uno zombie vittima di un esperimento del Professor Hicks).
Il Professor Hicks, storico nemico di Dylan, è il fratellastro di quel Dottor Hicks che ha creato la Zona del Crepuscolo e appare per la prima volta nel numero 14, Fra la vita e la morte, mentre le origini di Opal sono rintracciabili ai tempi di Ritorno al crepuscolo, Dylan Dog #57 (albo in cui non viene mai mostrata in viso).
In Una storia d’orrore l’inserimento metaletterario di un fumetto dal titolo The Witch potrebbe essere un facile richiamo a un’altra grande opera sclaviana: Caccia alle streghe. Chi conosce la storia di Dylan Dog ben ricorda quest’albo, datato giugno 1992, in cui Sclavi si esprimeva contro la censura sui fumetti, un episodio che rappresenta un vero e proprio spartiacque. Importante al punto da renderlo un perno per l’opera di Bilotta: il Pianeta dei Morti sembra raccontare infatti un futuro ipotetico del Dylan Dog dei primi 69 numeri, fino a Caccia alle streghe dunque, per farne al contempo la chiusura di un percorso ma anche un punto di partenza imprescindibile (l’albo viene anche citato più volte da Bilotta nelle storie del PdM, quando il Dylan del futuro viene tormentato da incubi ricorrenti che richiamano il finale di Dylan Dog #69).
Riportiamo questi legami di continuity (e ce ne sarebbero diversi altri, sui quali sorvoleremo per amor di sintesi) principalmente per ribadire quanto l’affresco realizzato da Bilotta sia sostanzialmente unico e, sebbene nel corso degli ultimi due Speciali sia stato dirottato non più nel futuro alternativo del PdM ma piuttosto in un indefinito presente (anch’esso verosimilmente alternativo e non strettamente legato a quanto avviene attualmente all’interno della serie regolare), l’unico vero confronto di Bilotta, la sua (e la nostra) bussola per orientarsi nella giungla delle quasi quarantennali pubblicazioni dell’inquilino di Craven Road, è e rimane l’opera di Tiziano Sclavi. Anzi, di Tiziano Sclavi e Angelo Stano, come vedremo.
MORGANA, CRANDALL REED E IL CONCETTO DI MEDIUM
Bilotta si insinua dunque tra gli spazi bianchi delle storie di Sclavi, ne esplora i risvolti e le conseguenze, ne mette in luce le sfumature e gli angoli bui, ampliando e dando nuovi significati a tutta una serie di concetti e idee che negli albi di Sclavi erano state solo suggerite.
In particolare, in quest’albo torna su uno dei capisaldi della mitologia dylaniata: Morgana.
“Oh, è molto semplice, signor Reed: con quel vostro fumetto apparentemente insignificante avete squarciato il velo di un possibile futuro… o meglio di un probabile, probabilissimo futuro… la vittoria degli zombie, le oasi degli immemori… e ormai non si sa più, tra gli uni e gli altri, chi siano i veri morti…”
Madame Trelkovski, Morgana (Dylan Dog #25)
Già in un precedente pezzo di Francesco Pelosi veniva posto l’accento sui tanti indizi disseminati da Sclavi nel corso degli anni sul passato e su un eventuale futuro di Dylan con idee spesso appena accennate: lo stesso concept alla base del Pianeta dei Morti viene riassunto in un dialogo di Madame Trelkovski in Dylan Dog #25, albo che fornisce una vera e propria ossatura di base per Una storia d’orrore, sulla quale costruire una sorta di rielaborazione e integrare nuovi spunti.
Centrale è il ritorno tra queste pagine di Crandall Reed, fumettista creato da Sclavi proprio in Morgana e ritratto da Angelo Stano con le proprie fattezze. L’equivoco/ambivalenza del suo ruolo è al tempo stesso ironico ed emblematico: Bilotta gioca infatti con il significato del termine “medium” tra spiritismo (persona in grado di dialogare con entità extrafisiche e/o di prevedere il futuro) e sociologia (mezzo di comunicazione, in questo caso il fumetto), entrambi impersonificati appunto dall’alter ego di Stano. La presenza di un fumettista tra i personaggi e di un enigmatico fumetto horror nella trama rappresentano un modo per inserire una chiave evidentemente metafumettistica nella storia e per parlare dell’esigenza di raccontare, della sottile linea di demarcazione tra realtà e fantasia e del desiderio di lasciare il segno attraverso l’arte (lo stesso Gerasi, ad esempio, si autoritrae a sua volta nei quadretti a pag. 96, perpetrando così il gioco metanarrativo).
Tornando a Morgana, Bilotta non si limita a realizzare un remake/sequel di quell’albo, ma ne sfrutta gli spunti come base di partenza per una storia nuova di zecca, che riverbera nella mente di chi già conosce il classico dylaniato e si evolve verso una direzione differente, maggiormente introspettiva e filosofica come è nello stile dello sceneggiatore romano.
LA ZONA DEL CREPUSCOLO, LA MEMORIA E I CONTINUI RITORNI
Il concetto della Zona del Crepuscolo, del resto, è assolutamente coerente e propedeutico alla narrazione del Pianeta dei Morti: laddove Sclavi aveva immaginato un luogo di confine fra la vita e la morte dove ogni malattia è congelata da un’eterna immobilità, Bilotta ha dato origine a un “what if” di grande impatto narrativo, un mondo ossessionato da modi diversi di respingere la morte, “diviso tra chi si narcotizza per arrivare a fine giornata e chi si uccide nel tentativo di vivere per sempre”, in cui i morti viventi/vivi morenti sono una grande metafora contenitore di visioni filosofiche ed esistenziali affini a quelle sclaviane, sebbene autonome.
Parlando d’amore, Bilotta indugia sul tema della memoria, della potenza dei legami, arrivando anche a domandarsi se non sia una vita senza alcuna relazione affettiva il vero incubo, forse ancor più temibile della futura epidemia nel contesto distopico.
Anche la scelta finale di Dylan, senza voler spoilerare troppo, sembra essere rappresentativa dell’esigenza/necessità editoriale di non vincolare il personaggio a un unico amore, di resettare tutto per potergli far vivere, il mese successivo, una nuova storia senza aver memoria di essere ancora innamorato della stessa donna. Anche qui, la realtà editoriale si interseca con la rappresentazione della realtà stessa tra le pagine di un fumetto, in un gioco a incastri di grande impatto che sembra l’incarnazione di una Zona del Crepuscolo narrativa, dove l’oblio regna e tutto sembra immodificabile.
GERASI E L’ESIGENZA DI SPERIMENTARE
Se Bilotta sembra dialogare implicitamente in modo costante con Sclavi, ad accompagnarlo è un Gerasi che (anche in modo raffigurativo) si confronta esplicitamente con Stano. Rappresentare Stano, nella figura di Crandall Reed, è al contempo un omaggio al disegnatore del numero 1 della serie e storico copertinista ma anche una dichiarazione d’intenti per un artista,
Gerasi, che si conferma come uno dei pochi in grado di raccoglierne l’eredità, in particolare per il desiderio di continuare a mettersi in gioco, di sperimentare con tecniche differenti (si veda per confronto il lavoro fatto sui precedenti Speciali di Dylan Dog e su Mercurio Loi ed Eternity, per rimanere in ambito bonelliano), di mescolare l’esigenza di riconoscibilità del personaggio e del suo mondo con uno stile autoriale marcato e personale.
Il suo tratto nervoso e impalpabile, che già aveva convinto due anni orsono in Una risata vi resusciterà (Dylan Dog Speciale #35), si fa qui più deciso, con neri ampi a descrivere ombre più nette, perfettamente funzionali al mood del racconto. Gerasi conferma la sua eccezionale capacità di ritrarre l’espressività dei suoi personaggi, di cercare nelle elucubrazioni narrative di Bilotta una chiave di lettura precisa e convincente.
CONCLUSIONI
“E quindi…? Ho inventato un incubo, per farne un divertimento!”
Una storia introspettiva, di grande atmosfera e con disegni efficaci che riesce a esprimere, tra incubi quotidiani e spunti metafumettistici, una elegante riflessione sulla scrittura sclaviana e sui suoi risvolti, ma anche sulla natura del personaggio e dei suoi racconti, ugualmente divisi tra vita e morte, tra orrore ed amore.
Abbiamo parlato di:
Speciale Dylan Dog #37 – Una storia d’orrore
Alessandro Bilotta, Sergio Gerasi
Sergio Bonelli Editore, settembre 2023
160 pagine, brossurato, bianco e nero – 7,90 €
ISSN: 977112365904830037