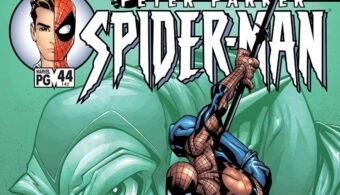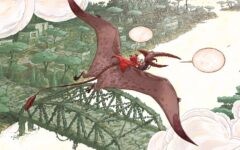Un eroe orfano di padri

Al contrario, sappiamo che Chris Claremont e Herb Trimpe, chiamati a scrivere e disegnare le sue prime avventure, non avevano partecipato alla sua ideazione e possiamo al più notare che aspetto fisico e design del costume originario rimandano alla mano di John Romita Sr. che in quel periodo era chiamato a creare graficamente molti dei personaggi della Casa delle Idee.
Le storie con protagonista Capitan Bretagna durarono però meno di un anno poiché il settimanale chiuse i battenti nel luglio 1977 con il numero 39. Seguirono quattro anni di iato, prima che il personaggio venisse ripreso e rilanciato nel 1981 nell’antologico Marvel Superheroes #377 in quello che, col senno di poi, si è trasformato in un ciclo di storie fondamentale non solo per l’eroe britannico ma anche per l’intero universo Marvel, grazie a due allora giovani e promettenti autori inglesi dall’identico nome di battesimo: Alan Moore e Alan Davis.
Già nel 2009, nella terza uscita della collana Marvel Gold, Panini Comics aveva presentato l’intera run di Moore e Davis sul personaggio, raccogliendo in un solo volume i numeri 387-388 di Marvel Superheroes, gli undici della rivista Daredevils e i numeri dal 7 al 13 di Mighty World of Marvel, cioè le tre testate inglesi che avevano ospitato il ciclo di avventure di Capitan Bretagna.
A fine 2017, l’editore di Modena ha fatto un passo in più con un nuovo volume cartonato della serie Marvel History: oltre a ristampare le storie comparse negli albi citati, ha racchiuso in una sola pubblicazione anche le avventure comparse nei dieci numeri di Marvel Superheroes antecedenti l’arrivo alle sceneggiature di Alan Moore, quelli che segnarono il rilancio dell’eroe da parte di Dave Thorpe ai testi (con l’esclusione del #385 firmato da Paul Neary) e di Alan Davis ai disegni, membro del team artistico fin dall’inizio.
Al di là di un mero pregio completistico, questa inclusione portava con sé un duplice valore. Da un punto di vista narrativo, permetteva la piena e completa comprensione dello story arc creato da Moore che, pur sviluppando una storia totalmente nuova per il personaggio, fondava le sue premesse su quanto scritto da Thorpe nelle sue avventure.
Dall’altro – cosa ancora più importante – il contenuto del volume dava la possibilità di confrontare la narrazione di Moore con quella di Thorpe e al tempo stesso seguire l’intero arco evolutivo di Alan Davis. Da quella lettura emergeva la possibilità di individuare in questo lavoro giovanile dei due Alan già alcuni segni stilistici distintivi che diventeranno punti fissi e ricorrenti della cifra narrativa dell’uno e grafica dell’altro.
Nel 2022 Panini dedica uno dei suoi famosi ed eleganti Omnibus alla figura del Capitano, un corposo volume cartonato con sovracoperta di quasi 650 pagine curato nell’edizione italiana da Marco Rizzo. Il fulcro di questa pubblicazione restano le storie di Moore e Davis, qui riproposte nuovamente, a cui però vanno ad aggiungersi i numeri dal 14 al 16 di Mighty World of Marvel e i quattordici numeri della serie della Marvel UK Captain Britain del 1985, firmati da Jamie Delano e il sempre presente Davis (con l’aggiunta di un racconto di Grant Morrison illustrato da John Stokes nel #13). Ad arricchire il menù arrivano poi due storie tratte da Captain America #305-306 del 1985, di Michael Carlin e Paul Neary, e due Annual – rispettivamente di New Mutants (#2, 1986) e di Uncanny X-Men – i cui autori sono, e non poteva essere diversamente, Claremont e Davis.(#11, 1987).
A completare il volume abbiamo una prefazione firmata proprio da Davis e risalente al giugno 2021 e un corposo estratto dallo sketchbook del fumettista britannico, che lascia spazio in conclusione alla postfazione firmata da Jim Krueger.
Una nota particolare: pur essendo quello firmato da Moore e Davis un vero e proprio ciclo fondativo, non solo per Capitan Bretagna ma anche per una serie di concetti fondamentali del Marvel Universe, ancora oggi alla base delle storie a fumetti come delle loro iterazioni nel linguaggio cinematografico e televisivo, il nome del Bardo di Northampton non compare nell’elenco a inizio volume degli autori, né viene mai menzionato nei redazionali (lo si trova però nei credit all’inizio delle storie). Sappiamo bene che ciò deriva da un’esplicita richiesta dello sceneggiatore, tuttavia è fuor di dubbio che il fulcro di questo volume continui a essere il “ciclo dei due Alan”, che merita un’approfondita analisi tanto da un punto di vista narrativo quanto grafico.
Le doti del giovane Moore

Al futuro bardo di Northampton la sezione inglese della Casa delle Idee propone dunque di sceneggiare le avventure dell’alter ego supereroico di Brian Braddock e Moore si trova “nel mezzo di una trama che non aveva iniziato né completamente capito” (come ammette lui stesso nell’introduzione pubblicato nel volume Marvel History del 2017).
David Thorpe, fin dall’inizio del rilancio dell’eroe, aveva impostato le storie con un forte taglio politico e la cosa aveva creato frizioni con i suoi supervisori che spinsero lo sceneggiatore ad abbandonare l’incarico dopo nove numeri.
Nel giro delle successive due uscite, in uno spazio di dieci tavole complessive (queste avventure si componevano di 5/6 pagine ciascuna, lunghezza dovuta al risicato budget a disposizione per il pagamento degli autori), Moore fa una sorta di tabula rasa di quanto avvenuto prima: uccide la spalla di Capitan Bretagna, l’elfo Jackdaw, e annienta l’eroe stesso, facendolo disintegrare da una creatura nota come la Furia in un cimitero dove riposano i supereroi (tra le lapidi, non può non essere notato il nome di Miracleman, l’eroe che da lì a un anno avrebbe segnato l’affermazione di Moore come autore) e che racchiude in sé l’indizio di una sottotrama – quella relativa all’eroina Capitan UK – che l’autore porta avanti per diciannove storie, facendola diventare via via più centrale e sciogliendone l’intreccio nell’ultimo numero da lui scritto.
Seppur la sicurezza nella scrittura e nella gestione dei personaggi venga acquisita con il procedere delle storie, sin da subito è evidente lo scarto con le precedenti sceneggiature di Thorpe. La narrazione si fa da subito più densa e profonda sia a livello di azione sia di testi e dialoghi e, dopo l’annientamento dell’eroe, Moore nel suo terzo numero mette in atto la rinascita di Capitan Bretagna attraverso le gesta di Merlino e di sua figlia Roma, ai quali lo scrittore dona una profondità caratteriale e un senso narrativo di cui fino ad allora erano stati privi.
Annientamento e rinascita, che diventano in seguito due dei topoi fondamentali della scrittura di Moore, sono portati avanti nelle otto pagine della prima storia ospitata su Daredevils #1 (Uno straccio, un osso, una ciocca di capelli…) in una sorta di taglia e cuci narrativo che riprende tanto i fili di trama già imbastiti da Thorpe quanto stralci delle precedenti avventure del Capitano per imbastire un racconto delle origini che getta una nuova luce sul personaggio, donandogli un rinnovato senso e proposito.
A ben vedere, la rinascita di Capitan Bretagna è un vero e proprio canovaccio sul quale Moore sviluppa nel 1982 il rilancio di Miracleman: in entrambi i casi, senza rinnegare il passato dell’eroe, egli permea i due di uno spessore inedito – più profondo e contemporaneo – usando gli elementi narrativi già presenti nelle storie passate legandoli in un nuovo disegno. È quell’operazione che è passata alla storia del fumetto come Revisionismo supereroico e di cui si scorgono i primi accenni proprio in Capitan Bretagna.

A cominciare dalla distopia, qui accennata come sfondo dell’azione ma che trova pieno sviluppo in seguito in due capolavori come V for Vendetta e, in parte, Watchmen. Distopia che ha come centro l’Inghilterra che nella realtà del tempo è entrata nell’era thatcheriana, su cui l’autore si concentra più da vicino in Miracleman.
C’è poi presente l’idea del supereroe non più infallibile, bensì umano e affetto da traumi psicologici dovuti alle avventure che vive. Caratteristica che in questo volume Moore non applica al protagonista ma a una delle sue controparti del multiverso (argomento su cui torniamo più avanti), Capitan UK, attrice principale come già accennato di una sottotrama che attraversa l’intera gestione della storia da parte dell’autore.
Moore fa compiere all’eroina – unica superstite di una realtà parallela distrutta dalla minaccia che si sta ora per abbattere su quella di Capitan Bretagna – un intero arco di sviluppo psicologico complesso e non scontato: traumatizzata dalla strage avvenuta nel suo mondo e incapace di reagire e sopportare il fardello di dolore davanti alla prospettiva di un nuovo ripetersi della catastrofe, la donna torna a indossare il suo costume, spinta dagli eventi, ma il suo agire è indelebilmente segnato dalle cicatrici che porta dentro.
Insieme a tutti questi fattori, lo sceneggiatore mostra un’estrema abilità nel tratteggiare e caratterizzare i comprimari, che fino alla storia precedente erano quasi uno sfondo senza spessore o meri meccanismi narrativi. Moore dà consistenza e ambiguità al personaggio di Opal Saturnyne (che tante volte in futuro tornerà nelle storie con protagonista il Capitano e anche in tante avventure mutanti, anche nell’ultimo rilancio firmato da Jonathan Hickman), così come approfondisce la figura di Betsy Braddock, sorella di Brian e futura Psylocke degli X-Men.
Ancora, la capacità di creare personaggi stravaganti e sopra le righe come i membri del gruppo mercenario Unità Esecutiva, dai poteri improbabili ma al contempo affascinanti; o di prendere un villain come Jim Jasper della Crazy Gang – poco più di una macchietta nella prima storia del rilancio di Capitan Bretagna firmato da Thorpe – e trasformarlo in un criminale folle e pericoloso, capace di mettere in pericolo l’intera esistenza di universi.
Davis e la progressione artistica di un talento naturale
Come detto sopra, ad Alan Davis viene affidato il compito del restyling grafico di Capitan Bretagna, che va in scena nella prima storia del rilancio firmata da Dave Thorpe su Marvel Superheroes #377. Per il ventottenne autore britannico si tratta del primo incarico professionale importante e si trova davanti a una sfida non da poco: ridefinire completamente il costume dell’eroe che originariamente portava sul petto l’immagine di un leone.
Segno araldico, senza dubbio, che tuttavia in Inghilterra è associato al simbolo che indica la freschezza delle uova1.
Davis ha un’intuizione vincente, che si rivela ancora più fondamentale visti i successivi sviluppi narrativi portati avanti da Alan Moore:
«Decisi di basare il suo costume sulle uniformi militari. Chi ha visto le guardie reali che montano fuori da Buckingham Place, riconoscerà immediatamente alcuni componenti: i pantaloni bianchi e gli stivali alti con le falde sulle ginocchia sono state le parti più facili. Il copricapo ha richiesto più tempo, perché volevo che somigliasse a un elmetto piuttosto che a una maschera. Le strisce sul petto le pensai all’inizio come due fasce incrociate e hanno subito numerosi cambiamenti prima della scelta definitiva.» (Modern Masters Volume 1: Alan Davis – TwoMorrows Publishing)

Ciò che colpisce veramente da subito – fin dalla prima pagina della prima storia – è come il disegnatore inglese sia dotato, ancorché privo di significative esperienze professionali, di un eccezionale storytelling e di una capacità di strutturare di conseguenza le tavole.
Nella pagina iniziale de Il ritorno di Capitan Bretagna, Davis distrugge la griglia per ricomporla in una serie di vignette che, come frammenti che si ingrandiscono progressivamente, assecondano il viaggio che Brian Braddock e l’elfo Jackdaw compiono verso la dimensione reale: un movimento a spirale che va a ricomporsi nell’ultima vignetta della pagina che termina con l’arrivo dei due sulla Terra.
Il segno di Davis è ancora grezzo, lontano dall’eleganza e dalla pulizia tipiche del suo stile maturo, tuttavia sono impressionanti la padronanza e il dinamismo della narrazione grafica.
È vero che la resa delle fisionomie dei personaggi è ancora discontinua, che in alcune tavole il layout risulta infelice per la leggibilità o per un’esuberanza di vignette e particolari (responsabilità, da un lato, della poca esperienza di Davis e, dall’altro, della tendenza di Thorpe a chiedere al disegnatore vignette dense di personaggi ed elementi di ambientazione) ma la sensazione che si ha procedendo con la lettura delle pagine è quella della progressione in tempo reale della crescita artistica di Davis.
Anche Moore evidenzia questa caratteristica, sempre nella prefazione al volume del 2017:
«Dopo circa una dozzina di pagine, cominciamo a notare che le singole immagini e la disposizione delle tavole assumono un aspetto più elegante e meno impacciato, mentre inizia ad affinarsi velocemente l’occhio dell’artista, che scarta gli elementi superflui e si concentra invece sui singoli dettagli espressivi. Tavola dopo tavola, pagina dopo pagina, oltre le difficoltà iniziali della raccolta, siamo testimoni di un talento nel pieno impeto mozzafiato dell’evoluzione e della formazione.»
Quando Moore arriva alla scritture delle storie, il segno di Davis si è già fatto più sciolto e sicuro e, complici le attente e dettagliate sceneggiature dello scrittore, assistiamo al pieno esplodere del talento del disegnatore in tavole che si alternano tra griglie regolari, vignette verticali, tagli orizzontali e splash page nelle quali risalta la chiarezza di lettura.Davis acquisisce sicurezza anche in quello che diventerà un altro tratto distintivo della sua cifra stilistica: mentre il tratto si fa più continuo, pulito ed elegante, viene fuori la capacità dell’artista di donare ai personaggi una rara grazia nei movimenti e una dinamicità nelle espressioni facciali che evidenziano tanto i passaggi comici, quasi caricaturali, quanto i momenti estremamente drammatici della narrazione.

Una delle vette grafiche dell’intero volume la si raggiunge nella storia Il suono e la furia (Daredevils #10).
Siamo nella fase della vicenda in cui assistiamo all’apparente trionfo degli antagonisti e alla sconfitta di Capitan Bretagna e dei suoi alleati, quel momento di inesorabile disfatta che precede il rialzarsi degli eroi e la vittoria finale.
La storia si compone di tredici pagine e la terzultima e penultima tavola compongono un’unica spread page, nella quale viene rappresentata non tanto un’azione fisica quanto una successione di momenti psicologici vissuti dai protagonisti.
Il layout si struttura in quattro grandi vignette verticali – due per pagina – caratterizzate da un’identica impostazione, con la parte alta che contiene l’immagine di due personaggi del gruppo degli eroi e due antagonisti: agli estremi abbiamo Cobweb e Merlino, mentre nelle vignette centrali troviamo la Furia e Jim Jaspers. Il fondo delle quattro vignette invece ospita le immagini di quattro eroi – rispettivamente Wardog, Betsy Braddock, Capitan Bretagna e, di nuovo, Cobweb che apre e chiude la doppia pagina; la parte centrale delle due tavole viene usata per inserire una serie di figure che, muovendosi tra vignette e spazi bianchi che le dividono, fungono da collegamento tra i riquadri che simboleggia non tanto il fluire dell’azione quanto degli stati d’animo: Legion e le pedine degli scacchi posseduti da Merlino che raffigurano Betsy e Brian.
L’intera sequenza serve a trasmettere la drammaticità del momento, lo sconforto e la disperazione vissuti dagli eroi, contrapposto alla follia e alla spietatezza dei loro antagonisti e la sconfitta inattesa dello stesso Merlino, deus ex machina degli eventi. Queste situazioni legate tra loro – una conseguenza dell’altre – sono rese graficamente da Davis attraverso l’estrema sofferenza di pose ed espressioni con cui raffigura gli eroi e con una serie di elementi grafici che cuciono tra loro le vignette.
Tali elementi appartengono tutti alla Furia – di fatto il mezzo materiale che decreta la sconfitta degli eroi – e sono i fasci di luce ortogonale che escono dal suo occhio nella seconda vignetta attraversando la doppia tavola e la ripetizione dello stesso occhio in tre dei quattro quadri, una sorta di mirino puntato su Wardog, Betsy e Capitan Bretagna.

I lasciti mooriani al Marvel Universe
Il ciclo di storie di Moore e Davis racchiudono al loro interno anche un altro valore, di stampo narrativo, fondamentale per l’architettura dell’universo Marvel da lì in avanti.
È infatti qui che lo sceneggiatore inglese presenta per la prima volta il concetto di multiverso nel cosmo Marvel e conia il termine di Terra 616, a rappresentare la realtà che ospita la continuity principale nella quale si svolgono la maggior parte delle storie della Casa delle Idee.
Questo concetto qui introdotto si lega direttamente alla figura di Capitan Bretagna e alla rivelazione della sua appartenenza a un corpo interdimensionale che ha il compito di proteggere l’esistenza dei vari universi paralleli e che in ognuno di essi vanta un rappresentante che è una rivisitazione del personaggio di Brian Braddock (Capitan UK, Capitan Airstrip One, etc), la cui adunata è splendidamente resa da Davis nell’ultima storia del ciclo.
Questi due elementi saranno ripresi da molti degli autori che in seguito hanno lavorato sul personaggio, a cominciare dallo stesso Davis che insieme a Jamie Delano ha dato vita a un altro importante ciclo narrativo del Capitano fino ad arrivare a Chris Claremont che, sempre insieme a Davis, ha fatto del concetto di terre parallele uno dei pilastri narrativi della sua gestione del gruppo mutante Excalibur.
A questo già importante tesoro, Moore fornisce in queste sue storie tutta una serie di personaggi così interessanti che sono andati ad arricchire il pantheon marveliano e sono tornati in decine di storie future, non ultima la creazione dell’elementale Meggan che appare per la prima volta ne Il dialogo delle candele (The Mighty World of Marvel #7) e che ricoprirà un ruolo fondamentale nella vita di Brian Braddock.
Questo omnibus di Capitan Bretagna dunque possiede la caratteristica non rara nella produzione di Moore, di presentare una serie di storie “invecchiate bene”, che rispondono ancora tanto ai ritmi quanto agli stilemi narrativi della attuale produzione supereroica e dotate di un approfondimento psicologico oggi forse ancora più apprezzabile che in passato.
Se a questo aggiungiamo l’apporto di Alan Davis, la grazia artistica che si ritrova nelle pagine e la possibilità di seguirne l’evoluzione autoriale dalla prima all’ultima pagina, possiamo affermare che questo ciclo di Capitan Bretagna resta a tutt’oggi una delle letture fondamentali tanto per gli appassionati dei supereroi Marvel quanto per i lettori del buon fumetto in generale.
Abbiamo parlato di:
Capitan Bretagna (Marvel Omnibus)
AA.VV.
Traduzione di Dario Fonti, Andrea Antonazzo, Francesco Vanagolli (Max Studios), Andrea Plazzi, Pier Paolo Ronchetti
Panini Comics, 2022
648 pagine, cartonato con sovracoperta, colore – 65,00 €
ISBN: 9788828709541
Il British Lion Quality Mark è un simbolo che in Inghilterra viene stampato su ogni singolo uovo e sulle rispettive confezioni e che certifica che il prodotto è rispondente a una serie di standard qualitativi imposti dalle normative britanniche e della comunità europea. Il simbolo riprodotto è, appunto, quello di un leone incoronato colorato di rosso. ↩