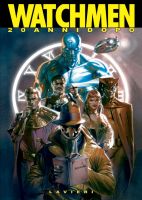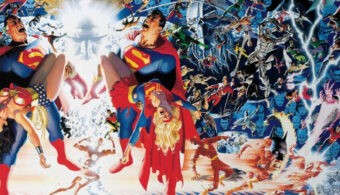Questa fu la prima impressione e ci volle poco per capire che invece dagli Stati Uniti era arrivato un fumetto insolito, culturalmente profondo, inquietante nella sua aderenza a tematiche sociali e politiche senza essere para-ideologico o inutilmente retorico. E per di più raffinato nella costruzione sintattica, nel ribadire la capacità immaginifica e comunicativa dell’arte sequenziale (per usare una terminologia cara a Will Eisner), nel tratteggiare con sapienza un mondo verosimile calcato da personaggi dolorosamente vivi, un’umanità attanagliata dalla paura di una guerra termonucleare risolutrice, nel far respirare il racconto attraverso una narrazione a più voci.
Proprio qui, nella struttura da romanzo corale, sta una delle chiavi di lettura più affascinanti e interessanti del capolavoro di Alan Moore e Dave Gibbons.
Basta scorrere le prime pagine per capire come Moore abbia impostato l’opera su un continuo cambio di soggettiva, sia con diverse voci narranti inserite in didascalie, sia per mezzo di raffinate tecniche narrative. Ad esempio, nella sequenza d’apertura1 si alternano sapientemente presente e passato prossimo e nel dialogo dei due detective, sul luogo del delitto che dà il via a tutta la vicenda, non s’intrecciano solo le loro considerazioni con i flashback di ciò che probabilmente è successo, ma anche i diversi angoli di lettura con i quali interpretarlo. Difatti, le vignette che descrivono l’azione già compiuta non ci mostrano semplicemente quell’azione, ma ce la svelano attraverso gli occhi di uno dei due protagonisti (il misterioso assassino), come se già dal principio gli autori abdicassero nell’indicarci quale sia il proprio metro di osservazione, scegliendo una posizione di neutralità di volta in volta coincidente con il punto di vista di uno degli attori.
Una scelta, così incredibilmente efficace nella sintesi di queste pagine, che sarà una delle peculiarità dell’intero fumetto.
La sensazione è quella di trovarci di fronte ad un fumetto postmoderno dal profondo respiro narrativo supportato da una pluralità di personaggi e di voci narranti, e conseguentemente di tecniche di storytelling al servizio di questi due elementi. Un grande affresco capace anche di guardare oltre la vicenda narrata per mezzo di preziose appendici esterne alle tavole disegnate e per la tridimensionalità di tutto l’apparato culturale, massmediologico, iconografico e popolare di cui tutto il fumetto straborda. Nulla di ciò è sovrastruttura disturbante, ma dà fisicità a quella che è pura finzione. Uno sguardo laterale che ci permette, osservando un particolare, di intuire meglio la totalità.
La consapevole volontà nel giocare sull’alternanza dell’io narrativo e del metodo espositivo suggerisce come per gli autori sia importante che lo sguardo d’insieme venga bilanciato continuamente da una ricerca del particolare che dia profondità e anima a tutto il racconto. L’intelaiatura in dodici capitoli di ventotto pagine ciascuno2 scandite da una griglia, pressoché costante, di nove vignette per tavola, è forse la giustificazione di ciò ed esplicazione di un meccanismo pensato a priori per livellare, su un registro medio, la presenza di così tanti ingredienti.
Partendo dalla considerazione di Watchmen quale romanzo corale in cui molte vicende, svariati personaggi e diverse idee narrative confluiscono in un’unica storia possiamo anche puntare l’attenzione, in una sorta di reverse engineering applicato al fumetto, sugli elementi di cui è composto.
Dietro la maschera
Ovviamente non si può che partire dai supereroi che nel bene e nel male sono i veri protagonisti di Watchmen. Certo, dei supereroi atipici visto che l’unico a mostrare dei superpoteri è il Dr. Manhattan, una figura enigmatica e molto più che semplicemente umana. Post-umano o ex-umano potremmo dire, tenendo conto delle sue origini. Gli altri vigilantes mettono in scena la parte più ambigua di sé stessi, celando il proprio volto dietro una maschera che in un certo modo interpreta ed è derivativa di una società moralmente allo sbando.
Così Rorschach, dietro le macchie da test psicologico da cui prende il nome, nasconde la personalità di un uomo trasformato dalla brutalità del mondo. Vive all’interno di una concezione distorta delle relazioni sociali abbracciando il moralismo più primordiale. Per questo rispecchia, uguale e contrario, la follia lucida e violenta del Comico, anch’esso sconfitto dagli ingranaggi di un sistema tanto incontrollabile da esigere ordine e rigore. Come il resto della società, entrambi fuggono la ragione per ripiegarsi in modi diversi all’interno di un pensiero debole, costruito attorno a canoni culturali e morali arcaici: bene contro male, purezza contro decadenza, rettitudine contro devianza; ma anche occhio per occhio e violenza per combattere la violenza.
Uno, il Comico, asservito all’autorità politica perché bisognoso di essere guidato e di avere un ruolo da protagonista all’interno delle dinamiche del potere; l’altro, Rorschach, ribelle e individualista, al servizio di un’immagine distorta di giustizia, ma aggrappato comunque a un’idealità superiore e non para-nichilista come quella del Comico.
Se gli eroi del passato, ormai prepensionati, con i propri costumi sgargianti sembrano essere in netta asincronia con la plumbea realtà sociale e politica che si sta profilando all’orizzonte, allora in questo senso Rorschach e il Comico capiscono prima degli altri che il vento è cambiato e che per non essere ridicoli o fuori dal tempo bisogna scivolare nella violenza fascista e servile. Oppure nella schizofrenia, anticipando di molto i dubbi e le angosce che i loro colleghi proveranno in prima persona. Un cambiamento manifesto nelle azioni, sempre più violente e crudeli, quanto nell’indossare maschere e costumi sempre meno lindi e colorati. Una mutazione genetica dell’eroe che già si prospettava in tutta l’editoria mainstream (e non) americana, figlia della disillusione e del riflusso politico degli anni Ottanta e di un pessimismo che a volte sconfinava nel reazionario.

Se ci sono dei messaggi politici in Watchmen (e sono convinto che ci siano) questo è uno dei più rilevanti, ossia il voler ricondurre il malessere di una civiltà allo sbando soprattutto alla situazione politica giostrata da governanti senza scrupoli, come le figure di Nixon e Kissinger ancora in carica a metà Ottanta sembrano suggerire.3
Veidt incarna il demiurgo moderno che con il suo intelletto e il suo potere riesce a plasmare le pulsioni e i desideri della parte della società più esposta ai media4 e contemporaneamente imbastisce un complotto il cui schema è (quasi) impossibile da svelare, nascosto com’é in un intricato sistema di scatole cinesi.
Veidt e il Dr. Manhattan in un certo modo sono simili, tanto è vero che i due provano particolare stima reciproca. Entrambi basano la propria esperienza sulla consapevolezza di sé e sulla conoscenza dei meccanismi che fanno girare il mondo, di fronte ai quali il Dr. Manhattan si attribuisce comunque una posizione di spettatore (per via anche della sua condizione non-umana) mentre Veidt, prevedendo un infausto finale, interviene pesantemente per alterarne le dinamiche e condizionare le conseguenze.5
Non tutti i personaggi in calzamaglia che popolano questo romanzo a fumetti hanno specificità così complesse, ma è pur vero che mai ci troviamo davanti dei character bidimensionali. I vigilantes del passato, che scopriamo man mano per mezzo di sofisticati flashback, avevano di certo un approccio meno problematico alla propria “carriera” di eroe e per il semplice fatto d’essere vestigia di un’epoca più semplice e decifrabile sono manifestamente inadeguati al presente di Watchmen.
Non solo in conseguenza di una lettura anacronistica della società, ma anche per via dell’apparato iconografico di cui sono portatori.
Non è casuale che due dei personaggi chiave di tutta la vicenda, Nite Owl e Silk Spectre, sia nelle loro vesti private sia nei costumi che indossano di nuovo dopo un lungo periodo, meglio di tutti gli altri vivono sulla propria pelle il cambiamento tra la Golden Age dei primi supereroi e il riflusso del nuovo ordine. A differenza di Rorschach, del Comico, di Ozymandias che da tale cambiamento di condizione vengono influenzati, essi tentano di adeguarsi allo spirito del tempo, ovviamente non riuscendoci, inadatti comunque al ruolo che si impongono sia nell’indossare o nel dismettere la maschera. La loro scelta di ribellarsi a una condizione più subita che accettata è un atto forte, che scombina le carte di una vicenda dal finale già scritto.6
separatorearticoloL’uomo della strada
Accanto al colorato cast di vigilantes passati e presenti, nel mondo creato da Moore e Gibbons non c’é il “vuoto” o scenari apparentemente sfocati. Questi personaggi sono solo una parte degli attori che recitano sul palcoscenico di Watchmen, tanto che l’uomo della strada, il giornalaio, lo psichiatra, i detective hanno la stessa importanza dei personaggi principali, così come accade nella vita reale. Anzi, la coralità dell’impianto narrativo è qui che ha il suo più efficace sviluppo. Infatti, per mezzo di comparse più o meno ricorrenti la narrazione acquisisce un respiro che altrimenti
non avrebbe. Abbiamo già fatto cenno, in questo senso, alla prima sequenza in cui i due detective che investigano sulla morte del Comico si scambiano una serie di considerazioni sul delitto. Se analizziamo più a fondo la loro conversazione ci accorgiamo come Moore in poche battute riesca ad informarci che i vigilantes da qualche anno sono stati messi fuori legge, introducendo così uno dei temi più importanti di tutto il plot. Quindi, facendo parlare o agire delle comparse (o poco più) Moore riesce a creare uno sguardo d’insieme, un enorme puzzle sociologico-politico, che in altri fumetti o romanzi avrebbe avuto bisogno di ridondanti quanto necessarie spiegazioni.
La presenza costante di questi contributi ci suggerisce ancora una volta come il romanzo sia strutturato sempre sulla ricerca dell’effetto dicotomico tra la vicenda singolare e l’affresco generale. Senza che ciò porti a una frattura nell’andamento narrativo, che risulta essere strutturato come un intricato thriller in cui tutti i pezzi, man mano che ci vengono svelati, alla fine andranno semplicemente al loro posto.
In fondo, negli sproloqui tra il malinconico e il pessimistico del giornalaio che compare all’inizio del Capitolo III riceviamo molte delle informazioni necessarie per comprendere meglio l’intera vicenda, ma allo stesso tempo capiamo anche maggiormente lo scenario sociale in cui si sviluppa. Lo stesso accade nelle “comparsate” dell’editore reazionario del New Frontiersman con la sua lettura della situazione politica mondiale;7 o nel Capitolo VI, nella vicenda dello psichiatra che cerca di curare Rorschach, rivelatrice non solo del passato del vigilante, ma anche della società borghese che popola il mondo di Watchmen.
Storie dal villaggio globale
La pluralità delle voci messe in campo da Moore e Gibbons permette quindi agli autori di creare un’opera profondamente stratificata. Nel supportare ulteriormente questo intendimento, all’interno di ogni capitolo (ma anche parallelamente in forma di appendice) viene inserito un enorme ed elaborato apparato iconografico e massmediologico, tanto vasto, particolareggiato e credibile che risulta molto più che un utile corollario di fianco al quale far recitare tutti gli attori. Potremmo
anche pensare che le pubblicità dei prodotti Veidt, la presenza della televisione, il fumetto di pirati che il ragazzino legge all’edicola, i quotidiani che in un crescendo esasperato annunciano l’apocalisse, il romanzo del primo Nite Owl più volte citato, contribuiscano tutti con pari forza alla coralità della narrazione. Anzi, sono in realtà il substrato ideologico, culturale e materiale senza il quale Watchmen non avrebbe potuto in alcun modo colpire con tanta forza l’immaginario di una generazione.
Tutti questi elementi descrivono e fanno pulsare di vita vera l’immagine di una società culturalmente complessa e al lettore provocano un piacevole effetto vertigine, stimolato com’é da continue citazioni autoreferenziali e da una moltitudine di particolari a prima vista poco importanti. Merito anche dell’abilità narrativa e della perizia grafica di Dave Gibbons se tutto ciò risulta omogeneo e funzionale al racconto e per certi versi complementare allo svolgimento della trama.
é così per le preziose appendici in fondo ad ogni episodio che indirizzano il racconto su un piano differente. Se infatti all’interno del fumetto la storia, benché articolata, segue uno svolgimento pressoché “orizzontale” (inizio, svolgimento e conclusione), queste appendici possiamo considerarle come una narrazione che devia in verticale e che estrapola diversi aspetti del racconto per meglio approfondirli.

Sopra tutto svetta Storie del Vascello Nero, il fumetto dentro il fumetto, che dall’inizio del Capitolo III ci accompagnerà per quasi tutto il volume, generando una vera e propria narrazione parallela spesso giocata su contrappunti con la storia principale. La vicenda di un unico sopravvissuto all’assalto di una nave pirata, che per riprendersi la vita che gli è stata tolta sprofonda nel delirio e nella paranoia, la si può leggere come una chiara allegoria di quello che sta succedendo nel mondo di Watchmen, tanto è vero che la reazione di questo fantasioso personaggio è paragonabile alla deriva patologica di Rorschach e del Comico, e in parte con la lucida follia che ispira la “soluzione finale” messa in atto da Veidt.
Insomma, il villaggio globale nel mondo di Watchmen, sia esso rappresentato da un quotidiano o dalla televisione accesa in sottofondo, da una musica appena accennata o da un cartellone pubblicitario che fa capolino in una vignetta, a sua volta è il protagonista di un’altra storia nella storia che deve essere raccontata: quella di una società articolata e per certi versi simile alla nostra, i cui eccessi, i desideri, le spinte emotive e le devianze sono probabilmente causa ed effetto della presenza di tanti eroi mascherati.
Il diario di R.
é abbastanza evidente come l’ambigua figura di Rorschach prevalga su tutte le altre nel dare un sostanziale contributo nel raccontarci ciò che si sussegue dalla morte del Comico in poi. Già dalla prima pagina, attraverso un uso massiccio di didascalie, parrebbe narrarci una sua versione, una diversa lettura di ciò che sta accadendo filtrata dalle macchie della sua maschera. Sembrerebbe quasi adottare uno di quei monologhi interiori prepotentemente entrati di moda in quegli anni nei comics americani,12 anche se in realtà Rorschach parla a sé stesso attraverso il suo diario in
cui annota i propri pensieri e le proprie impressioni.
Questo esprimersi in lunghi stream of consciousness è l’arma principale con la quale Moore mette in scena la coralità della sua narrazione, che acquisisce in questo modo movimenti carsici, accelerazioni, rallentamenti. è così quindi per il lungo peregrinare nella memoria e nella propria coscienza da parte del Dr. Manhattan nel suo esilio su Marte13 o per le considerazioni dello psicologo che per analizzare Rorschach perde di vista il proprio equilibrio e quello del suo matrimonio.14 Le altre didascalie, e Moore ne usa in abbondanza, sono più che altro delle voci fuori campo che hanno comunque la capacità di raccontare squarci del passato determinanti per una migliore definizione del contesto narrativo.15
Il differente uso delle didascalie divide quindi i personaggi tra chi con diverse modalità svela i propri pensieri (Rorschach e il Dr. Manhattan) e chi (Veidt, Dreiberg, Jupiter…) invece è solo osservato dall’esterno o al massimo viene raccontato attraverso le considerazioni dei primi.
Il diario di Rorschach è sicuramente l’unica voce in didascalia che ci accompagna lungo tutta l’opera e la sola che si impone al di là di ogni singolo episodio narrato, riuscendo nell’impresa di legare tutto con il suo contorto, ma puntiglioso annotare.
Vera voce di una coscienza deturpata dalla decadenza morale di una società in preda alla nevrosi pre-nucleare, scompare con la morte del suo autore nel momento in cui il mondo si ricompatta su valori eteroindotti, quasi non avesse più uno scopo, niente e nessun altro da raccontare.
Anche se nel finale riecheggiano altre parole, quelle del Dr. Manhattan: “Niente ha mai fine.”
Note
1 Watchmen, Capitolo I, tavola 2 e 3.
2
3
4 Si vedano i continui riferimenti ai prodotti della linea Veidt sparsi per tutto il volume, dai profumi ai giocattoli, alla sua presenza sui media, quasi per far intuire al lettore, la sua capacità pervasiva e contemporaneamente mantenere l.aurea di benefattore o membro emerito della comunità.
5 Emblematica, a questo proposito, la scena in cui Ozymandias, nel suo rifugio in Antartide, attraverso decine di monitor osserva contemporaneamente i media di tutto il mondo per capire in anticipo le tendenze e i possibili sviluppi politici e sociologici (Watchmen, Capitolo X, tavola 8).
6 Watchmen, Capitolo VII, tavole da 19 a 21.
7 id, Cap. VIII, tav. 10; Cap. X, tav. 24; Cap. XII, tav. 32.
8 Il romanzo Sotto il cappuccio e firmato da Hollis Mason, alias Nite Owl I, in appendice ai Capitoli I, II e III.
9 In appendice ai Capitoli VIII, IX, XI.
10 Appendice al Capitolo VI.
11 Appendice al Capitolo X.
12 Si veda per esempio Wolverine di Chris Claremont e Frank Miller (Marvel Comics, 1982).
13 Watchmen, Capitolo IV.
14 Watchmen, Capitolo VI.
15 Si veda in proposito nel Capitolo II come i ricordi della madre di Silk Spectre, del Dr. Manhattan, di Adrian Veidt e di Dan Dreiberg durante il funerale di Edward Blake diventino veicolo per sondare a larghe falcate il passato dei Minutemen e il loro rapporto con il defunto. In questo senso i loro ricordi assumono l’importanza di veri e propri soggetti narrativi.
Tratto da “Watchmen 20 anni dopo”, edita da Lavieri nel 2006.
Potete leggere gli interventi di Dez Vylenz, Mike Carey e Michael Moorcock (tutti in lingua Inglese) comparsi sullo stesso volume ai seguenti indirizzi:
Ringraziamo smoky man e Lavieri editore per aver concesso la pubblicazione di questo articolo.