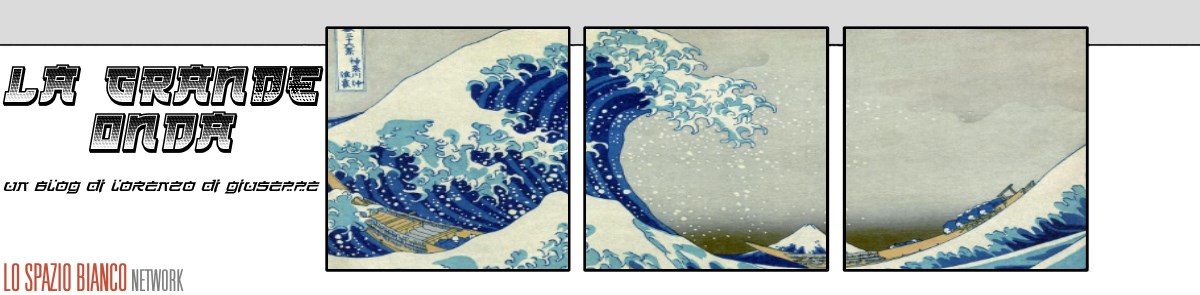Nel 2020, Corentin Garrido, traendo ispirazione da un saggio dello studioso e traduttore Ryan Holmberg sulle linee cinetiche nei gekiga, ha completamente rivoluzionato il volume 6 di Astroboy di Tezuka Osamu, mantenendo solamente le linee cinetiche e i simboli grafici ed eliminando tutto il resto, offrendo così una prospettiva nuova e stimolante non solo su quest’opera, ma in generale sul fumetto tutto. Questo perché il gioco di linee e segni sulla pagina evoca immediatamente sia il dinamismo creato da Tezuka sia la potenza espressiva e comunicativa intrinseca in ogni segno.
Nell’analisi chi segue si tenterà di esporre in modo strutturato e ragionato quanto il concetto di linee cinetiche nella tavola di un fumetto giapponese sia affine a quello di ley lines (le cosiddette “linee temporanee”, “linee geomantiche” o “linee geomagnetiche”) nello spazio fisico di alcuni luoghi.
Ovviamente, alla base di questo articolo non c’è nessuna ideologia new age o antiscientifica, ma semplicemente l’intenzione di adottare nuovi metodi d’indagine nell’approfondimento del fumetto giapponese, con il proposito di stimolare ulteriori studi e ricerche che applichino approcci anticonvenzionali o alternativi nel momento in cui si prendono in considerazione i manga.

Un accenno storico sulle ley lines
Le ley lines vengono considerate dagli esperti del settore allineamenti rettilinei che collegano idealmente punti geografici di rilievo e strutture storico-archeologiche di diverso tipo. Esse consentono di scoprire e tracciare traiettorie occulte, che secondo alcuni formano una rete di antiche piste attraverso il paesaggio che interconnettono punti di importanza sacra o semplicemente storica((James Thurgill, “A Strange Cartography: Leylines, Landscape and ‘Deep Mapping’ in the Works of Alfred Watkins”, humanities, No. 4, 2015, pp. 637-638.)).
Questo concetto è stato teorizzato da Alfred Watkins (1855-1935) nel 1921. Watkins, archeologo autodidatta e antiquario, mentre si trovava nell’Herefordshire per raccogliere documentazione scritta e fotografica, notò che antichi monumenti, fortezze, villaggi pre-romani, chiese, alberi e molti altri luoghi e oggetti sembravano allineati in modo inequivocabilmente intenzionale: lunghe tracce rettilinee sembravano incidere il loro percorso attraverso il paesaggio e Watkins attribuì la causa di queste linee all’età dei monumenti che le segnavano, riconducendo tutto all’uomo primitivo. Quella di Waktins non era tanto la scoperta di una “genealogia magica” dei luoghi – seppur si presentava come un primissimo tentativo di geografia alternativa, che mirava a unire gli studi sullo spazio e sull’ambiente con quelli sull’occulto – quanto una ricerca finalizzata a indicare le ley lines come un sapere antico e dimenticato, o meglio come un insieme di saperi, perduti ma immanenti. Watkins insisteva sul fatto che tale conoscenza fosse incorporata nel paesaggio, lasciata a noi da scoprire. Nei suoi termini, quindi, la scoperta delle ley lines, in ogni posto del mondo, sarebbe stata un modo di ripercorrere la storia, per svelare le narrazioni dietro ai luoghi e ripensare il paesaggio, un modo particolare di conoscere i luoghi e di sviluppare una biografia per essi e su di essi((Thurgill, “A Strange…”, pp. 639-640.)).
Secondo Watkins le ley lines appartengono a quella classificazione in cui le linee sono generate attraverso un processo di produzione; tracciano connessioni tra gli oggetti antichi e li legano al paesaggio e, in quanto tali, sono valorizzati da qualcosa di molto più che una semplice indicazione di scala, distanza, direzione o destinazione. In quanto linee, le ley lines forniscono un significato e suggeriscono che i nostri antenati conoscevano la terra che li circondava in un modo che molti ritengono sia andato perduto nell’esistenza urbana contemporanea. Esse arricchiscono la storia attraverso l’approfondimento della nostra interrelazione con il mondo naturale e, cosa ancora più importante, forniscono un modo per rientrare nel paesaggio, per mappare, ripercorrere, reimmaginare e far risorgere la nostra posizione all’interno e tra i luoghi. Le ley lines implicano un significato nascosto presente tra i luoghi; indicano un movimento tra le sfere, aree che un tempo potevano apparire come il milieu ostile di uno spazio altrimenti astratto. Possono essere viste come un modo per dare un senso alle cose, per fornire chiarezza attraverso la creazione di una mappatura ravvicinata o “profonda” del paesaggio((Thurgill, “A Strange…”, pp. 641.)).
Le ley lines, quindi, non sono solo una “scoperta”, ma altresì un metodo di ricerca, un concetto strutturale utile a mappare un territorio o un immaginario, come verrà spiegato più approfonditamente nel successivo paragrafo. D’altronde, come sa chi si occupa di narrazione, le storie possono riecheggiare e rifrangersi attraverso la, e accanto alla, storia scientifica dell’umanità((Gordon White, Star.Ships: A Prehistory of the Spirits, Scarlet Imprint, 2016, p. 9.)). Nel mondo pre-moderno, quando le persone scrivevano riguardo al passato erano più concentrate su cosa aveva significato un determinato evento. Il mito era un evento che accadeva una sola volta ma che, in qualche modo, era destinato a ripetersi per sempre e la mitologia diventava una forma d’arte che superava la storia e andava a evidenziare ciò era senza tempo nell’esistenza umana((White, Star.Ships…, p. 105.)). Il mito, nel suo essere intrinsecamente camaleontico, funziona in opposizione alla religione, che è monolitica e dogmatica: dove il mito incoraggia un ampio spettro di credenze, il dogma restringe il campo entro stretti limiti. L’abilità del mito è quella di tenere aperte le porte dell’immaginazione all’interno di un framework costrittivo((White, Star.Ships…, p. 298.)).
Negli ultimi anni sono molti i media che hanno esplorato il rapporto tra mitologia, percorsi di conoscenza ed esplorazione alternativi e “magici” e mappatura dell’immaginario. Uno di quelli che mi sento di citare brevemente è Moon Hunters (2016), videogioco sviluppato e pubblicato da Kitfox Games, che cerca, attraverso il gameplay, il lavoro artistico su character design e background, il worldbuilding, la colonna sonora e una narrazione non lineare, di mettere al centro le storie e del loro ruolo nel plasmare il mondo. Per quanto sia possibile trovare alcuni difetti, è un progetto animato dalla voglia di raccontare qualcosa di diverso e dalla volontà di creare un’atmosfera mitologica ma accogliente, dove la ripetizione e il caso diventano sigilli da rompere per accedere al cuore del gioco e della propria esperienza emotiva.
Il legame tra ley lines e linee cinetiche
Fatta questa breve introduzione, credo che possa cominciare a essere più chiaro quale sia il legame tra ley lines e linee cinetiche nei manga. Così come le prime permettono di mappare un territorio, le seconde permettono di mappare una pagina a fumetti. Movimenti e flussi di energia, visivi, concettuali e ipotetici, vengono coinvolti grazie a entrambe, permettendo inoltre di scoprire le direttive occulte che muovono l’immaginario legato alle rispettive controparti fisiche. Eccola, quindi, la vera connessione tra le due: la possibilità di mappare e cartografare territori di qualsiasi tipo, che siano pianure o pagine, ridefinendo i confini dell’immaginario. Questo è esattamente ciò che ha fatto Corentin Garrido con Astroboy 6, cioè provare a descrivere la forza grafica ed emotiva e la dinamicità del segno di Tezuka spogliandolo dei disegni stessi per veicolare diversi aspetti, che combinano qualcosa di definibile come “movimento puro” ed “emozione pura”, evocando un preciso immaginario per ribaltarlo e, allo stesso modo, ridefinire la funzione delle singole vignette e della pagina. Le linee cinetiche permettono di leggere una pagina (o più pagine) di un manga attraverso modalità inedite, scatenando reazioni che sono allo stesso tempo inconsce e perfettamente razionali: rendere visibili diversi tipi di movimento significa per l’autore mettere a disposizione un set grafico collaudato e di immediata comprensione, ma altresì permette al lettore di generare movimento partendo da qualcosa di fermo, ovvero di generare la vita dalla morte. Per questo le linee cinetiche possono essere le ley lines dei fumetti, perché inglobano la doppia energia di autore e lettore, guidando alla costruzione di pagine dinamiche e alla lettura partecipata. Come è ovvio che sia, non tutti gli autori e le autrici riescono perfettamente in questo intento, e ancora meno sono quelli o quelle che donano un apporto originale alla materia, così come non tutti i lettori apprezzano certi tecnicismi.
Holmberg scrive che, come ogni lettore di manga d’azione dagli anni Sessanta in poi sa perfettamente, la caratteristica distintiva delle linee cinetiche nei fumetti giapponesi contemporanei è la loro comune apparizione come un campo di linee ravvicinate, quasi parallele o a raggiera. Naturalmente si usano anche sottili scie o fasci di linee e altro ancora, ma ciò che è incisivo è spesso l’immagine delle linee cinetiche che riempiono un’intera vignetta, trascendendo la loro funzione di tracce di un movimento passato o progressivo e raggiungendo una multifunzionalità che può, allo stesso tempo, indicare il movimento fisico dei corpi, esprimere il movimento “nervoso” (cioè del sistema nervoso) delle menti e delle emozioni, focalizzare visivamente l’occhio del lettore su elementi grafici prescelti e integrare il design delle pagine (e persino di intere opere) attraverso un modello quasi-geometrico condiviso((Ryan Holmberg, “The Eye and the Storm: Speed Lines and Gekiga FX”, International Journal of Comic Art, Vol. 15, No. 2, 2013, pp. 394-395.)). Per questo, negli esempi più felici, invece di vedere le cose muoversi, il lettore percepisce di osservare il “movimento stesso”.

Se si prende Akira (1982-1990) di Ōtomo Katsuhiro (1954-), in molte pagine e vignette si può notare che, quando i personaggi si muovono su veicoli, le linee cinetiche più che circondare i soggetti o dirigersi verso essi – eventi che di tanto in tanto si verificano comunque – creano una sorta di pavimentazione o tunnel della velocità, che permettono ai personaggi di viaggiare sopra le linee cinetiche o immersi in esse. Questa è senza dubbio una delle rivoluzioni grafico-concettuali portate al grande pubblico dall’autore giapponese con la sua opera più famosa, un elemento che meriterebbe di essere preso in esame come caso di studio singolo, ma sono diversi gli esempi più recenti che si discostano dalla mera imitazione di un modello paradigmatico come Akira per adottare soluzioni innovative.
Nella due serie Levius (2012-2015) e Levius/est (2015-2021), l’autore Nakata Haruhisa, utilizza le linee cinetiche solo negli scontri fisici, ma in due modi differenti: inglobandole nei corpi dei combattenti per enfatizzare il movimento degli stessi e la forza dei colpi o disegnando onde d’aria/calore per segnalare il surriscaldarsi dell’atmosfera provocato dai duelli (fattore che si presta bene alla serie dall’impianto narrativo steampunk). Il primo tipo di uso credo sia particolarmente rilevante, perché sposta la visualizzazione del movimento da “verso i corpi” a “nei corpi”, cercando di rendere evidente quanto la velocità non sia solamente qualcosa di percepito o percepibile, ma diventi effettiva perché espressa attraverso la sua aderenza a un organismo fisico, che scatena determinati impatti e reazioni. Sicuramente, questo è possibile grazie al segno e all’impostazione di Nakata, che si rifanno molto al fumetto europeo e rendono possibili espressioni (e teorizzazioni su di esse) differenti rispetto alla maggior parte del fumetto mainstream giapponese((È interessante notare come sia Ōtomo che Nakata, di generazioni diverse, non manchino di palesare influenze europee nei loro fumetti, e che entrambi siano giunti, il primo in maniera più incisiva e il secondo probabilmente meno, a portare una certa freschezza nell’uso delle linee cinetiche. Anche Fujiwara Kamui (1959-) utilizza soluzioni simili a quelle di Ōtomo (ringrazio per l’iniziale segnalazione Matteo Caronna di Terre Illustrate), ma ha affermato in un’intervista che la sua ispirazione non viene dall’autore di Akira ma da Moebius, che è poi anche per lo stesso Ōtomo e per Nakata un deciso punto di riferimento. Sembra quindi che ci siano delle connessioni tra innovazione grafica nelle linee cinetiche nei manga e fumetto europeo, connessioni da esplorare e approfondire debitamente.)).

Se si guarda al manga alternativo e sperimentale, un nome che viene subito in mente per le innovazioni grafiche impiegate è Yokoyama Yūichi (1967-). Yokoyama non solo ha rivoluzionato l’uso delle linee cinetiche, ma ha fatto un passo oltre rendendo “movimento” il suono, con un lavoro mastodontico sulle onomatopee, la loro resa grafica e uditiva. Per le linee cinetiche, come sottolinea sempre Holmberg in un suo articolo per il The Comics Journal, già da Il viaggio (2006, in Italia per Canicola Edizioni nel 2011) Yokoyama sceglie di considerare il cinematismo nel fumetto come un’attività che coinvolge non solo immagini in movimento, ma anche occhi in movimento. Il viaggio, un wordless manga ambientato quasi interamente su un treno ad alta velocità simile allo shinkansen giapponese, è particolarmente significativo in questo senso perché, attraverso il concetto di cinematismo, apre a riflessioni feconde. Thomas Lamarre, nel suo libro The Anime Machine: A Media Theory of Animation, riflette sul cinematismo sostenendo che la visione attraverso il finestrino del treno, che coinvolge il treno stesso come un apparato teorico e fisico diverso dal cinema, pone l’accento su velocità e movimento. Inoltre, l’autore si sofferma sul fatto che l’essenza del cinematismo risieda nell’uso di apparati mobili di percezione, che servono sia a dare allo spettatore la sensazione di trovarsi al di sopra del mondo e quindi di controllarlo, sia a far crollare la distanza tra spettatore e bersaglio, alla maniera della logica balistica del colpo istantaneo((Thomas Lamarre, The Anime Machine: A Media Theory of Animation, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2009, p. 5.)). Yokoyama, molto più che negli altrettanto complessi Baby Boom (2009) o World Map Room (2013), porta agli estremi questa soluzione, facendo collassare occhio e movimento sulla pagina, muovendo l’occhio del lettore attraverso prospettive impensabili, giocando con la sequenzialità del fumetto, e allo stesso tempo facendolo scontrare con il movimento tecnologico, velocissimo e inafferrabile del treno, reso con linee cinetiche geometriche, dense e onnipresenti che si impongono sulla visione sovrastandola e dichiarando il dominio della velocità e del “movimento puro” sulla visione.

Conclusioni
In conclusione, riassumendo quanto detto in precedenza, si può affermare che ley lines e linee cinetiche nei manga condividano alcune caratteristiche: mappano il territorio di riferimento (terreni o pagine), rendono possibile di leggere i suddetti territori in modi inconsueti e singolari e stimolano riflessioni sotterranee sull’immaginario che le ingloba attraverso il mezzo che utilizzano. Mi è parso interessante vedere i sottili legami che uniscono Tezuka ai videogiochi, Garrido a Yokoyama, il tutto passando per ley lines e linee cinetiche: è proprio come se tutto fosse connesso, anche se è probabile che siano soltanto salti mortali interpretativi. Gli esempi utilizzati non sono certamente esaustivi per uno studio delle o sulle linee cinetiche, ma sono stati scelti per la loro relativa vicinanza temporale. Visto che ogni caso specifico potrebbe sicuramente meritare una trattazione a parte, la speranza è che queste riflessioni possano portare a tentativi di studi originali – come d’altronde lo è questo, un tentativo – che amplino i discorsi critici in Italia intorno al fumetto giapponese, spesso in balia di superficialità, aneddotica e mancanza di approfondimento, in particolare riguardo alla parte grafico-visuale. I propositi sono sempre quelli che animano questo blog in generale, ovvero spingere ad analisi che scandaglino le opere senza accontentarsi di riflessioni superficiali, ma provino, anche azzardando interpretazioni astruse o teorie avventate – come sto facendo in questo caso – a scuotere la critica rompendone le coordinate date per certe. La scelta di questo tipo di comparazione, forse leggermente audace in certi termini, deriva dal mio interesse personale non solo verso entrambi gli argomenti, ma anche verso la volontà di costruire uno spazio più aperto rispetto alle solite e riciclate formule della critica letteraria, spesso erroneamente prestata al fumetto.