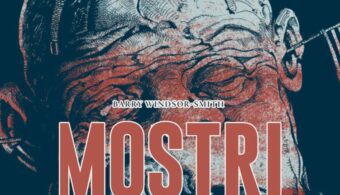Perché l’autobiografia è noiosa?
L’autobiografia è un esercizio comune. Si può dire che chiunque abbia scritto sulle pagine di un diario personale e segreto abbia messo mano alla propria autobiografia. E non possiamo saperlo, ma qualcuno ha sicuramente letto stralci di quelle parole prelevando il manoscritto da quello che credevamo essere il nascondiglio perfetto!

Ci sono molti segreti dietro a un romanzo di successo, ma ci sono pochi segreti dietro a un’autobiografia. Se vi interessa scoprire i più importanti, leggete il fiume in piena che è L’opera Struggente di Un Formidabile Genio di Dave Eggers. Pur con i suoi alti e bassi, l’approccio meta-letterario del romanzo ci offre un’opera unica, curiosa e divertente; struggente in alcune parti – Eggers non ci inganna del tutto – volutamente leggera e travolgente in altre, quasi per timidezza verso la propria tragedia familiare.
L’atto di scrivere un racconto autobiografico porta con sé il peso della testimonianza. Certo, come ci suggerisce Eggers, è possibile leggere le autobiografie fingendo che non parlino di vita reale, trasformando così l’opera per qualche strana ragione in qualcosa di più interessante e degno di essere letto!
Perché è opinione abbastanza comune che le autobiografie siano generalmente noiose. In effetti, apparentemente, i racconti di questo tipo non possono lasciare troppo spazio all’immaginazione; non vi si possono narrare cose troppo strane o irreali, pena l’incredulità del lettore. Un’autobiografia deve essere per qualche verso aderente alla realtà dei fatti, anche se rivisti e reinterpretati dalla sensibilità e dalla memoria dell’autore.
Questa essenza parzialmente minimalista rende alcuni tentativi ripetitivi e poco coinvolgenti. Oltre cioé alla possibilità di riconoscersi in certe esperienze comuni, viene quasi da chiedersi “Perché quello che mi racconti dovrebbe essere minimamente interessante? Pensi di aver avuto una vita più importante di me?”. Personalmente, in generale, apprezzo di più romanzi di “fantasia” nei quali l’autore mostra la sua vita e la sua esperienza celata da avvenimenti e situazioni evidentemente false. Ma alcune autobiografie funzionano. E il fumetto, perché di questo si vuole parlare, si è più volte dimostrato un mezzo efficacissimo per raccontarle.
Scegliere di raccontarsi

Quegli stessi eventi dovrebbero inoltre apparire interessanti per una persona che decide di leggere quel racconto. Per queste ragioni, la verità di cui si parla nasce dalla necessità di raccontare quella specifica storia agli altri, e di rappresentarsi a se stessi come atto di rivelazione: ovvero, ogni processo autobiografico è per prima cosa un processo conoscitivo.
Tutto nasce da una pagina bianca, da un foglio da disegno bianco. O da un manto di neve incontaminato, sul quale per primi, al mattino presto, decidiamo di lasciare le nostre impronte. Con “suoni visivi” speciali, Craig Thompson scrive e disegna Blankets, tra un lavoro temporaneo e un altro, a fare panini e mangiare scarti lasciati dai clienti, ospite in casa di amici, determinato a lasciare una sua personale traccia nel panorama più che mai contaminato del fumetto statunitense, e non solo; spinto da un’emozione fortissima che diventa forza di volontà, espressa a parole e soprattutto a disegni nelle ultime pagine del volume:
“Che soddisfazione lasciare un segno su una superficie bianca. Fare una mappa dei miei movimenti… anche se è soltanto temporanea”.
Blankets è un romanzo a fumetti di quasi 600 pagine edito dalla Oni Press. È stato un successo clamoroso in USA, in Francia e anche in Italia fin dalla sua prima pubblicazione Coconino Press. Descritto come un “monumento alla vita quotidiana”, è in realtà un tipico romanzo di formazione, che si sofferma soprattutto su alcuni mesi dell’adolescenza di Craig, con parecchi flashback dell’infanzia e una parte conclusiva di un passato meno remoto, quando l’autore, raggiunti i vent’anni, si allontana dalla casa dei propri genitori e dallo sperduto paesino del Wisconsin in cui è nato.
Il titolo ha una duplice traduzione. Letteralmente “blankets” significa “coperte”, ma in senso figurato può significare anche “manto di neve”, “nevicate”. Entrambi i significati hanno rilevanza nel testo: il “feticcio” ricorrente del romanzo è infatti una coperta cucita da Raina, primo vero amore di Craig, musa ispiratrice dell’autore e vero fulcro intorno alla quale ruota tutta la storia; la neve – bianca e incontaminata per la maggior parte del racconto, sporca e fangosa nell’ultima parte – è l’elemento atmosferico che ammanta tutta la vicenda, che circonda i protagonisti, i loro umori e le loro vite.
Quando Craig Thompson pubblica Blankets ha trent’anni. Contando anche i circa tre anni di lavorazione, è passato relativamente poco tempo dagli avvenimenti raccontati nel volume. Non è lecito aspettarsi quindi un profondo “riassorbimento” di quelle esperienze, una rielaborazione sostanziale di quelle emozioni.
Per queste ragioni, Blankets ci appare come un racconto quasi “diaristico” in certe parti, minimalista, concreto.

Perché questa forza può facilmente ribaltarsi e diventare debolezza.
Nei racconti del suo primo incontro con Raina, della sua visita presso la casa dei genitori di lei, dei primi baci, del tormento e del senso di colpa dovuto all’educazione profondamente cattolica dei suoi genitori… in ognuno di essi si sente la vicinanza emotiva di Craig, le ferite ancora aperte. La semplicità con la quale l’autore guarda e ci mostra quei fatti può sembrare spesso ingenua, priva com’è di una qualsiasi apparente interpretazione. Ma Craig è più bravo di quanto può sembrare a prima vista.
Non lasciamoci ingannare, perché l’autore in realtà scrive assecondando un’urgenza comunicativa fortissima, che riesce a travalicare qualunque perplessità del lettore.
Chiediamoci, con umile disposizione, perché Craig Thompson ha deciso di raccontarsi, e facciamo un passo indietro. Esiste un’altra caratteristica essenziale dell’autobiografia della quale non ho ancora parlato. Chi decide di raccontarsi lo fa sempre con uno specifico, chiarissimo proposito, un progetto che è giustificazione del racconto ma, soprattutto, della propria esistenza. Come per una dimostrazione, l’autore ha un punto da elevare a principio di vita, un vertice significante in grado di porsi come motivo essenziale della sua vita, che deve diventare (auto)evidente al termine del racconto, necessario.
Qual è il principio di Blankets? Cosa vuole dimostrare, a sé e agli altri, Craig Thompson?
Ce lo sottolinea nelle ultime, splendide pagine, ma già ne parla in diverse occasioni nelle pagine precedenti: egli è nato per raccontare per immagini. Craig è, per costituzione e per necessità esistenziale, un autore di fumetti. La sofferenza e l’incomprensione bigotta della famiglia, l’amore fortissimo per Raina, luce superiore di bellezza e armonia, il confronto personale con la religione cattolica hanno messo ripetutamente alla prova questa necessità, questo dono divino, verrebbe da dire, fino alla sua naturale affermazione come atto di vita irrinunciabile.
Ogni incontro di vita, ogni esperienza, è per Craig occasione, spunto per tracciare delle orme nella neve, senza pudore e pace (esattamente come Eggers che, una volta deciso di raccontarsi, ha girato per mesi con un registratore portatile nel quale incidere i pensieri e gli avvenimenti prima che mutassero in ricordi). L’atto divino della creazione, in questi gesti espressivi e liberatori, diventa accessibile all’uomo e alla sua parzialità. è questo il messaggio fortissimo di Blankets: Craig ci mostra come sia giunto alla consapevolezza della sua vocazione terrena, ovvero raccontare per immagini.
Impronte nella neve
Analizzate le ragioni intrinseche del racconto, vorrei ora spostare l’attenzione sullo stile utilizzato dall’autore e capire dove il medium fumetto risulta vincente nel raccontare un’autobiografia.

Per quasi trent’anni, Eisner ha affinato l’arte della recitazione dei personaggi, dello story-telling, con la finalità specifica di rappresentare la quotidianità dei quartieri di una certa New York City. Il suo tratto è unico e inconfondibile ed è diventato un punto di riferimento imprescindibile per molti autori, americani e non.
Craing Thompson è uno di essi, senza dubbio. Il tratto spesso, l’ariosità delle tavole, il dinamismo dei gesti, l’ironia che aleggia in tutto il racconto, l’equilibrio efficace tra realismo e segni iconici del giovane autore nascono da uno studio approfondito di Eisner che non si traduce in semplice copia, ma in rielaborazione personale.
Ma Thompson fa propria la lezione anche di altri autori, primo fra tutti Peter Kuper. Il “verismo” eisneriano è costantemente in bilico con il delirio espressionistico di Kuper, che in alcuni momenti sembra esplodere tra le pagine. Osservando attentamente le tavole del primo capitolo, Il bugigattolo, è possibile accorgersi immediatamente di questa deriva: per i giovani bambini Thompson, il mondo è un luogo pericoloso abitato da mostri, i grandi (i genitori e i compagni di scuola più grossi e forti) sono troll e giganti spaventosi.
Il bugigattolo del titolo, ovvero lo stanzino polveroso in cui era costretto a dormire uno di loro se non faceva il bravo in casa, è il covo del coccodrillo che tutto inghiotte. Ma il mondo non è solo spaventoso, è anche il più incredibile luna-park tra le nuvole, popolato di fantasia e immaginazione. Kuper è presente nelle pagine più evocative di questo episodio (pagg. 16, 40-43, 60).

Oltre che nel tratto, si può vedere l’insegnamento di Peter Kuper anche nell’impostazione di alcune tavole, dove l’interiorità e il mondo esterno si confondono, si intersecano in modo inscindibile. Si vedano ad esempio le pagine nelle quali Raina regala a Craig la coperta (pagg. 182-183); oppure quelle conclusive del quarto capitolo, Statica (pagg. 258-261); o ancora quelle splendide della profonda intimità con Raina (pagg. 433-437).
Grazie alla perizia grafica dell’autore, evidente in queste e altre pagine, il fumetto esce vincente dal confronto con un qualsiasi romanzo autobiografico. Mi correggo, non voglio dire che in assoluto il primo sia più efficace del secondo. Ma la possibilità di cambiare registro così velocemente, la forza evocativa di certi disegni, l’espressività iconica dei volti, dei gesti e della postura dei personaggi, sono impensabili in un romanzo letterario.
Laddove alcuni passaggi, in un romanzo, con l’uso delle sole parole, rischierebbero di sembrare troppo naif o troppo facilmente poetici, in Blankets diventano strumenti efficaci di immedesimazione, capaci di veicolare emozioni intense, ricche di sfumature.
Craing Thompson è un autore giovane quando crea Blankets, e mostra ancora alcune fragilità soprattutto sul piano dell’intenzionalità narrativa, che alcune volte appare troppo ingenua. Eppure con quest’opera dimostrò di aver già compreso in modo profondo la reale forza e specificità del medium fumetto, di averla interiorizzata ed elaborata. Un opera senza pedanteria né didascalismo e neppure autocompiacimento; solo la pressante, esuberante necessità di raccontarsi e scoprirsi, di sollevare la coperta della propria intimità e di lasciare tracce ben visibili sul manto nevoso incontaminato.
Abbiamo parlato di:
Blankets
Craig Thompson
Traduzione di Claudia Manzolelli
Rizzoli Lizard, 2010
592 pagine, cartonato, bianco e nero – 29,00€
ISBN: 8817043737
Riferimenti:
www.coconinopress.com
www.blackvelveteditrice.com
Recensione di Goodbye Chunky Rice di Craig Thompson
Articolo sulla presentazione di Blankets a Milano
Recensione di Lascia stare e altri racconti brevi di Peter Kuper