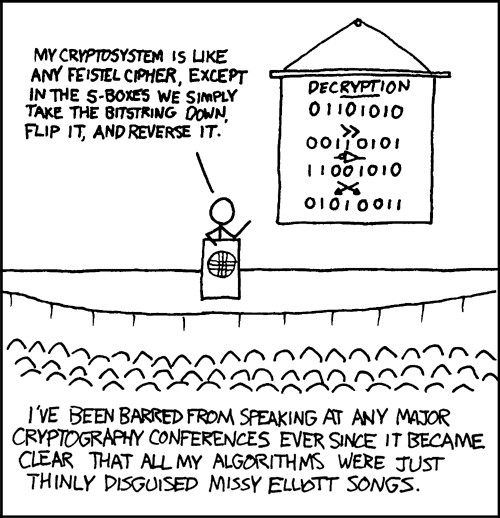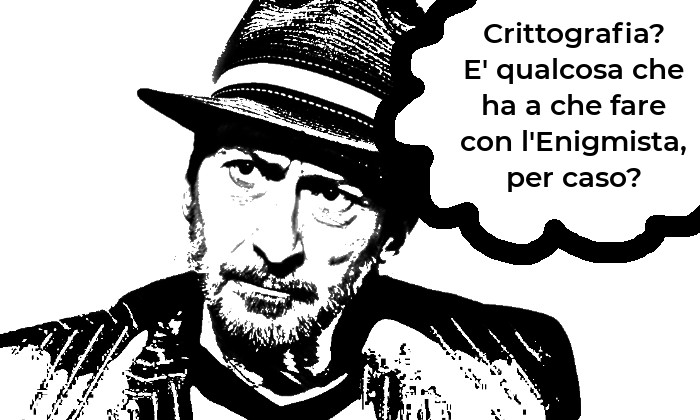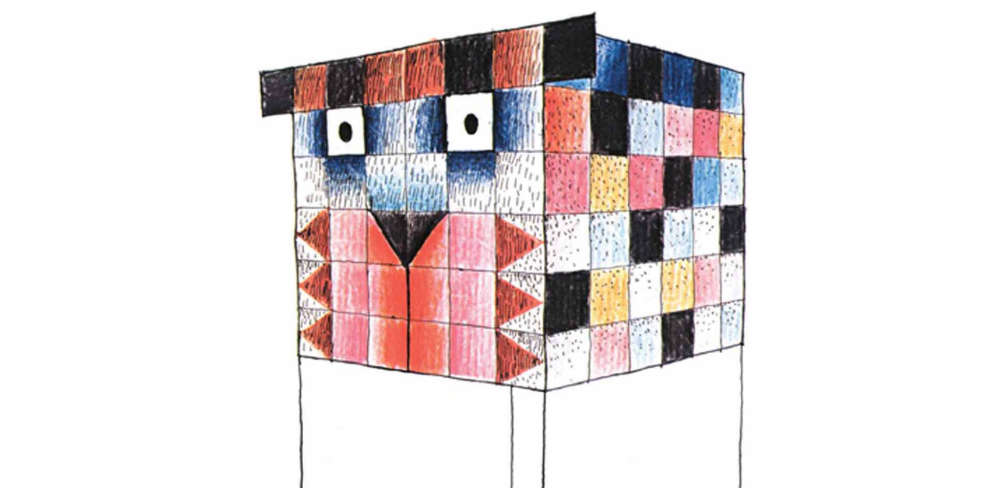La crittografia, in poche semplici parole, è l’arte matematica di nascondere informazioni dietro codici numerici o, più in generale, alfanumerici. Da sempre l’evoluzione nel campo è stata guidata ora dai crittografi, ovvero coloro che cercano di sviluppare gli algoritmi per crittare (nascondere) le informazioni agli occhi di coloro che non posseggono la chiave, e i crittoanalisti, coloro che cercano, invece, di rompere i codici e le chiavi per decifrare i messaggi nascosti. In particolare Miller, nato nel 1842 a Milwaukee, nel Wisconsin, è riuscito a ideare nel 1882 il one time pad, noto come cifrario di Vernam, dal nome del crittografo che per primo brevettò il sistema, Gilbert Vernam, nel 1919.
Il sistema crittografico di Miller e Vernam, di difficile se non impossibile decifrazione, richiede l’uso di una chiave condivisa lunga quanto se non più del messaggio scambiato tra mittente e destinatario. Il testo in chiaro viene cifrato utilizzando una chiave segreta casuale combinando ciascun bit del messaggio originale con il corrispondente carattere della chiave.
Se la chiave è
- realmente casuale;
- lunga almeno quanto il testo in chiaro;
- mai riutilizzata in tutto o in parte;
- tenuta completamente al segreto;
allora il testo cifrato risultante sarà impossibile da decrittare o rompere.
Tale inviolabilità del metodo è stata dimostrata nel 1959 da Claude Shannon ((Shannon, C. E. (1949). Communication theory of secrecy systems. Bell system technical journal, 28(4), 656-715. doi:10.1002/j.1538-7305.1949.tb00928.x)), così da assegnare all’algoritmo sviluppato da Miller e Vernam l’appellativo di “cifrario perfetto”.
Altra particolarità del metodo è che ciascuna chiave viene utilizzata una e una sola volta. Inoltre la necessità di una distribuzione sicura delle chiavi ha reso i cifrari monouso derivati dal metodo poco utilizzati per scopi pratici, a differenza delle chiavi di crittazione migliori, basate su numeri primi estremamente grandi. Questo perché la determinazione dei fattori primi di un numero di molte e molte cifre richiede un dispendio di risorse estremamente grande, tanto che si stima che le chiavi migliori siano decifrabili con un tempo pari almeno all’età dell’universo!