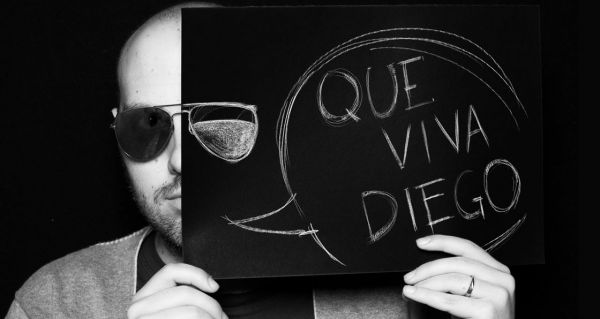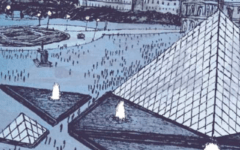Francesco Barilli: Come scrittore e mediattivista “nasco” con i giorni del G8 genovese del luglio 2001. Poco dopo quei fatti fu un mio caro amico a chiedermi di scrivere per Ecomancina, sito internet di informazione alternativa da lui creato. Accettai subito: per me era un’esigenza più che una possibilità. Parafrasando Che Guevara, si trattava di recuperare la capacità di indignarmi di fronte alle ingiustizie, tornando a sentire che nessuno può ritenersi escluso dalle responsabilità dell’agire concreto. Dico recuperare perché la mia generazione è quella del riflusso, su cui pesa la colpa d’aver favorito il precipitare di molte conquiste fatte dalle generazioni precedenti, d’aver affossato speranze che “il popolo di Genova” aveva provato a riaccendere. E quel “ritiro nel privato”, quel richiudersi in se stessi che ho provato anch’io assieme a quelli della mia età, dopo Genova l’ho sentito forse come una colpa da espiare. Il primo pezzo che scrissi fu proprio sul caso Pinelli, a cui seguirono articoli e soprattutto interviste, generalmente realizzate con persone che avevano sofferto lutti per stragi (Bologna, Ustica, Piazza della Loggia, Via dei Georgofili ecc) o per omicidi per mano fascista o delle forze dell’ordine (Carlo Giuliani, Fausto e Iaio, Piero Bruno ecc). È così che è nata la mia amicizia con Haidi Giuliani, madre di Carlo, e conseguentemente la volontà di assisterla nella sua idea di un sito internet che raccogliesse al suo interno la storia di suo figlio, di “quelli di Genova”, di quelli venuti prima e, purtroppo, dopo. Quel sito lo coordino tuttora: reti-invisibili.net. Cio’ che è arrivato in seguito è conseguenza di quel percorso nato a Genova. Per l’editore Becco Giallo ho curato i redazionali dei volumi Ilaria Alpi, il prezzo della verità, Dossier Genova/G8, Il delitto Pasolini, Peppino Impastato, un giullare contro la mafia. Ho contribuito al libro Fausto e Iaio. Trent’anni dopo (Autori Vari, Costa & Nolan, 2008). Ho curato con Sergio Sinigaglia La piuma e la montagna (Manifestolibri, 2008). Con Checchino Antonini e Dario Rossi ho scritto Scuola Diaz: vergogna di Stato (Edizioni Alegre, 2009). Fino a Piazza Fontana…
Matteo Fenoglio: Ho 32 anni. Vivo e lavoro a Pinerolo in provincia di Torino. Ho conseguito il diploma all’Accademia di Belle Arti di Torino con una tesi sui rapporti tra arte e musica nella Repubblica di Weimar. Nel 2006 ho conosciuto Luca Vanzella e Luca Genovese di Selfcomics e ho iniziato a collaborare con loro scrivendo e disegnando due storie uscite prima sul web e poi raccolte in antologia. Nel 2008 ho partecipato alla collettiva Futuro Anteriore al Napoli Comicon con un racconto sui testi di Luana Vergari. Dal 2007 al 2009 ho collaborato con tre storie brevi alle antologie prodotte da Radio Sherwood, Resistenze, Zero Tolleranza e Sherwood Comix. Nel 2009 ho illustrato una parte del libro Due cuori e una capanna (Q press).
Alterno la passione per il fumetto al lavoro in una industria chimica e all’attività di delegato sindacale.
Sono sposato con Floriana e ho una bimba di dieci mesi di nome Sara.
Come è nata l’idea di raccontare la tragedia di Piazza Fontana a fumetti? È un progetto affidatovi dall’Editore oppure dovuto ad una vostra proposta?
FB: Personalmente direi un mix: come ti dicevo, avevo già collaborato con l’editore, ma sempre e solo curando apparati redazionali. Avevo già intervistato Francesca Dendena (dell’associazione familiari vittime della strage) nel giugno 2005, poco dopo l’ultima sentenza della Cassazione. E La piuma e la montagna, libro che citavo prima, si apre proprio con una mia intervista a Licia Pinelli. Intendo dire che al Becco Giallo sapevano del mio interesse verso la materia, e con Guido e Federico le collaborazioni sui redazionali avevano già stabilito un rapporto oltre il professionale, fatto di stima e fiducia reciproche. Il 40 anniversario della strage, poi, lo percepivo come un obbligo da assolvere in qualche modo. Già da tempo mi chiedevo cosa fare in proposito. Vedi, io sento l’esigenza di preservare la memoria di queste vicende, non come qualcosa di freddo o rituale, ma perché si tratta di fatti tragici che, oltre a non vedersi riconosciuta giustizia (spesso, se non sempre…) sono a rischio di oblio o – peggio – di una riscrittura distorta. Pero’, confesso, non avrei pensato alla sceneggiatura di un fumetto: per il mio passato mi sarei sentito più portato a mezzi espressivi che mi sono più noti: un racconto, un saggio, una serie di interviste… Penso che da parte di Guido e Federico l’idea di affidarmi Piazza Fontana sia stata una “scommessa sulla fiducia”. Un azzardo che spero di aver ripagato.
MF: La proposta è arrivata direttamente dall’editore. Nel dicembre 2008 mi contatto’ Guido Ostanel di Becco Giallo, che già conoscevo per aver collaborato a Resistenze e Zero Tolleranza. Mi chiese se l’idea poteva interessarmi e che avrei lavorato con un giornalista che aveva già curato i redazionali per alcuni loro libri. Nel 2000 avevo letto un bellissimo testo di Giorgio Boatti intitolato Piazza Fontana (Einaudi, 1999) e ne rimasi così colpito da recuperare una serie di libri inerenti a quei drammatici giorni. Accettai con piacere la proposta di Guido e mi feci lasciare il numero di telefono della persona con cui avrei diviso le fatiche nei dieci mesi successivi. Quando chiamai Francesco per la prima volta eravamo due perfetti estranei.
Lo conobbi di persona a Torino il 20 gennaio del 2009, il giorno prima che nascesse mia figlia. Adesso, a quasi un anno di distanza, lo considero quasi un fratello.
Francesco citi tra le difficoltà riscontrate nella stesura dell’opera la complessità della materia e la mancanza di esperienza nella sceneggiatura di un fumetto, difficoltà superate grazie alla collaborazione e all’affiatamento con Matteo. Potete raccontarci brevemente come si è sviluppata l’opera? Dal primo approccio allo sviluppo e alle varie collaborazioni di cui vi siete avvalsi.
FB: Temendo di dimenticare i ringraziamenti (non rituali, ma assolutamente sinceri!) parto dalla fine della domanda. Oltre ai familiari delle vittime e a Fortunato Zinni (testimone della strage) sono stati di grande aiuto Federico Sinicato, avvocato di parte civile per i familiari, e Aldo Giannuli (storico, consulente delle Procure di Bari, Milano, Pavia e Brescia, nonché della Commissione Stragi). E il grazie più grosso (lo dico nel libro, ma voglio ribadirlo qui) lo devo a Saverio Ferrari, dell’Osservatorio Democratico sulle nuove destre: ho perso il conto delle volte in cui gli ho “rotto le scatole” per un aiuto su qualche dettaglio, una conferma, un dubbio da sciogliere…
Passando al resto della tua domanda, fin dall’inizio avevo un paio di idee in testa. Una fissa, l’altra maturata dopo la conoscenza di Matteo. La prima: utilizzare Patmos, una lunga poesia che Pier Paolo Pasolini dedico’ alle vittime di Piazza Fontana. La scrisse immediatamente dopo la strage, prima che il bilancio si facesse ancora più drammatico e prima della morte di Pinelli. Questo mi ha costretto a misurarmi con un talento poetico infinitamente più valido per inserire nel finale, con versi miei, le altre vittime e il ferroviere anarchico, volendo testimoniare anche i morti assenti in Patmos.
La seconda idea era, se possibile, ancora più ambiziosa ed è maturata confrontandomi con Matteo nelle prime settimane di lavoro. Una storia come quella di Piazza Fontana può costringerti ad essere puramente didascalico, privilegiando cioé una ricostruzione storico documentale della vicenda; oppure, specularmente, può portarti la tentazione di inserire elementi “di fiction”, per migliorare il ritmo narrativo. Alla fine abbiamo scelto l’opzione più rischiosa: attenerci scrupolosamente ai documenti e ai fatti, senza inserire personaggi di fantasia (col compito di accompagnare il lettore oppure col fine di una migliore drammatizzazione), e contemporaneamente plasmando quel materiale “reale” in qualcosa che non fosse una semplice ricostruzione storica. In altre parole, non volevamo fare un saggio su Piazza Fontana “travestito” da fumetto: volevamo raccontare una storia che avesse potenzialità non solo come opera di impegno civile, ma pure come lavoro narrativo, restando pero’ aderenti ai fatti e senza “concessioni romanzesche”.
Credo che sul concetto di “narrativa impegnata” (sia essa un’opera in prosa o a fumetti) si potrebbero fare ulteriori riflessioni, ma ci porterebbero fuori tema. Basti dire che, a mio avviso, perché si possa parlare di “narrativa impegnata” si deve essere mossi dal fuoco sincero dell’impegno, ma si deve pure arrivare a un risultato dignitoso nel racconto puro e semplice. Questo è stato il nostro obbiettivo e pensiamo di averlo centrato (anche se, ovviamente, il giudizio definitivo spetta ai lettori), e in tale direzione l’aver trovato Matteo è stato un aiuto davvero sorprendente. Lui non è solo un ottimo disegnatore (il che è importante, ma dal mio punto di vista non è fondamentale) ma soprattutto ha uno spiccato senso del “narrare per immagini”, conosce i segreti e le difficoltà del ritmo narrativo, ha una cura per i dettagli meticolosissima, e sto parlando non tanto, o non solo, di dettagli grafici, ma di costruzione della tavola, pensata e ripensata fino a quando non lo soddisfa pienamente.
MF: Confesso che i primi momenti furono abbastanza difficoltosi. Come ben dici Francesco non aveva mai scritto la sceneggiatura di un fumetto e io non avevo mai lavorato su una forma racconto così lunga e articolata. I primi mesi furono una sorta di brainstorming forzato dove entrambi ci rimbalzavamo via mail stralci di soggetto, pezzi di sceneggiatura e primi studi dei personaggi. L’unica cosa sopravvissuta nella forma finale del libro sono i passaggi di Patmos, la poesia di Pasolini che Francesco decise fin da subito, e io ne appoggiai la scelta, doveva costituire il nucleo portante del lavoro. Superato il rodaggio dei primi tempi e imparando a conoscerci e stimarci, abbiamo iniziato a lavorare per sottrazione. Va considerato che Piazza Fontana è una vicenda che si snoda negli ultimi quarant’anni della storia repubblicana e si ramifica in mille tentacoli che difficilmente sono sintetizzabili in un libro a fumetti di 110 pagine. Dati i tempi prestabiliti e l’enorme mole di materiale sull’argomento siamo stati costretti alla scelta obbligata di privilegiare alcuni snodi ritenuti da entrambi più significativi e “cruciali” di altri. In poche parole abbiamo scelto una “linea”, il taglio da dare al lavoro. Abbiamo prima costituito il corpo centrale del libro, privilegiando la narrazione dura e cruda dei fatti. Poi ci siamo concentrati su quella che io chiamo “cornice”, ovvero il prologo e l’epilogo e alcune scelte grafiche legati ai passaggi della sopracitata Patmos.
La terza, grande difficoltà a cui fa riferimento Francesco è il doversi confrontare con la responsabilità di non poter deludere chi ancora aspetta verità e giustizia per la strage. Come avete pensato di affrontare questo aspetto nel racconto?
FB: Guarda, le primissime bozze (sia della sceneggiatura che delle tavole) le abbiamo mostrate a Francesca Dendena, Carlo Arnoldi e Fortunato Zinni, per un parere. Ma dopo averli incontrati per l’intervista che sapevo avrebbe chiuso il libro (realizzata a casa di Francesca, il 16 marzo 2009) io e Matteo abbiamo scelto di tenere noi le redini della narrazione. A quel punto avevamo raccolto le loro impressioni, i loro ricordi, avevamo capito quali erano le aspettative, cosa volevano fare emergere, quali particolari apparentemente secondari tenevano a sottolineare. Penso, per fare un esempio, ai funerali del 15 dicembre; un momento che tutti ci hanno evidenziato come un messaggio di grande civiltà e fermezza che seppe dare Milano, seppure sconvolta dalla tragedia: un momento che abbiamo cercato di riprodurre nel fumetto proprio rispettando quelle aspettative. Dopo aver raccolto le loro prime impressioni, il fumetto doveva essere pero’ in mano nostra. Penso di poter dire anche per Matteo che, da quel momento in poi, gli ultimi 6 mesi di lavoro sono stati un’esperienza non solo professionale, ma “di vita”, per il continuo confronto a cui abbiamo sottoposto le nostre idee, riuscendo sempre a trovare non solo una sintesi, ma una soluzione che quelle idee le sapesse valorizzare meglio di quanto il singolo ideatore (di volta in volta io o Matteo) avesse proposto.
A quarant’anni di distanza la strage di Piazza Fontana risulta tuttora irrisolta nonostante la definitiva chiusura della vicenda giudiziaria con la sentenza della Corte di Cassazione del maggio 2005. Mi sembra chiara la vostra scelta di privilegiare la ricostruzione storica rispetto alla concatenazione degli eventi, spesso contraddittoria, che emerge dalle varie sentenze susseguitesi nel corso degli anni. Mi sbaglio? Quali sono le motivazioni di questa scelta?
FB: Nella sua prefazione, Aldo Giannuli scrive che “Piazza Fontana non è una storia: è un groviglio inestricabile di storie, un intreccio informe e debordante di uomini e cose”. Ha ragione: come accennavo prima, si tratta di una vicenda che, al di là delle implicazioni etiche e di responsabilità verso le vittime, narrativamente è affascinante e contemporaneamente difficile da trattare. Una storia complessa, che si snoda anche fuori dai nostri confini, inserendosi in un contesto nazionale e internazionale assai contorto: direi che la strategia della tensione, che si dipana da Piazza Fontana in poi, non è altro che il frutto amaro della guerra fredda est-ovest scaturita dal secondo conflitto mondiale. La faccenda è resa ancora più complessa da almeno altri tre fattori: il gran numero di personaggi coinvolti; il peso di quarant’anni passati; la presenza di sentenze di assoluzione che, ovviamente, costringe ad usare cautela in certi passaggi. Per usare una metafora, la questione della scelta di privilegiare questo o quell’aspetto può essere accostata al lavoro di uno scultore che prende un grosso blocco di marmo per realizzare una statua. Quel blocco di marmo è tutto “materiale buono”, ma lui è costretto a buttarne gran parte per modellare la figura che ha in mente. Analogamente, io e Matteo ci siamo trovati con una montagna di documenti, che a sua volta ci parlava di episodi interessanti ma che abbiamo dovuto scartare (spesso scegliendo di raccontarli comunque nelle note) in nome dell’unitarietà narrativa.
FB: Beh, sulla conoscenza preventiva del progetto ti ho già risposto. Posso dirti che tutti sono stati ben disposti da subito verso il nostro lavoro. Intendo dire che nessuno ha trovato nulla da eccepire sulla scelta del fumetto, nessuno ha dimostrato pregiudizi verso questa forma espressiva. Non ci siamo, insomma, dovuti scontrare con pregiudizi tipo “sì, ma il fumetto è roba da ragazzini”. E i loro pareri che abbiamo raccolto dopo l’uscita del libro sono stati assolutamente positivi.
I programmi scolastici sembrano ignorare la storia italiana contemporanea e la conoscenza delle vicende che hanno segnato e continuano a segnare il nostro paese dal dopoguerra ad oggi, la cui esperienza è sempre più relegata a parte dell’editoria o a sporadici tentativi di approfondimento quale, ad esempio, Blu Notte di Carlo Lucarelli. La realizzazione di Piazza Fontana vuole in qualche modo colmare a questa grave lacuna? In quale misura? E nei confronti di quale pubblico?
FB: Sul punto dell’ignoranza rispetto a certe vicende ti diro’ di più. C’é una frase di Fortunato Zinni, nell’intervista finale, a mio avviso molto significativa: “Il punto non è decidere se sia o meno il caso di mettere una pietra sopra la strage. Quella, purtroppo, c’é già… Il punto è riconoscere che tutte le Istituzioni sono state assenti – e in molti casi ben peggio che assenti – e questo riconoscimento deve avvenire dalla più alta carica dello Stato”. Vedi, l’assenza di giustizia su Piazza Fontana fa male, ma in una certa misura posso accettarla. Intendo dire, per citare un solo caso, che posso accettare che Freda e Ventura, parafrasando il giudice Salvini, siano segnati da una “colpevolezza storicamente provata, anche se non traducibile in una sentenza di condanna”: la loro assoluzione sul piano penale è figlia di un principio di civiltà giuridica (i due soggetti sono stati definitivamente assolti precedentemente, per cui non sono nuovamente processabili) a cui va portato il massimo rispetto, anche quando ci ferisce. Quel che davvero fa male al Paese (anche perché, differentemente dalle assoluzioni definitive, si tratta di un aspetto su cui la società può e deve incidere) è che i giovani siano in gran parte convinti che la strage è stata opera delle Brigate Rosse (e questa mia frase, sia chiaro, non nasconde nessun tentativo di sminuire la gravità delle azioni delle BR); oppure che i media nazionali si occupino di Garlasco o del “caso Meredith” dimenticando che proprio in questi mesi si sta celebrando a Brescia un processo importantissimo: quello sulla strage di Piazza della Loggia, probabilmente l’ultimo procedimento sul quinquennio di stragi italiane avvenute fra il 1969 e il 1974. Il punto è che la conoscenza della storia recente è fondamentale anche per capire l’evoluzione (involuzione?) del Paese negli anni che ci portano all’attualità. Sulle possibilità che il nostro libro possa servire a colmare questa lacuna, non sono ottimista. Pero’ mi piace ricordare una frase che ho sentito pronunciare a Giorgio Gaber in un’intervista: “Mi interessa di più raccontare una verità intera a una singola persona che mezza verità a mille persone”. Ecco, credo che sintetizzi bene anche il mio atteggiamento, non solo riguardo Piazza Fontana, ma in generale verso le tematiche che tratto su reti-invisibili.net. Potrei risponderti citando un’altra frase, stavolta proprio del fumetto. Una frase del capitolo 3 che abbiamo estratto da un modo di dire molto utilizzato in America a proposito dell’omicidio del Presidente Kennedy, e le cui potenzialità forse nemmeno io e Matteo abbiamo colto appieno, fino a quando Aldo Giannuli l’ha utilizzata all’interno della sua prefazione: “Dov’eri il 12 dicembre 1969?”. Ebbene, trattandosi di un fumetto in realtà noi ci rivolgiamo a un pubblico che per la maggior parte, almeno ci auguriamo, quarant’anni fa non era ancora nato. Se siamo riusciti a portare questo pezzo di storia d’Italia a chi non lo conosceva, o ne conosceva solo vaghi stralci, possiamo essere contenti. Fossero anche dieci lettori, sono dieci lettori a cui abbiamo raccontato una verità intera, e non una verità dimezzata.
MF: é vero quanto dici sulla carenza del nostro sistema scolastico. Ricordo che da ragazzo mi chiedevo come mai a scuola non venissero forniti gli strumenti adeguati per capire di cosa parlavano in quegli anni i giornali e le televisioni. Avendo letto di recente che secondo alcuni studenti di Milano la strage di Piazza Fontana è stata portata a termine dalle Brigate Rosse, che oltretutto nel 1969 manco esistevano, penso che la situazione non sia poi così cambiata. Il nostro lavoro non pretende di colmare questa lacuna. Certo, non nascondiamo la speranza che possa essere letto come primo approccio all’argomento, ma ci farebbe piacere venisse letto innanzitutto come si legge un fumetto (rivolto quindi anche a chi conosce la storia che vi è narrata) con i suoi ritmi, le sue suggestioni, il suo lirismo.
Il desiderio non è poi solo quello di approcciare al tema le fasce di lettori più giovani, quanto di mantenere viva la memoria dei fatti, cercando di capire che quanto è successo quarant’anni fa ha lasciato degli strascichi evidenti nella società in cui viviamo.
Ho trovato molto efficaci le tavole raffiguranti la città di Milano e le illustrazioni abbinate alla commemorazione delle vittime dell’esplosione. Matteo ci parli della realizzazione grafica del volume?
MF: Vorrei qui tralasciare il discorso sulla documentazione iconografica, su cui mi sono dilungato già in appendice al libro.
Mi fa piacere che tu abbia trovato efficaci le immagini del prologo e di Patmos. La realizzazione di quelle pagine nasce dalla precisa intenzione di legare i vari capitoli del libro con un filo rosso che, pur muovendosi per suggestioni, ricordi al lettore la centralità delle vittime da un lato, e il valore della memoria dall’altro. Così va letta la scelta di inserire le immagini della Milano “contemporanea” contenute nel prologo.
Aldo Nove, in un suo libro dal titolo Milano non è Milano, affermava che “chi vive, se vuole andare avanti, deve dimenticare il suo passato. E Milano si dimentica, si trasforma. Per sopravvivere a se stessa”.
Milano, più di altre città, è nella percezione mediatica il simbolo del dinamismo, della finanza, dello stile, delle tendenze. Non ne abbiamo, consciamente o inconsciamente, un’immagine “storicizzata”. Così la scelta di inserire all’interno di un discorso più ampio sulla memoria alcune tavole che raffigurassero graficamente questo contrasto.
Si è proceduto cercando volutamente di creare uno stacco tra le didascalie e le immagini, così come si è fatto per le varie tavole contenenti i brani di Patmos.
Quali analogie o differenze hai riscontrato rispetto ai tuoi lavori precedenti? (penso, ad esempio, a Resistenze o Zero Tolleranza).
MF: Nei precedenti lavori mi muovevo in territori più circoscritti. Avevo una storia da sviluppare in poche pagine con un’ambientazione precisa, pochi personaggi e una trama lineare. E soprattutto, nella maggioranza dei casi, la storia ero io a scriverla. Qui si è trattato di affrontare una vicenda storica dalle mille sfaccettature, con una miriade di attori primari e secondari coinvolti. In secondo luogo mi sono dovuto confrontare per nove mesi con un’altra persona (cosa che prima non avevo mai fatto in questa misura), entrarvi in sintonia, sacrificare parte del proprio ego, scendere a compromessi. Con la fortuna che Francesco si è da subito dimostrato una persona disponibilissima e soprattutto paziente. Per quanto riguarda lo stile grafico utilizzato penso che le analogie con le precedenti esperienze siano evidenti. Ho cercato qui di uniformare il più possibile tutti i passaggi grafici, dalle architetture alle figure umane. Il timore di affrontare un libro così lungo era quello di non riuscire a condurre una stessa cifra stilistica dal principio alla fine.
Prima di salutarvi, quali sono i vostri progetti futuri?
FB: Innanzitutto, continuo a coordinare reti-invisibili.net, un impegno che mi occupa quotidianamente. Sto lavorando su un romanzo imperniato sui fatti di Genova, che come ti ho accennato sono stati uno spartiacque nella mia vita. Ti devo pero’ confidare che (l’avrai capito…) scrivere un fumetto è stata un’esperienza molto stimolante, e non vorrei che Piazza Fontana restasse un’isola, nella mia esperienza di narratore. Ho già tre progetti in testa, e tutti coinvolgono Matteo, anche se… lui non lo sa ancora!!! Per meglio dire: del primo progetto sa già qualcosa, il secondo lo immagina, il terzo non sa nemmeno che esiste! Ecco, ti diro’ che sono molto curioso di vedere adesso cosa ti risponde lui!
MF:Prima di tutto un po’ di riposo. Poi ci sono alcune diverse proposte da prendere in considerazione. Innanzitutto un soggetto (questa volta di fiction!) che Francesco mi ha da poco fatto avere e che spero di leggere prima della prossima era geologica (scusa franz, ma rispondere alle interviste prende del tempo!).
Poi mi piacerebbe riprendere a scrivere e disegnare alcuni racconti brevi, ai quali penso già da parecchio tempo. L’unico impegno certo e confermato è la partecipazione alla Seconda Guida Illustrata al Frastuono più Atroce, prodotta da Lamette e che dovrebbe uscire la prossima primavera. Una sorta di ritorno a casa nel mondo dell’autoproduzione e, considerando i nomi coinvolti, un gran bel ritorno!
Riferimenti:
Piazza Fontana su LoSpazioBianco