
Gli incarichi istituzionali che si sono presto affiancati alla scrittura non hanno permesso una produzione massicciamente prolifica, ma spulciando l’elenco delle storie che ha realizzato nel corso dei decenni si può riscontrare una quantità sufficiente a delineare un percorso virtuoso e multiforme, capace di spaziare da trame classiche a narrazioni che accompagnavano varie iniziative collaterali: dai gadget alle campagne di sensibilizzazione, dallo sport ai programmi televisivi.
Importante, ma spesso trascurata, è inoltre la sua attività di autore di frame-story, vale a dire quella manciata di tavole inedite realizzate per raccordare insieme vecchie storie ristampate in vari albi speciali negli anni Novanta e primi Duemila, firmate con lo pseudonimo di Antonio Secondo; compito che fu poi istituzionalizzato tra il 2014 e il 2017 nella testata Topostorie.
Massimo Marconi è scomparso il 26 maggio 2025: a due mesi di distanza, proponiamo quindi una nuova puntata della rubrica Essential 11 con una selezione – proposta in ordine cronologico – il più possibile rappresentativa di quello che è stato il suo lavoro su Topolino, cercando di puntare i riflettori anche su opere solitamente meno ricordate.

Paperino e le 20mila beghe sotto i mari
disegni di Luciano Gatto (Topolino #1011, 1975)
Richiamando nel titolo un classico della narrativa d’avventura, Marconi si smarcò velocemente dalla trama originaria – come accadeva sovente nelle Parodie Disney – per imbastire un’avventura come tante che vedeva Zio Paperone alla ricerca di un bastimento affondato contenente 20.000 macchinari realizzati in una lega speciale e quindi remunerativa.
Il romanzo di Jules Verne veniva citato esplicitamente, prima da Qui, Quo, Qua che giocando in giardino reinterpretavano l’avventura del Capitano Nemo, poi dal gioco di parole sulle leghe (metalliche, in questo caso, e non intese come unità di misura), ma i punti di contatto si fermavano qui: per il resto si trattava di una piacevole “caccia al tesoro” marittima che funzionava autonomamente e che risentiva ancora, nei rapporti tra Zio Paperone e Paperino e tra Paperino e nipotini, delle dinamiche conflittuali codificate nei due decenni precedenti da Guido Martina.
Divertente e movimentata, la storia era accompagnata dal tratto pulito e chiaro di Luciano Gatto, che aumentava l’aura di classicità della trama.
Pluto e l’invasione dei replicanti
disegni di Massimo De Vita (Topolino #1564, 1985)
Ispirandosi in parte al film Gremlins (1984) di Joe Dante, nominato apertamente fin dalla prima tavola ove i protagonisti lo hanno appena visto al cinema, lo sceneggiatore realizzò in questo caso una storia atipica per almeno un paio di ragioni: i personaggi e le atmosfere.
Sono infatti Pluto e Tip & Tap – i nipotini di Topolino – le figure al centro della vicenda, il primo in qualità di “vittima degli eventi” e i secondi nei panni di chi ha visto qualcosa di impossibile ed è chiamato a fare la sua parte, senza venir creduto da chi sta loro intorno.
È bene ricordare che negli anni Ottanta vi era un florido filone cinematografico che partiva da simili presupposti e aveva ragazzini come protagonisti, giacché risultò particolarmente intelligente da parte di Marconi la volontà di iniettare tali istanze all’interno di una storia Disney, valorizzando peraltro un cast solitamente sfruttato poco e male; anche l’atmosfera vagamente inquietante veniva da quelle pellicole e riusciva effettivamente a dare qualche brivido grazie alla non proprio rassicurante moltiplicazione di “Pluti” dallo sguardo sinistro, pur restando sempre nell’alveo di quanto permesso dal contesto disneyano.
Massimo De Vita, che in quegli anni illustrò varie storie dell’autore, presentava qui una delle sue ultime prove caratterizzate da quello stile dettagliato ma “composto” di inizio decennio, che in quel periodo era in procinto di evolversi.


Topolino e il mistero del Mundial
disegni di Massimo De Vita (Topolino #1584, 1986)
In occasione dei Mondiali di Calcio del 1986, Topolino pubblicò una storia ad hoc – come fatto con le edizioni precedenti e successive – firmata proprio da Marconi. Lo sceneggiatore scrisse una trama ambiziosa, nella quale venne utilizzata la macchina del tempo dei professori Zapotec e Marlin per fare indagare Topolino e Pippo sulla scelta del CT della Nazionale italiana di far entrare in campo Gianni Rivera solo negli ultimi 8 minuti della finale dei Mondiali del 1970, che si erano svolti in Messico proprio come quelli del 1986.
La sceneggiatura giocò abilmente proprio su questa comunione di Paese ospitante tra le due edizioni, muovendosi in bilico tra passato e futuro con un escamotage molto simpatico e intrigante.
Ulteriore particolarità della storia erano i tre finali alternativi, ideati su spunto di tre guest star: il CT della Nazionale italiana Enzo Bearzot, il calciatore tedesco Karl Heinz Rummenigge e l’ex Presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini, che nelle successive ristampe sono stati sostituiti da Zio Paperone, Archimede e Pico de Paperis.
Per i disegni di De Vita valgano le considerazioni di cui sopra, con una nota di merito per le caricature dei tre illustri ospiti e per la puntuale rappresentazione dello stadio Azteca di Città del Messico.
Pista! a Topolinia (quasi una telenovela)
disegni di Giorgio Cavazzano (Topolino #637, 1987)
In un’epoca pre-Disney +, ma anche pre-Disney Channel, in Italia era la Rai a fornire gli spazi televisivi per i prodotti della Casa di Topolino: prima dei vari programmi-contenitori come Disney Club e Domenica Disney di metà anni Novanta, vi erano trasmissioni generaliste legate al mondo disneyano e tra queste spiccava Pista!, condotta dal regista e attore Maurizio Nichetti, che ha sempre avuto un legame speciale con il mondo dell’animazione.
Marconi scrisse ben due storie per pubblicizzare Pista!, ma la seconda è probabilmente la più riuscita per comicità, capacità di giocare con i personaggi Disney all’interno di un contesto pseudo-realistico e abilità nello stravolgere la realtà con la lente della fantasia, in maniera non dissimile – se vogliamo – con quanto fatto nell’ambito del film Chi ha incastrato Roger Rabbit?
I disegni di un Giorgio Cavazzano decisamente coinvolto e divertito furono la ciliegina sulla torta per qualcosa di promozionale ma molto gradevole.


Topolino e il ritorno al passato
disegni di Massimo De Vita (Topolino #1672, 1987)
Si tratta sicuramente di una delle storie di riferimento nella produzione marconiana: in seguito a uno dei consueti viaggi indietro nel tempo di Topolino e Pippo grazie alla prodigiosa macchina dei professori Zapotec e Marlin, i due crononauti sono stati inavvertitamente seguiti da un bambino; per un guasto alla consolle non è possibile rimandarlo subito a casa e pertanto Topolino ha il compito di badare a lui evitando che impari troppe cose di ciò che per lui è futuro.
Una storia molto di cuore, visto il rapporto che si instaurava con il piccolo, ma che trovava il proprio apice nella rivelazione sulla sua identità, con una spiegazione molto suggestiva relativa al mistero che avvolge quella figura storica.
Fenomenali i disegni di De Vita, che oltre a rappresentare magnificamente i protagonisti riesce a dare il giusto tocco al giovane comprimario, nonché alle evocative ambientazioni.
Qui, Quo, Qua e il tempo delle mele
disegni di Massimo De Vita (Topolino #1688, 1988)
Altra storia celeberrima di Marconi che, ancora una volta, dimostrò di saper guardare con attenzione ai fenomeni di costume del suo tempo: anche se la trama non seguiva fedelmente quella dell’omonimo film con Sophie Marceau, il tema dei primi amori giovanili rimase centrale anche in questo fumetto.
L’autore riuscì a trattare l’argomento con il giusto tatto scegliendo uno dei nipotini di Paperino – Quo – come innamorato di turno, e ponendo i suoi fratelli come guastatori di questo sentimento in nome di un senso di tradimento familiare.
Nel decennio successivo altri autori avrebbero spesso indugiato sulle prime palpitazioni giovanili, privilegiando in quei casi Tip & Tap, ma Il tempo delle mele è rimasta paradigmatica di come poter parlare di argomenti più terra-terra e vicini al target dei lettori, per quanto delicati, in maniera fresca e azzeccata.
Il merito fu ancora una volta anche di De Vita, che con il suo stile morbido e rassicurante caratterizzò bene le espressioni del giovane infatuato, così come gli outfit per fare colpo sulla sua bella; alcuni inserti attorno alla griglia, a suon di cuoricini e simboli analoghi, completavano efficacemente l’atmosfera.


Topolino e la spada del tempo
disegni di Giorgio Cavazzano (Topolino #1817, 1990)
Molte sono state le storie Disney in cui Marconi ha promosso i vari sport, dal basket al ciclismo della BMX, ma mai come con la scherma l’autore seppe volare alto con la fantasia, creando un intero universo fantasy per la collaborazione con la Federazione Italiana Scherma.
Invece di mettere in scena ragazzini intenti a imparare i rudimenti della disciplina nelle palestre scolastiche o un personaggio Disney che in maniera un po’ didascalica illustrasse le qualità del singolo sport, Marconi scelse di calare la scherma all’interno di un’epica narrazione fantastica, avvincendo in questo modo il lettore al di là dell’intento promozionale e risultando coerente, dal momento che la spada era un elemento che avvicinava i due contesti.
Topolino e la spada invincibile fu il primo tassello dell’operazione, che conobbe addirittura un sequel con La spada del tempo, alzando narrativamente il tiro tramite un’avventura che non sfigurava per nulla accanto ad altre opere disneyane di genere: un cattivo decisamente temibile, un ferro dai poteri inquietanti e uno scontro finale reso ottimamente.
Anche in questo caso il supporto di Cavazzano permise un ulteriore salto di qualità per concorrere risultato finale, dando brillantemente vita su carta ai testi dello sceneggiatore.
Topolino presenta “La strada”
disegni di Giorgio Cavazzano (Topolino #1866, 1991)
Tra tutte le storie di Massimo Marconi che si sono ispirate ad altre opere extra-fumetto, questa è senza dubbio la più aderente alla fonte originaria: l’operazione, avvenuta con grande rispetto del capolavoro di Federico Fellini e con la promozione attiva del giornalista Rai Vincenzo Mollica, era delicata e lo sceneggiatore ha quindi dosato molto bene ogni personaggio, ogni interpretazione e ogni snodo di trama al fine di rendere onore a La strada. Guardando direttamente alla realtà rurale in cui si muovevano Topolino, Minni e gli altri nelle loro primissime avventure a strisce e ripescando il loro look di quel periodo grazie a uno strepitoso Cavazzano, si è trovato un perfetto punto di incontro tra Mickey Mouse e la poetica del regista di Rimini arrivando a una storia memorabile, sospesa tra realtà e sogno – cifra stilistica felliniana – e in grado di inserire anche lo stesso Fellini in un finale d’eccezione.


Topolino e la piramide impossibile
disegni di Massimo De Vita, da (Topolino #1868, 1991)
La macchina del tempo nascosta nei sotterranei del museo di Topolinia è ancora al centro di una vicenda ideata da Marconi, in questo caso più aderente allo standard della serie: Topolino e Pippo sono chiamati a risolvere il mistero di una piramide appena scoperta e realizzata in zinco, materiale che all’epoca degli antichi egizi non esisteva. La spiegazione risultava invero inflazionata, ma il plus dell’avventura si rintracciava nell’intento educativo – tutt’altro che didascalico – relativo alle salutari proprietà dello zinco e nei siparietti comici: tra i due protagonisti incastrati in compiti di facchinaggio e gli accesi scontri tra i professori Zapotec e Marlin, le risate abbondano.
De Vita aveva ormai inaugurato la fase della sua maturità artistica e lo dimostrò con tavole eleganti, fresche e dinamiche che elevavano ulteriormente la storia.
Topolino e il collegamento multidimensionale
disegni di Giorgio Cavazzano (Topolino #1961, 1993)
Dall’inizio degli anni Novanta e fino alla prima metà del decennio successivo, una costante dell’estate di Topolino era il gadget da montare, allegato in più parti ad altrettante uscite del settimanale pubblicate a luglio. Marconi si occupò dal 1991 al 1993 di scrivere storie che richiamassero esplicitamente il giocattolo di turno, non limitandosi a brevi storielle di carattere promozionale ma firmando epiche avventure suddivise in diversi episodi. Il collegamento multidimensionale ne è un ottimo esempio: senza preavviso Topolino e Pippo finiscono in una dimensione alternativa di stampo fantasy, ma riescono a rimanere in contatto con Tip & Tap sulla Terra grazie a dei prodigiosi walkie-talkie… gli stessi allegati al magazine, ovviamente. Il gusto per il fantastico si unisce a quello di un giallo classico, il tutto per far volare con la fantasia i ragazzini che avrebbero avuto presto in mano quello stesso oggetto al centro della storia.
Un difficile equilibrio tra le esigenze promozionali e quelle squisitamente narrative di cui Marconi è sempre stato maestro: qui accompagnato da un Cavazzano decisamente in forma, perfetto biglietto da visita per una storia solida e ingaggiante.


Topolino e la scatola dei 100 anni
disegni di Silvio Camboni, da (Topolino #1997, 1994)
Durante un colpo finito male, Gambadilegno entra in possesso di una scatola che avrebbe dovuto rimanere nascosta ancora a lungo; da questo suggestivo incipit si dipanava una trama ricca di colpi di scena, che mischiava sagacemente giallo, thriller, elementi spionistici e una comicità purissima.
Marconi dimostrò come Topolino si trovasse perfettamente a suo agio in ognuno di questi risvolti: in particolare sorprende il numero di volte in cui lo sceneggiatore lo calò in situazioni slapstick – solitamente riservate a Paperino – senza che il personaggio ne uscisse snaturato o che la trama ne risultasse svilita.
Una commedia degli equivoci spigliata alla quale dà un ottimo contributo anche Silvio Camboni con i suoi disegni conturbanti e ricchi di atmosfera, caratterizzati da una ricercatezza di fondo nel tratteggiare il protagonista e le ambientazioni che sarebbe poi esplosa negli anni successivi.


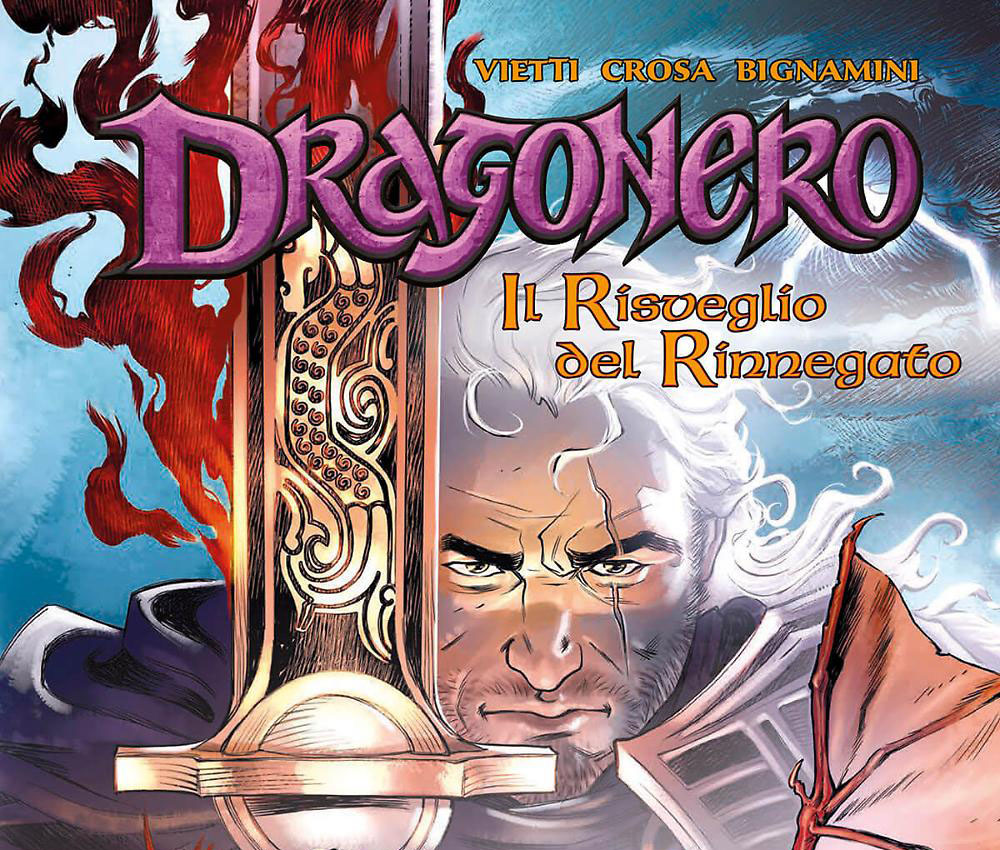


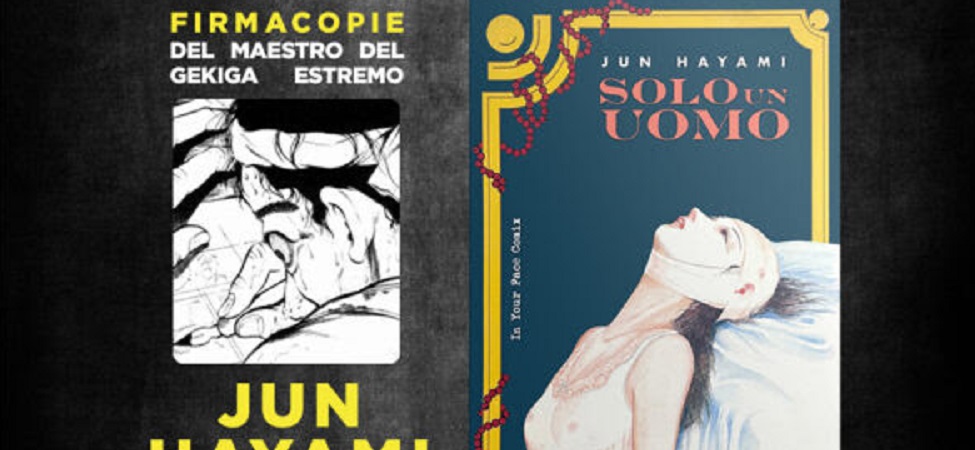





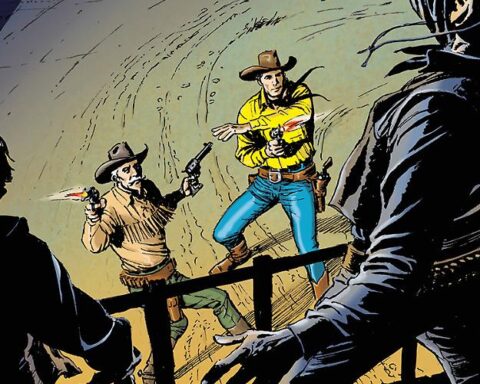

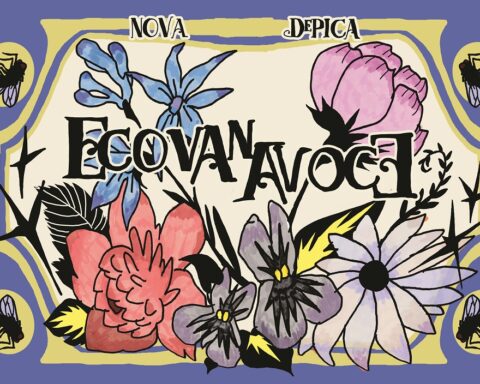
Ottimi consigli. Solo un appunto: Fellini era di Rimini!
Ciao Riccardo,
grazie per l’apprezzamento e, soprattutto, per la segnalazione dell’errore, sfuggito all’editing del pezzo e per il quale chiediamo scusa a te, alle altre lettrici e agli altri lettori e soprattutto a Federico Fellini, se ci sta leggendo ovunque sia!