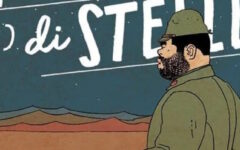Non è insolito trovare nella camera del lettore di fumetti accanto alla sua collezione di albi, una console o magari un pc utilizzati per immergersi nel mondo altrettanto amato dei videogiochi. Vi è un filo rosso che collega i fumetti ai videogiochi. Questo passa per l’esperienza estetica, che ruota intorno al vedere, per una fruizione di tipo più interattivo rispetto altri media e a volte attraverso una ricerca di evasione dalla vita di tutti i giorni, al desiderio di avventura, di esplorazione di mondi nuovi e fantastici. D’altronde non è un caso che fumetti e videogiochi siano universi che spesso coincidono o quantomeno si incontrano – pensiamo alle cut-scenes di un classico come Max Payne, ai crossover virtuali e fumettistici tra Fortnite e gli universi Marvel e DC, a Fables di Bill Willingham e al suo spin-off dei Telltale Games, The Wolf Among Us, per non parlare dei numerosi videogiochi a tema supereroico, dalla serie Arkham fino a Marvel Spider-Man. È il filo della cultura cosiddetta “nerd” o, ancora più in generale, della pop-culture, la cultura popolare.
Se negli anni ’80 e ’90 il “nerd” era l’emarginato che preferiva i mondi di fantasia offerti da fumetti e videogame allo sport o alle feste, oggi questa dimensione è stata integrata nella vita di tutti i giorni e molti dei suoi prodotti hanno “prevalso” divenendo un fenomeno di massa. Ha vinto in questo senso “l’impulso al gioco” di Schiller, secondo cui “l’essere umano è pienamente sé stesso solo quando gioca,” come spiega Tommaso Ariemma nel suo libro. Il gioco fantastico nel quale si immergevano i “nerd” attraverso le pagine del fumetto o il mondo virtuale del videogioco oggi ha attirato e risucchiato al suo interno milioni di altri.
La cultura popolare viene spesso, a torto, opposta a una cultura cosiddetta “alta” dove certamente risiede la filosofia, un tempo considerata la “regina delle scienze”. Come però ben sapeva Umberto Eco che leggeva Engels per rilassarsi e Corto Maltese come lettura più impegnata, tale distinzione impoverisce e fa torto a entrambe. Lo stesso sa certamente Ariemma, docente di Filosofia ed Estetica tra i maggiori divulgatori della pop-filosofia italiana e autore di libri quali La filosofia spiegata con le serie TV (Mondadori) e Platone showrunner. Regole filosofiche per scrivere la serialità (Audino), opere che vengono definite, appunto, di pop-sofia. Questa consiste, spiega Ariemma, in un “esercizio della filosofia che usa strategicamente i fenomeni della cosiddetta ‘cultura di massa’, i fenomeni pop non solo come oggetto di analisi, ma anche come strumenti per filosofare”. In questo filone si inserisce il suo ultimo suo libro, Filosofia del gaming. Da Talete alla PlayStation, pubblicato per Tlon.
Il libro si divide in tredici capitoli (o forse sarebbe più corretto parlare di livelli?) che ripercorrono cronologicamente alcune delle pietre miliari della storia della filosofia rileggendole in relazione all’esperienza del gaming.
Come si addice a una “normale” storia della filosofia, si parte da Talete. Scriveva Russell in Storia della Filosofia Occidentale che, nonostante l’affermazione che tutto è fatto d’acqua scoraggi principianti e studenti liceali, Talete merita invece più rispetto di quanto gli si attribuisca inizialmente. Per Ariemma Talete è il filosofo dell’immersività, e cosa c’è di più immersivo di un videogioco?
Anche il secondo capitolo è un passaggio obbligato per una filosofia del (video)gioco: si affronta Eraclito. Eraclito è il pensatore del flusso – Ariemmma lo battezza il primo streamer – ma è anche colui che vede nel mondo un gioco continuo, il gioco di un fanciullo che innalza immensi castelli di sabbia, solo per tornare nuovamente a distruggerli (concetto ripreso poi da Nietzsche). In questo senso nulla può sottrarsi al gioco.
Altro passaggio obbligato è il confronto con lo storico Huizinga autore di Homo ludens, un testo imprescindibile per chi vuole affrontare il concetto di gioco e tutte le sue diramazioni. Il libro poggia su di una solida base concettuale e su un buon lavoro di ricerca: Ariemma non sta banalmente considerando alcuni tra i filosofi occidentali più significativi per rapportarli arbitrariamente al gaming (come si potrebbe temere da un’opera di questo tipo), ma dimostra di conoscere approfonditamente i testi e gli autori che hanno studiato e definito il concetto stesso di gioco. Altro autore menzionato e chiamato in causa accanto a Huizinga è, ad esempio, Roger Caillois, autore de I giochi e gli uomini, un classico di antropologia fondamentale per chiunque voglia dedicarsi ai game studies o anche per chi voglia approfondire il concetto di “maschera” (come sa chi ha letto il mio La maschera dell’antieroe).
Autori come Huizinga, Caillois e Jankélévitch fanno in qualche modo da ponte tra i grandi filosofi classici quali Aristotele, Spinoza ed Hegel e la tematica “meno seria” del gioco, consentendo di comprendere meglio come questa sia profondamente legata al pensiero filosofico. A proposito di serietà: perno dell’opera è il concetto di “gioco serio”, introdotto nel quarto capitolo dedicato a Platone e ripreso in seguito più volte. Come sanno i (video)giocatori, non ha senso affrontare il gioco non seriamente. “Gioco e serietà non devono mai separarsi”: il primo da solo sarebbe quanto mai noioso, un ridicolo passatempo, mentre la serietà senza giocosità è tragica, drammatica.
D’altronde la felicità richiede un “giocare con ciò che è serio”, scriveva Nietzsche in Su verità e menzogna in senso extramorale ed è segno della “grande salute” giocare con tutto ciò che è stato ritenuto sacro, ribadiva in seguito ne La gaia scienza. Come Eraclito, a cui il filosofo tedesco spesso si richiama, anche per Nietzsche il gioco è un aspetto fondamentale della vita, anzi potremmo dire che è l’unica cosa da prendere veramente sul serio in quanto tutto non è altro che un gioco. Certo non è necessariamente un gioco semplice o piacevole, anzi – almeno secondo il pensatore dell’Übermensch – è un gioco di sopraffazione, di lotta, di sfida continua. Quale miglior accostamento, allora, se non quello operato da Ariemma che chiama in campo i battle royale come Fortnite e League of Legends. Ariemma arriva a definire i videogame “macchine nietzscheane” alle quali il videogiocatore non può che darsi completamente. Infatti, chiosa l’autore, “un gioco è tale perché ognuno vi mette tutto sé stesso.”
Negli altri capitoli l’autore accosta Aristotele a Dark Souls, riprende l’Etica di Spinoza parlando di The Last of Us, si rifà ad Hegel citando Super Mario (un gioco profondamene hegeliano che scorre in una direzione precisa). Vengono anche trattati alcuni temi classici dei game studies, come il discusso rapporto dei videogiochi con la violenza e la loro potenziale pericolosità per i più giovani. Discorsi familiari, specialmente per un appassionato della nona arte che non può non sorridere (ma anche riflettere) vedendo i videogiochi affrontare quello attraverso cui i fumetti sono già passati. I fumetti “seducono gli innocenti”, scriveva un famigerato psicologo negli anni ’50, accusandoli di essere la causa di una generalizzata “corruzione giovanile”. Oggi la stessa accusa viene mossa ai videogiochi. D’altro canto la stessa calunnia venne mossa a Socrate nel 399 a.C.
Altra domanda pressante relativa ai game studies è se i videogame possano essere definiti arte. Anche qui è facile, per un lettore di fumetti, vedervi molte assonanze e similitudini col mondo dei comics, definiti solo a partire dagli anni ’60 la “nona arte” (subito dopo “il rutto parlato” e l’ottava, “foto di gattini”, direbbe Leo Ortolani). Ariemma è categorico a questo proposito: “non solo i videogame sono arte, ma non sono solo arte”. Se il fumetto è arte – e lo è – non vi è dubbio che anche il videogioco è considerabile tale.
Lo scopo di Ariemma non è quello di analizzare uno o più videogiochi attraverso la filosofia, ma piuttosto di indicare come la struttura stessa del videogioco – sia questo GTA, Dark Souls, Fortnite o The Last of Us – si rifaccia al pensiero filosofico. Nel complesso Filosofia del gaming è un saggio che ha alle spalle una solida base teorica sia relativa alla filosofia sia ai game studies. Non ha però la pretesa di esaustività e tutti i livelli dell’opera sembrano voler dare piuttosto uno stimolo a riprendere, approfondire e proseguire il gioco in “single player”. Se si trattasse di un cabinato degli anni ´80, a ogni gettone corrisponderebbe un capitolo: un’esperienza breve e intensa, ma che lascia, come tutti gli arcade che si rispettino, una certa insoddisfazione e la voglia di continuare a giocare. Per usare una metafora più recente, se vuole conquistare il trofeo di platino della filosofia del gaming, l’agognato 100%, il lettore deve dare tutto sé stesso e continuare a esplorare e approfondire andando oltre la fine del libro.
Filosofia del gaming è una preziosa aggiunta al panorama della pop-sofia italiana. È un testo serio ma leggero, fedele al concetto di gioco-serio che sta alla sua base. Questo è un concetto chiave fondamentale per comprendere non solo i game studies o la filosofia del gaming, ma tutta la pop-sofia – anzi forse addirittura la filosofia – nel suo complesso. Non si puó essere buoni pop-filosofi senza un ironico giocare con ció che è serio e, contemporaneamente, senza prendere assolutamente sul serio il gioco e la sua apparente leggerezza. Eraclito e Nietzsche approverebbero.
Abbiamo parlato di:
Filosofia del gaming. Da Talete alla PlayStation
Tommaso Ariemma
Tlon, 2023
102 pagine, brossurato, bianco e nero – 13,00 €
ISBN: 9791255540021