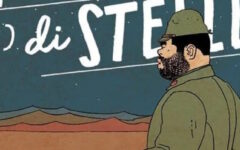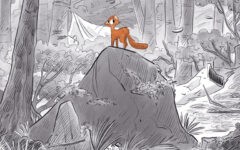Sfar narratore non gioca mai a carte scoperte, non impone mai direttamente il suo punto di vista sugli eventi, ma preferisce le prospettive oblique, i riferimenti indiretti. Come quando gioca con il proprio nome, mettendolo al centro di un’accesa disputa etimologica fra animali parlanti, il gatto del rabbino e l’asino di un sufi incontrato durante un pellegrinaggio. Il primo sostiene l’origine ebraica del nome (sofer, guarda caso, “scrivere”), il secondo quella araba. È una contesa priva di senso, dato il carattere profondamente inaffidabile e scivoloso del linguaggio: i “maestri”, il rabbino e il sufi, queste cose le sanno bene e preferiscono cantare, danzare e pregare insieme fino alle prime luci dell’alba.
Anche Sfar conosce bene la natura ingannevole delle parole, ma sa altrettanto bene che la loro semantica vaga è il cuore della rappresentazione artistica e della possibilità di creare mondi infiniti: uno dei dilemmi di fronte al quale si trova il felino, dopo l’acquisizione violenta ed improvvisa del linguaggio, è proprio il problema della verità e della finzione. Le sue prime parole sono menzognere, ma anche quando si sforzerà di dire il vero (la discussione con il vecchio maestro lo dimostra) non sarà sempre apprezzato. Il gatto sperimenta sulla propria pelle una serie crescente di dubbi, difficoltà ed incertezze, nel passaggio da un’esperienza del mondo basata esclusivamente sui sensi (in particolare sul tatto) ad una forma più complessa di comprensione ed organizzazione della conoscenza.
Il linguaggio crea un mondo indipendente da quello che conosciamo sensorialmente, non ne è uno specchio, non riflette nessuna realtà oggettiva. Anzi, si appropria del reale con un’azione predatrice di imposizione dei nomi, come dice il rabbino a pag. 31: “Il pensiero occidentale è una macchina prensile, predatrice, e, in ultima analisi, distruttrice… il Logos è fatto di tesi, antitesi e sintesi, mentre il giudaismo è fatto di tesi, antitesi, antitesi, antitesi…”.
L’antidoto sembra essere, per Sfar, la saggezza della tradizione ebraica, la sua struttura aperta, che registra una catena infinita di opposizioni, ma non pretende di risolverle.
Contenuti complessi, quindi, ma espressi dall’autore in una forma semplice: nella sceneggiatura, nel tratto, efficace e funzionale alla storia, e nella struttura delle tavole, sempre ordinata in sei vignette. Stupisce la facilità con cui l’autore si addentra in questioni filosofiche e teologiche di ampio respiro, senza mai cadere nell’erudizione fine a se stessa: l’elemento emotivo non passa mai in secondo piano, ma è il motore di tutta la storia. La forma “colta” con la quale si ammantano i desideri e le passioni dei personaggi sembra solo suggerirci che vissuto e pensiero vanno sempre di pari passo e, in fondo, sono la stessa cosa.

Il microcosmo iniziale è presto turbato dall’arrivo di una lettera dalla Francia, preludio all’intromissione a tutto campo dell’Europa.
In Malka dei Leoni, l’orizzonte si allarga per la prima volta oltre la Blanche: si attende l’arrivo di un bizzarro parente e del suo leone e il rabbino è costretto a sostenere un dettato in lingua francese. Le soluzioni narrative si fanno più fluide e Sfar ci propone una commedia degli equivoci basata su iniziali fraintendimenti. Con Malka fa il suo ingresso anche un rinnovato senso del meraviglioso, omaggio a mille romanzi d’avventura e a tanta parte del fumetto francese “classico”. Nel racconto conclusivo, significativamente intitolato Esodo, l’azione si sposta a Parigi: tutto è apparentemente sconvolto, Zlabya (la figlia del rabbino) si è sposata, il gatto ha perso la parola, il rabbino è dubbioso. La capitale trasforma la diversità in caricatura (il destino del cugino artista), vi predomina il grigio (al contrario della varietà di colori con cui Sfar dipinge Algeri), ma è anche occasione di nuovi incontri e quindi di nuove possibilità, prima del ritorno a casa con la saggezza acquisita dal viaggio.
La nuova edizione della Rizzoli offre un’ottima possibilità di (ri)lettura dei primi tre racconti della saga di Sfar ad un prezzo relativamente contenuto: inutile dire che ne aspettiamo con ansia il seguito.
Riferimenti:
Il sito della casa editrice: rizzoli.rcslibri.corriere.it
Il sito dell’autore (in francese): www.pastis.org