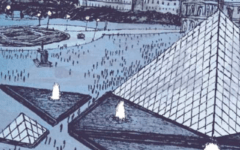L’acquisto dei diritti da Yamato Video per una prossima ripubblicazione di Paranoia Agent (titolo originale Mōsō dairinin; 2004) ci restituisce, dopo anni di limbo (dopo la chiusura della divisione video della Panini in Italia), una delle opere seriali giapponesi più importanti di sempre in versione blu-ray restaurata.
L’autore è Satoshi Kon, regista di culto nell’ambito dell’animazione nipponica e non. Morto prematuramente lasciando un vuoto incolmabile nel cinema d’animazione – e, ci azzardiamo a dire, nell’arte più in generale – aveva creato, grazie all’inossidabile collaborazione con lo studio Madhouse, questa mini serie da 13 episodi.
Prima di approfondire tutto quello che questa serie ha avuto il merito di esprimere, ci sembra dovuta una panoramica sull’autore e la sua produzione. Specie considerando che, seppure sia riconosciuto fra i più grandi registi di animazione giapponese della sua generazione, la prematura scomparsa l’ha privato della consacrazione definitiva, lasciando il pubblico ignaro della vera consapevolezza della sua grandezza.
Nella disamina che andremo ad affrontare ci avvarremo di due fonti imprescindibili nell’ambito italiano: il volume Satoshi Kon, il cinema attraverso lo specchio, a cura di Enrico Azzano, Andrea Fontana e Davide Tarò, edito da Edizioni il Foglio; e di E-Motion, sfortunato esperimento di rivista d’animazione con contenuti di altissima qualità chiusa purtroppo da anni, edita da IHT Gruppo Editoriale.
Biografia di un autore sognante
Nato in Hokkaido il 12 ottobre 1963, dopo le scuole si iscrive alla Musashi Art University con l’intenzione di diventare pittore. Ben presto viene notato dalla famosa rivista di manga Young Magazine e riesce a diventare assistente di Katsuhiro Otomo. Quest’ultimo rappresenta inevitabilmente il punto di riferimento non solo per la formazione di Satoshi Kon come mangaka , ma soprattutto per la successiva introduzione al mondo dell’animazione, da cui poi il regista spicca il volo con uno stile personale che di certo deve la sua genesi all’apprendistato presso il maestro di Akira.
Sono da ricordare fra le sue produzioni manga La stirpe della sirena (Kai-kisen, Star Comics, seconda metà degli anni novanta, volume 47 di Storie di Kappa e una nuova edizione uscita nel luglio 2019 sempre dallo stesso editore); World Apartment Horror (Warudo apaatoment hora, Star Comics, prima serializzato sulla rivista Kappa Magazine dal n.43 al n.46 nel 1992, poi in un volume unico nel 2006 per Storie di Kappa); Opus (2013, edita da Planet Manga in due volumi) e Seraphim, in collaborazione con Mamuru Oshii (2013, Planet Manga).
Il salto nel mondo dell’animazione avviene nel 1991 come animation designer per la cura degli sfondi di Roujin Z (Rôjin Z), film di Hiroyuki Kitakubo per il mercato Home Video (OAV).
Il 1993 è invece l’anno di Patlabor 2 (Kidô Keisatsu patorebâ: The Movie 2) e dell’incontro con il maestro Oshii, il quale comincia a stimolarlo sulle tematiche di convivenza di diverse verità che si svolgono su più livelli di lettura: tuttavia, se nell’operato del regista di Ghost in the Shell esse vengono sviluppate nella stessa realtà della narrazione, in quello di Kon vedono invece un continuo sovrapporsi di piani diversi, in cui sogno e realtà si mescolano costantemente e l’uno è simbolo e continuazione dell’altro.
Ormai Kon ha intuito che l’animazione è il mezzo più congeniale allo sviluppo delle sue idee. Benché la direzione delle animazioni nel quinto OAV della serie Le bizzarre avventure di Jojo (Jojo no Kimyona Boken, 1993) sia un ulteriore e importante tassello della sua formazione, il punto di svolta fondamentale è il lavoro per la sceneggiatura, direzione artistica e layout di Magnetic Rose (Kanojo no omoide), primo episodio del bellissimo trittico Memories (Memorîzu, 1995), progetto del maestro Otomo.
È qui che, per stessa ammissione di Kon, ha inizio il suo riflettere sulla fusione di realtà e illusione.
“(…) riguardo il tuo coinvolgimento in Memories invece?”
“Semplicemente avevo dei legami con Katsuhiro Otomo, dai tempi della mia collaborazione al manga Akira, e in seguito lui mi propose varie volte di lavorare assieme. Così quando cominciò la realizzazione di un lungometraggio d’animazione a episodi (quello che poi divenne Memories), la mia partecipazione fu naturale. In più, anche Koji Morimoto, regista di Kanojo no omoide (Magnetic Rose, il primo episodio di Memories, ndr), voleva a tutti i costi lavorare con me.
(…) Credo di poter anche affermare che il mio interesse per la tematica di fusione tra realtà e illusione abbia avuto qui la sua origine.” 1
Perfect Blue, il primo lungometraggio
Il 1997 è l’anno della prima regia con il lungometraggio OAV Perfect Blue, psycho-thriller prodotto dalla piccola Rex Entertainment con l’aiuto della Madhouse, inizialmente pensato come live action e poi convertito nel formato d’animazione con il coinvolgimento del nostro giovane regista.
Insieme a Sadayuki Murai, sceneggiatore di Boogiebop Phantom (Bûgîpoppu fantomu: Bûgîpoppu wa warawanai, Takashi Watanabe, 2000), Kon contribuisce anche alla sceneggiatura; si occupa inoltre del design dei personaggi, della direzione artistica e della supervisione dei layout. Qui, come sarà poi per il resto della sua carriera, la sua presenza come autore diventa totalizzante.
Perfect Blue narra di una giovane idol, Mima, che scopre a sue spese le difficoltà di un percorso di conversione della propria carriera a quella di attrice. Fin da questo primo film, Satoshi Kon è perfettamente consapevole delle potenzialità dell’animazione come mezzo espressivo dotato di regole proprie, che riesce ad utilizzare e adattare ai suoi intenti narrativi: il montaggio “frammentato”, in cui immagini della vita della protagonista si mescolano mostrandoci sequenze in cui lo spettatore perde la bussola spazio-temporale tra realtà e immaginazione, permette a Kon di esprimere al meglio la propria idea di narrazione.
Si configura un cortocircuito alimentato dalla capacità della telecamera d’animazione, con il suo occhio già avulso dal reale, di mettere in scena un flusso ininterrotto di momenti fra reale e immaginato, fra luoghi e tempi diversi, in cui è spesso difficile orientarsi. I temi che vengono affrontati, come la ricerca di chi siamo veramente, chi vorremmo essere o semplicemente apparire, possono così essere espressi al meglio.
Il film vince il Gran Prix al Fantasia Film Festival di Montreal, riscuotendo anche un buon successo di botteghino in patria, e costituisce il definitivo trampolino di lancio per Kon.
L’attrice millenaria
Con ormai la piena fiducia dello studio Madhouse, nel 1998 iniziano i lavori per il secondo lungometraggio del regista di Osaka: Chiyoko, Millenium Actress (Sennen joyu, nel mercato internazionale semplicemente Millenium Actress).
Lavorano alla realizzazione il produttore Masao Muruyama, alla sceneggiatura di nuovo Sadayuki Murai e alle musiche quello che poi diventa uno dei più importanti collaboratori di Satoshi Kon, Susumu Hirasawa.
Le fonti di ispirazione spaziano dalla leggenda giapponese Taketori Monogatari (la leggenda del tagliatore di bambù), all’intera filmografia del maestro Yasujiro Ozu; da Mattatoio n.5 di Vonnegut (soprattutto nella versione film del 1972 diretta da George Roy Hill) all’immaginifico Le avventure del barone di Münchausen di Terry Gilliam, regista ex Monty Phyton con il quale Kon ha, soprattutto nelle opere seguenti, molto in comune nella deformazione dei corpi e nella meccanicità dei loro movimenti.
Nell’apparentemente semplice plot, il motore degli eventi è un’intervista/documentario che l’ormai maturo regista Gen’ya Tachibana decide di produrre su Chiyoko, anziana attrice ex diva degli studios per cui lavora, ritiratasi a vita privata fuori dalle luci del mondo dello spettacolo. Ma c’è dell’altro: Tachibana deve consegnare una chiave che la grande attrice aveva perso anni addietro, un oggetto che restituito alla legittima proprietaria spalanca i cancelli della sua memoria.
Da qui ha origine una cavalcata di immagini in cui il regista e il suo aiuto macchina vengono catapultati a vivere in prima persona – e per noi – la vita di Chiyoko: l’amore impossibile per un pittore, le rivali, le delusioni, le difficoltà di carriera nel Giappone tradizionalista anni ’50, in cui il ruolo sociale della donna non prevedeva di certo il cinema.
Se in Perfect Blue Satoshi Kon aveva fatto coincidere e confondere la vita privata della protagonista con quella pubblica immaginata dai fan, in Millenium Actress sviluppa una sovrapposizione tra i diversi piani della vita di Chiyoko, i suoi film e la storia del Giappone.
È un cinema dagli imprescindibili connotati onirici, liminare all’opera di David Lynch. E a proposito di Millenium Actress, c’è stato pure chi, come Ed Gonzales (sul sito Slant Magazine), è arrivato a parlare di risposta anime di Kon a Mulholland Drive (Mulholland Drive, David Lynch, 2001).
Proprio come avviene nei sogni, ogni strappo di montaggio corrisponde a un vero e proprio strappo nella logica consecutio temporale (altro che décupage classico decantato da Andrè Bazin!), un brusco cambio scena foriero di rinnovato spiazzamento nei confronti di uno spettatore ogni volta impreparato, eppure necessariamente pronto a rimettersi in gioco in un battito di ciglia, assieme alle fallaci certezze precedentemente acquisite. 2
Non importa che lo spettatore riesca a distinguere la vita dai set dell’attrice: tutto è funzionale al racconto del motore che ha dato senso alla vita della protagonista, e quale miglior mezzo per raccontarla se non il cinema, che ci parla della realtà anche attraverso l’immaginato?
“Kon voleva che la ragazza cercasse l’uomo, e che l’intervistatore a sua volte inseguisse la ragazza”, commenta Murai: “Ciò che volevamo esprimere e l’idea che anche nel corso di mille anni, gli esseri umani continuano ad agire nello stesso modo, ci sarà sempre un altro uomo che cerca lei, e così via. Volevamo esplorare questo concetto attraverso la vita di una donna”.3
Tokyo Godfathers
Il terzo lungometraggio vede Kon distaccarsi dai temi thriller, drammatici e onirici delle precedenti opere per scegliere invece un genere che si potrebbe inquadrare in quello della commedia brillante, in cui trovano spazio anche momenti drammatici.
Fonti di ispirazione sono il romanzo di Peter B. Kyne, The Three Godfathers (1913) e la sua trasposizione cinematografica opera di John Ford, In nome di Dio, il texano (3 Godfathers, 1948), con l’aggiunta di atmosfere che ricordano il classico di Frank Capra “La vita è meravigliosa” (It’s a Wonderful Life, 1946).
Tre senzatetto si aggirano per le strade di Shinjuku durante la vigilia di Natale: Gin, burbero ex ciclista di mezz’età; Hana, un travestito che lavorava in un locale per omosessuali; infine Miyuki, una giovane ragazza scappata di casa. Il trio vedrà nel ritrovamento fortuito di una bambina tra la spazzatura il segno della possibilità di un personale riscatto, e deciderà di dedicarsi al ritrovamento della madre della piccola (chiamata nel frattempo Kyoko – bambina serena): è “l’innesco” di una serie di eventi, molti casuali, che vedranno i protagonisti scontrarsi coi loro fantasmi per fare i conti col proprio passato.
Quarta protagonista del racconto è la città di Tokyo, meticolosamente rappresentata nei suoi enormi palazzi: una città che come dice Kon protegge, pur con le sue contraddizioni da metropoli, i tre senzatetto.
“(…) Detesto quando la città viene antropomorfizzata in modo zuccheroso, ma non mi piace nemmeno dire che sia solo spietata e crudele. Credo che Tokyo sia soprattutto una città piatta e uniformata (…) È una situazione dinamica in cui da una parte ci sono zone dure e dall’altra zone di pace, ed è proprio il fatto che questi due poli, in un certo senso contraddittori, siano fortemente presenti che alla fine genera piattezza.”4
Come già accennato, si riscontra un cambiamento sia di tematiche sia nel modo di raccontarle rispetto ai film precedenti, ma è soprattutto l’atteggiamento dei protagonisti nei confronti della vicenda che risulta diverso:
“(…) Nelle mie due opere precedenti come prima cosa ponevo i personaggi nello scorrere degli eventi, e poi mostravo come ne venissero trascinati. Anche Chiyoko in Millenium Actress, nonostante sembri agire di volontà propria, non è che, come personalità, si faccia poi troppo avanti. In Tokyo Godfathers, invece, la situazione è quasi invertita, e lo scorrere degli eventi nasce proprio perché i personaggi sono fatti in un certo modo. Ho voluto puntare a uno sviluppo delle vicende che sarebbe stato impossibile senza questi determinati protagonisti.”5
Questo si avverte chiaramente nel fatto che il raggiungimento dell’obbiettivo per i tre sarà irto di ogni tipo di ostacolo, bivio, deviazione, tutti non previsti ma che permettono un’evoluzione nella storia di ognuno, che avrà il suo punto di arrivo nel “miracolo di Natale” finale.
Così come nelle opere precedenti, anche qui Kon si occupa di ogni aspetto della realizzazione: dal soggetto alla regia, passando per sceneggiatura (insieme a Keiko Nobumoto), design dei personaggi, storyboard, idee sulla colonna sonora. Un vero e proprio deus ex machina che ricorda, rimanendo in ambito cinematografico, il lavoro a tratti maniacale che Stanley Kubrick dedicava ai suoi film.
Se purtroppo questo grande regista ci ha lasciati troppo presto, possiamo quantomeno consolarci sapendo che la sua produzione è interamente espressione della sua arte.
Paprika
L’ultima opera si configura come un ritorno del regista dell’Hokkaido alle amate atmosfere oniriche che, da sempre connotanti la sua poetica, qui trovano un riscontro più concreto, in una trama che si sviluppa attorno a una macchina: la DC-Mini, in grado di far vivere e condividere i sogni a scopo terapeutico.
Prendendo spunto dal romanzo omonimo di Yasutaka Tsutsui, Kon imbastisce qui, come e più che in precedenza, una narrazione attraverso il reale e l’immaginario, il sognato e il vissuto, che si mescolano continuamente fin dai titoli di testa.
I personaggi rivelano il loro vero essere solo nella loro controparte onirica: il sogno, da ricordo annebbiato nella veglia, diventa esternazione della verità insita in ognuno di noi e si manifesta nel piano della realtà portando con sé tutte le implicazioni del caso: la lezione di Freud calata nel cinema d’animazione.
Esemplare in tal senso è la magnifica sfilata che riporta alla mente quella, ugualmente di grande impatto, di Ghost in the Shell: Innocence (Mamoru Oshii, Kōkaku Kidōtai Inosensu, 2004): un insieme caotico di animali, personaggi dell’immaginario collettivo, protagonisti della mitologia giapponese e oggetti pop, che si mescolano e si compenetrano in un incedere lento e approssimativo.
La sfilata è un qualcosa che mi sono inventato io stesso. È uno dei motivi [del film, nda] più importanti per me e non era presente nella storia originale. (…) È anche interessante dove stia andando la sfilata – straripa nella realtà. Comincia nel deserto, il punto più lontano dalla civilizzazione, continua attraverso la giungla e poi sopra un ponte per intrufolarsi alla fine nella realtà.
Con lo strabordare di questa sfilata onirica nel mondo reale (ma lo è veramente?), avviene una “compressione” delle due dimensioni che consente al regista di creare un flusso di immagini dalla forte componente immaginifica, che esalta una narrazione più legata all’ambito emotivo che razionale.
Questo film sarà purtroppo il testamento spirituale di Satoshi Kon, che a lavori già iniziati per il suo successivo progetto The Dream Machine (Yume Miru Kikai), morirà prematuramente per un cancro al pancreas all’età di 46 anni, lasciando un enorme vuoto nel mondo nel mondo dell’animazione e nel cinema in generale.
Nel corso degli anni la sua storica casa di produzione Madhouse cercherà più volte di riprendere in mano il soggetto, fino all’ammissione di rinuncia da parte dell’ex direttore Masao Maruyama in considerazione del fatto che, oltre che per problemi finanziari, solo Kon avrebbe potuto completare un simile progetto. Troppo grande evidentemente la sua autorialità, la sua importanza in ogni momento dell’ideazione, sviluppo e conclusione di un’opera scaturita da una sua idea.
Paranoia Agent
Nel 2004, temporalmente compresa tra Tokyo Godfathers e Paprika, esce per il canale WOWOW la serie Paranoia Agent (Mōsō dairinin), sempre prodotta da Madhouse. Il numero limitato di episodi (13), scelta in linea con le tendenze di quegli anni, risultava funzionale alla possibilità di coniugare un budget naturalmente più limitato con la necessità di maggior sperimentazione nei contenuti. Saranno infatti della stessa lunghezza serie come Serial Experiments Lain (Yasuyuki Ueda e Yoshitoshi ABe, 1998), Haibane Renmei (Yoshitoshi ABe, 2002) e Kino no tabi: the Beautiful World (Ryūtarō Nakamura, Sadayuki Murai, 2003); ma anche, più recentemente, le meritevoli opere di Masaaki Yuasa quali Kaiba, The Tatami Galaxy, Ping Pong The Animation e Devilman Crybaby.
Lo staff è di altissimo livello: dal direttore delle animazioni Masashi Ando, che già aveva lavorato con Hayao Miyazaki per La principessa Mononoke e La città incantata, alle sceneggiature di Seishi Minakami (Boogiepop Phantom, Littel Snowfairy Sugar e Alien 9), fino all’ormai inseparabile Susumu Hirasawa per le musiche, che il regista aveva considerato fin da Millenium Actress un punto di riferimento per la sua ispirazione:
“Ci sono persone nell’ambiente artistico che senti di poter chiamare “maestri”?”
“Nessuno in particolare. Ma nutro una stima speciale per Susumu Hirasawa, che si è occupato delle musiche di Millenium Actress. Ho imparato molto dalla musica e dal suo atteggiamento creativo, e molta parte dei miei attuali racconti e idee hanno un debito nei suoi confronti.”6
Abbiamo visto come la poetica di Kon sia tesa a suscitare una sorta di “flusso di coscienza” visivo nello spettatore, caratteristica che l’accomuna a David Lynch: quella voglia di portare lo spettatore a farsi prendere e perdersi nel fiume di emozioni evocate da montaggi e improvvisi cambi di registro, affinché la componente razionale del racconto ceda il passo a quella più emotiva e istintiva, senza tuttavia venir meno al contenuto. E non è forse la musica il media che più di ogni altro esprime questo dualismo? Ecco che l’amico e fidato compositore diviene punto di riferimento dell’opera; le musiche di Hirasawa riescono in effetti a cucirsi alla perfezione sulle espressioni del linguaggio visivo sullo schermo: la sigla di apertura “Dream island obsessional park” ne è forse l’esempio più calzante, e può considerarsi da sola il manifesto poetico dell’intera serie.
Siamo acusticamente colpiti da un ritmo martellante che presenta in sequenza tutti i protagonisti della serie, i quali figurano di fronte a sfondi di catastrofi o contesti incongrui sorridendo, come ignari degli eventi in cui sono immersi.
Ognuno di loro è la personificazione di una paranoia, di quei mali che la società crea e nutre senza riconoscerne la paternità, infondendo in chi ne è affetto psicosi di ogni genere. Nessuno riesce ad accettarsi per quello che è, perciò crea una visione falsa di sé rispetto ai desideri della società, o addirittura (nel terzo episodio, Double Lips – una martellata in testa può ferire) una seconda versione di sé, per riuscire a fuggire dall’opprimente quotidianità.
I protagonisti vengono caratterizzati nel pieno di una fragorosa, quasi grottesca risata, che dissimula e nasconde le loro ansie e paure. Sono per così dire “incastrati” nel loro ruolo all’interno della società (e quella giapponese in particolare è estremamente rigida nell’inquadrare gli obiettivi e il rigore con il quale raggiungerli); allora, invece che affrontare apertamente e risolvere i loro tormenti, li nascondono come personaggi di una recita.
Il fungo atomico accolto con le braccia alzate dal detective Ikari è il suggello più potente di questa carrellata di tragedie: perfetta sintesi della grandezza scientifica dell’uomo e della sua inclinazione all’errore, sembra quasi un caso che sia stato scelto anche da Lynch in quello che forse è l’episodio più riuscito della terza stagione di Twin Peaks, un instant classic. In realtà anche per il regista texano esso rappresenta un momento di svolta dell’umanità, in un altro racconto in cui i personaggi fanno i conti con i loro problemi per combattere una minaccia – l’incarnazione del male stesso, nato proprio dallo scoppio della prima bomba atomica – che sembra esterna, ma che come nella serie di Kon alberga in ogni essere umano. Sarà Shonen Bat, l’apparente “nemico” della serie, a svegliarli dal loro torpore con un ben assestato colpo di mazza da baseball, primo passo verso la propria liberazione.
Ulteriore elemento distintivo della narrazione di Kon nella serie è l’alternanza di diversi registri narrativi: thriller, fantasy, commedia e satira sono sapientemente accostati senza forzature, riuscendo a mantenere sempre alto il rimo della narrazione per mezzo di soluzioni registicamente sempre fresche e stimolanti.
Alla sua prima (e ultima – sic) regia di serie tv, Kon coglie le potenzialità di un linguaggio nuovo, distante dal lungometraggio, proponendo una narrazione in cui la divisione in puntate mette in scena un continuo slittamento dei personaggi, che da protagonisti dell’episodio loro dedicato divengono comprimari negli altri. Ne risulta una raffinata capacità di evocare la poliedricità dell’essere umano, protagonista con il proprio io più intimo della propria storia e mera comparsa, osservabile da inedite e multidirezionali prospettive, in quella degli altri. Come nei precedenti lungometraggi la compenetrazione di sogno e realtà permetteva più piani di lettura del racconto, la serialità consente ora al regista una continua variazione del punto di osservazione dello spettatore, ottenendo un affresco d’insieme più compiuto.
L’effetto finale risulta ancora più sbalorditivo se si tiene conto di come la serie nasca dal “riciclo” di vecchie idee per progetti diversi:
“(…) Le circostanze che mi hanno portato a realizzare una serie TV sono in realtà complicate. Fino a quel momento avevo realizzato tre lungometraggi, e per ognuno c’era stata una lotta e un’esclusione di molte idee. Avevo l’impressione che per fare un film dovessi scegliere dieci idee su cento, ma le altre novanta non erano soltanto cose stupide, c’erano anche idee valide, che avrei voluto usare se le circostanze me lo avessero permesso. (…) La prima ragione per una serie televisiva è quindi un tentativo di riciclare in qualche modo questo materiale.” 7
Ora che le serie televisive hanno raggiunto una “dignità” artistica pari a quella dei film non possiamo fare altro che celebrare Kon, rimpiangendo la perdita di un grande regista e apprezzando ancora una volta le sue opere.
E-Motion, numero 4, Aprile/Maggio 2003, pag. 46, IHT gruppo editoriale. ↩
Satoshi Kon, il cinema attraverso lo specchio, Alessia Spagnoli, cap. 2, pag. 76 ↩
E-Motion, numero 2, Dicembre/Gennaio 2003, pag. 42-43, IHT gruppo editoriale. ↩
E-Motion, numero 9, Aprile/Maggio 2004, pag. 47, IHT gruppo editoriale ↩
Ibidem, pag. 47-48 ↩
E-Motion, numero 4, Aprile/Maggio 2003, pag. 46, IHT gruppo editoriale ↩
E-Motion, numero 9, Aprile/Maggio 2004, pag. 49, IHT gruppo editoriale ↩